Zoologia: gli Invertebrati 7/ed.
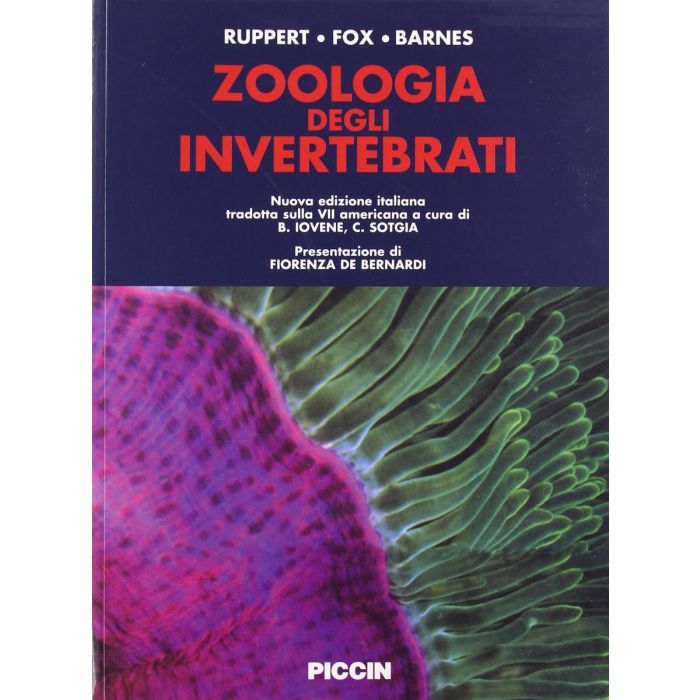
- ISBN/EAN
- 9788829918089
- Editore
- Piccin Editore
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2006
- Edizione
- 7
- Pagine
- 1120
Disponibile
80,00 €
La settima edizione di Zoologia degli Invertebrati è la prima edizione completamente rivisitata dell’opera classica originale, di cui fu autore lo scomparso Robert Barnes. Dalla pubblicazione della prima edizione risalente al 1963, gli studi sulla zoologia degli invertebrati sono progrediti per merito di una schiera di biologi dotati di grande ingegno e creatività. Molti di loro si sono accostati allo studio della zoologia degli invertebrati grazie al testo di Robert Barnes, altri hanno cooperato con l’autore stesso presso il Laboratorio Marino della Duke University, la Stazione Biologica di Ricerca alle Bermuda o al Gettysburg College. La ricerca di questi studiosi e di molti altri, condotta con l’ausilio di nuove tecniche e con metodi disciplinari innovativi, ha rivoluzionato la nostra conoscenza sugli invertebrati. Questa nuova edizione si arricchisce dei notevoli risultati emersi dalla ricerca moderna, di cui questi studiosi sono stati gli artefici.
La zoologia degli invertebrati è materia di studio destinata a chi è animato da una viva curiosità e da un amore profondo per le creature viventi in tutte le loro molteplici forme, e abbraccia, pertanto, lo studio della maggior parte degli animali, compresi i protisti, simili ad animali. Essa offre l’occasione di scoprire una stupefacente varietà di forme, dagli animali più comuni a quelli più bizzarri, dagli organismi microscopici a quelli giganteschi, dai più lenti ai più veloci. La zoologia degli invertebrati non è solo una delizia per la vista, con la immensa diversità che la contraddistingue, ma anche una sfida per la mente, perché stimola la ricerca di elementi comuni e unificanti in tutte le eterogenee forme da cui è popolata, la ricerca, cioè, della unità nella diversità. Nello studio degli invertebrati rientrano i principi basilari tratti da tutte le discipline biologiche, più propriamente, da tutte le discipline scientifiche, ma la zoologia degli invertebrati stessa racchiude un proprio principio, unico e fondamentale.
ELEMENTI DISTINTIVI DELLA SETTIMA EDIZIONE • Cinque nuovi capitoli introducono all’approccio funzionale-evoluzionistico, in base al quale le innovazioni di tipo evolutivo, comparse nella struttura e nella funzione degli organismi animali, costituiscono i caratteri fondamentali unificanti di tutta la diversità del mondo degli invertebrati. • Nuovi alberi evolutivi (cladogrammi), comprendenti i nomi dei taxa coinvolti e ricche descrizioni, chiariscono le relazioni evolutive. • 200 nuove raffigurazioni circa, insieme alle revisioni di diverse figure presenti nelle precedenti edizioni, contribuiscono a una maggiore chiarezza e illustrano le novità emerse dalla ricerca biologica più recente. • Un’ampia revisione del testo e un riordinamento dei capitoli riflettono l’andamento attuale della ricerca, comprese le recenti acquisizioni e le variazioni nella classificazione dei principali taxa. • Nuovi taxa recentemente istituiti, Cycliophora, Micrognathozoa, Tantulocarida e Myxozoa, sono inclusi nel testo e trattati in modo esauriente. • Una terminologia uniforme e standardizzata, con cui sono indicate le stesse strutture in taxa differenti, è stata adottata per evitare confusioni e sovrapposizioni. • Nuovi indirizzi Web commentati integrano il testo collegandolo a un gran numero di fonti, da cui possono essere tratte fotografie, animazioni, novità sulla ricerca e ulteriori dettagli praticamente su tutti i taxa esistenti. • Un nuovo sito Web, comprendente più di 300 foto originali a colori di invertebrati viventi e 300 figure chiave tratte dal testo, integra il testo e fornisce una ulteriore fonte per l’apprendimento. Nuovi capitoli introducono all’approccio funzionale-evoluzionistico Il concetto centrale e pregnante, che emerge dallo studio della zoologia degli invertebrati, è l’evoluzione delle strutture e delle funzioni degli organismi animali; questo concetto è la base e la guida per la ricostruzione delle relazioni evolutive e degli eventi che hanno determinato la comparsa di innovazioni di successo nelle strutture e nelle funzioni. Queste innovazioni costituiscono i piani strutturali fondamentali dei taxa animali: scopo di questa edizione è, fra gli altri, l’identificazione di questi piani fondamentali, la discussione delle funzioni ad essi connesse e la presentazione delle ipotesi più recenti sulla loro origine evolutiva, nel quadro di quello che viene definito l’approccio funzionale-evoluzionistico. Anche se in tutti i capitoli si possono trovare riferimenti e contenuti di tipo funzionale-evoluzionistico, questo testo comprende capitoli separati, dal titolo “Introduzione a …”, dedicati esclusivamente alla descrizione delle innovazioni chiave, come l’evoluzione delle cellule eucariotiche, della pluricellularità, la comparsa di epiteli, della simmetria bilaterale e di un esoscheletro impermeabile e di sostegno. Per fare qualche esempio, l’evoluzione degli eucarioti è stata accompagnata da un incremento delle dimensioni e della motilità cellulare, e dalla capacità di nutrirsi a spese dei progenitori procarioti (Capitolo 2, Introduzione ai Protozoa). L’acquisizione della pluricellularità ha determinato un ulteriore accrescimento delle dimensioni degli organismi, che, di conseguenza, poterono sfruttare i protozoi (e, quindi, i procarioti) come risorsa alimentare; la pluricellularità ha, inoltre, offerto vantaggi metabolici e di altro tipo rispetto ai protisti unicellulari (Capitolo 4, Introduzione ai Metazoa). La comparsa di epiteli ha permesso agli eumetazoi di compiere una regolazione fisiologica dei compartimenti interni extracellulari, come l’intestino e il celoma. Questa capacità di regolazione ha contribuito a migliorare l’efficacia della funzione digerente e di altre funzioni, ed ha, in una certa misura, affrancato gli eumetazoi dalla dipendenza dalla variabilità ambientale, permettendo loro di compiere attività sempre più complesse (Capitolo 6, Introduzione agli Eumetazoa). La comparsa della simmetria bilaterale negli eumetazoi ha condotto all’acquisizione di un corpo dotato di polarità direzionale e di organi di senso utili alla ricerca del cibo e di un compagno o alla fuga dagli avversari (Capitolo 9, Introduzione ai Bilateria). Gli artropodi, in particolare i 20 milioni e più di specie d’insetti, con le loro appendici mobili e gli esoscheletri di protezione e di supporto, hanno trovato le innovazioni chiave per la colonizzazione delle terre emerse e dell’aria (Capitolo 16, Introduzione agli Arthropoda). Particolare enfasi sulla scienza predittiva L’evoluzione delle strutture e delle funzioni degli orga-nismi animali rappresenta il concetto fondante di questo testo. Essa costituisce l’ossatura stessa della zoologia degli invertebrati e conferisce ad essa un altro valore e un nuovo significato, trasformandola da disciplina meramente descrittiva a scienza predittiva in continuo divenire. Ad esempio, disponendo di una semplice conoscenza della dimensione di un organismo e del suo livello di organizzazione, lo studente è in grado di prevedere se quell’organismo è dotato di un sistema circolatorio, escretore, respiratorio, di tessuti deputati alla locomozione e di alcuni aspetti della riproduzione, e come sono strutturati. Le poche ma inevitabili eccezioni sono un’occasione per lo studente di saggiare la bontà delle sue previsioni, di scoprire nuovi tipi di interazioni funzionali e di proporre nuovi modelli predittivi. Abbiamo osservato che questo approccio non solo rende più immediata la comprensione della diversità, organizzandola intorno a principi funzionali-evoluzionistici predittivi, ma è anche uno sprone per verificare la veridicità delle ipotesi formulate. Nuovi alberi filogenetici L’approccio funzionale-evoluzionistico poggia sulla fi-lo-genesi per il riconoscimento dei tratti fondamentali che caratterizzano ciascuna linea evolutiva principale. La settima edizione si basa sul metodo cladistico per la ricostruzione degli alberi filogenetici (cladogrammi); il Capitolo 1 (Introduzione agli Invertebrati) fornisce una introduzione semplificata al metodo cladistico, corredata da alcuni esercizi illustrati e commentati. In questo testo sono inclusi gli alberi filogenetici della maggior parte dei taxa principali, rappresentati in modo da risultare di facile lettura e comprensione, così da avvicinare gli studenti al loro studio ed analisi. I taxa terminali sono posti, come sempre, alle estremità dei rami, ma nei cladogrammi di questo testo sono menzionati anche gli adelphotaxa, posti a livelli paralleli all’interno degli alberi. Questo sistema convenzionale di rappresentazione permette un’immediata identificazione degli adelphotaxa, rafforzando l’obiettivo principale della cladistica: l’identificazione degli adelphotaxa e delle relazioni che li legano grazie al riconoscimento delle sinapomorfie. Gli alberi filogenetici inclusi in questo testo si basano su caratteri morfologici tradizionali e di recente identificazione, nonché sui dati molecolari. Nelle didascalie che accompagnano la rappresentazione dei cladogrammi sono inclusi i caratteri apomorfici corrispondenti a ciascun ramo, contrassegnati da un numero, e tutti i taxa sono identificati da un nome, in modo da fornire una descrizione sintetica – una sorta di guida allo studio – dei tratti principali che caratterizzano ciascun taxon. Nel caso in cui vi siano filogenesi contrastanti, ma di uguale validità, gli alberi corrispondenti comprendono e illustrano tutte le alternative. All’interno dei capitoli si trova, inoltre, una sezione dal titolo “Filogenesi di…”, in cui vengono discusse criticamente tutte le ipotesi filogenetiche principali, sia quelle che hanno ricevuto maggior consenso in passato che quelle più attuali. Si rammenti che tutte le filogenesi sono, in realtà, delle ipotesi, parte di un processo di scoperta in continuo divenire. Studenti e insegnanti dovranno essere pronti a modificare in maniera adeguata i cladogrammi rappresentati in questo testo, qualora emergessero nuovi fatti e nuove scoperte venissero divulgate. L’adozione e la diffusione del metodo cladistico hanno avuto come risultato la costruzione di classificazioni “naturali”, che rispecchiano le relazioni evolutive meglio di qualunque altro metodo filogenetico. Gli alberi filogenetici basati su sinapomorfie sono costituiti da adelphotaxa riuniti in coppie, spesso a livelli gerarchici, o ranghi, diversi. Questo tipo di alberi racchiude molteplici informazioni, ma spesso l’ordinamento dei taxa non coincide con le categorie linneane (regno, phylum, classe, ordine, e così via), tradizionalmente assegnate a quegli stessi taxa. Il numero complessivo dei ranghi gerarchici, inoltre, supera talvolta il numero delle relative categorie linneane. In parte proprio in virtù del gran numero di ranghi contemplati nelle filogenesi basate sul metodo cladistico, molti sistematici moderni evitano di assegnare a quei taxa le categorie linneane tradizionali. Come impone la pratica moderna, questa edizione di Zoologia degli Invertebrati tende a dare minore importanza all’attribuzione di categorie linneane ai taxa. La nostra personale esperienza dimostra che studenti e docenti apprezzano questo cambiamento. Per mantenere il legame con i relativi ranghi dei taxa, questo testo fornisce rappresentazioni di alberi filogenetici e una corrispondente classificazione in forma di tabella in una sezione del capitolo dal titolo “Gerarchia Filogenetica di …”. Per coloro i quali respingono questo sistema moderno, considerandolo in contrasto con gli insegnamenti ricevuti o con il proprio stile, abbiamo mantenuto i nomi abbreviati delle categorie linneane come indice superiore posto sui nomi dei taxa, e si possono trovare nelle sintesi iniziali del capitolo, nel titolo del capitolo e nelle sezioni “Diversità di…” all’interno dei capitoli. Standardizzazione della terminologia anatomica L’approccio funzionale-evoluzionistico implica necessariamente uno studio di tipo comparativo, e uno degli scopi di questo testo è stimolare sia il pensiero analitico dello studente che quello comparativo. Per rendere più immediato il confronto, in questa edizione molti termini anatomici sono stati standardizzati. Ad esempio, benché si tratti di strutture omologhe, gli organi escretori di filtrazione degli artropodi sono tradizionalmente descritti con nomi differenti nei diversi taxa. Pur menzionando questi nomi specializzati, in questo testo gli organi omologhi sono indicati con un unico nome, nefridio saccato. Analogamente, per dimostrare l’omologia delle cavità celomatiche di emicordati ed echinodermi, in questo testo usiamo i termini protocele, mesocele e metacele, tradizionalmente limitati agli emicordati, per riferirci alle cavità celomatiche embrionali e larvali degli echinodermi. Tali variazioni terminologiche, come pure alcuni termini di sostituzione coniati per chiarezza, sono stati adottati per aiutare gli studenti nell’apprendimento della zoologia degli invertebrati: ci auguriamo che gli specialisti siano comprensivi e accettino queste variazioni a scopo meramente didattico. In base alla nostra esperienza, sappiamo che gli studenti divenuti zoologi degli invertebrati hanno imparato e adottato senza alcuna difficoltà i termini classici, diffusi tra gli specialisti. Un nuovo sito Web con più di 600 immagini Gli invertebrati non sono solo animali curiosi e affasci-nanti: la maggior parte di essi sono dotati anche di straordinaria bellezza e di colori vivi e intensi, soprattutto ad un’osservazione dal vivo. Per molti studenti è proprio il primo contatto visivo con una lumaca, una stella di mare o con un calamaro vivo ad eccitare la loro curiosità e a trasformarla in un amore profondo per la zoologia degli invertebrati e, spesso, per la biologia in generale, destinato a durare per tutta la vita. Questa edizione permette al docente di accedere a un archivio in rete di circa 300 immagini originali a colori di invertebrati, soprattutto marini, osservati dal vivo, e di 300 figure di testo. Sia le foto che le immagini di testo possono essere condivise con gli studenti in vari modi. Il docente, ad esempio, può fornire agli studenti l’accesso per l’osservazione in rete o può scaricare le immagini e includerle nelle dispense per studenti o nelle presentazioni delle lezioni. Uno stimolo per la scoperta diretta La zoologia degli invertebrati rappresenta un territorio di frontiera per la scoperta, aperto a studenti e a scienziati competenti. L’obiettivo più ampio di questa nuova edizione di Zoologia degli Invertebrati è stimolare all’esplorazione di questo territorio di frontiera e fornire alcune indicazioni guida; ma si rammenti che la migliore fonte di scoperte sono gli animali stessi. Noi invitiamo i docenti, per quanto è loro possibile, a fare uso di invertebrati vivi nei loro laboratori didattici e a riunire studenti motivati in un corso estivo di zoologia degli invertebrati, organizzato presso un laboratorio marino. Questa interazione tra una mente curiosa e un organismo vivente è un fertile terreno di crescita per la scoperta. Abbiamo rilevato che la miscela di studenti motivati e di invertebrati viventi genera invariabilmente nuove osservazioni e nuove idee. Edward E. Ruppert Richard S. Fox
ELEMENTI DISTINTIVI DELLA SETTIMA EDIZIONE • Cinque nuovi capitoli introducono all’approccio funzionale-evoluzionistico, in base al quale le innovazioni di tipo evolutivo, comparse nella struttura e nella funzione degli organismi animali, costituiscono i caratteri fondamentali unificanti di tutta la diversità del mondo degli invertebrati. • Nuovi alberi evolutivi (cladogrammi), comprendenti i nomi dei taxa coinvolti e ricche descrizioni, chiariscono le relazioni evolutive. • 200 nuove raffigurazioni circa, insieme alle revisioni di diverse figure presenti nelle precedenti edizioni, contribuiscono a una maggiore chiarezza e illustrano le novità emerse dalla ricerca biologica più recente. • Un’ampia revisione del testo e un riordinamento dei capitoli riflettono l’andamento attuale della ricerca, comprese le recenti acquisizioni e le variazioni nella classificazione dei principali taxa. • Nuovi taxa recentemente istituiti, Cycliophora, Micrognathozoa, Tantulocarida e Myxozoa, sono inclusi nel testo e trattati in modo esauriente. • Una terminologia uniforme e standardizzata, con cui sono indicate le stesse strutture in taxa differenti, è stata adottata per evitare confusioni e sovrapposizioni. • Nuovi indirizzi Web commentati integrano il testo collegandolo a un gran numero di fonti, da cui possono essere tratte fotografie, animazioni, novità sulla ricerca e ulteriori dettagli praticamente su tutti i taxa esistenti. • Un nuovo sito Web, comprendente più di 300 foto originali a colori di invertebrati viventi e 300 figure chiave tratte dal testo, integra il testo e fornisce una ulteriore fonte per l’apprendimento. Nuovi capitoli introducono all’approccio funzionale-evoluzionistico Il concetto centrale e pregnante, che emerge dallo studio della zoologia degli invertebrati, è l’evoluzione delle strutture e delle funzioni degli organismi animali; questo concetto è la base e la guida per la ricostruzione delle relazioni evolutive e degli eventi che hanno determinato la comparsa di innovazioni di successo nelle strutture e nelle funzioni. Queste innovazioni costituiscono i piani strutturali fondamentali dei taxa animali: scopo di questa edizione è, fra gli altri, l’identificazione di questi piani fondamentali, la discussione delle funzioni ad essi connesse e la presentazione delle ipotesi più recenti sulla loro origine evolutiva, nel quadro di quello che viene definito l’approccio funzionale-evoluzionistico. Anche se in tutti i capitoli si possono trovare riferimenti e contenuti di tipo funzionale-evoluzionistico, questo testo comprende capitoli separati, dal titolo “Introduzione a …”, dedicati esclusivamente alla descrizione delle innovazioni chiave, come l’evoluzione delle cellule eucariotiche, della pluricellularità, la comparsa di epiteli, della simmetria bilaterale e di un esoscheletro impermeabile e di sostegno. Per fare qualche esempio, l’evoluzione degli eucarioti è stata accompagnata da un incremento delle dimensioni e della motilità cellulare, e dalla capacità di nutrirsi a spese dei progenitori procarioti (Capitolo 2, Introduzione ai Protozoa). L’acquisizione della pluricellularità ha determinato un ulteriore accrescimento delle dimensioni degli organismi, che, di conseguenza, poterono sfruttare i protozoi (e, quindi, i procarioti) come risorsa alimentare; la pluricellularità ha, inoltre, offerto vantaggi metabolici e di altro tipo rispetto ai protisti unicellulari (Capitolo 4, Introduzione ai Metazoa). La comparsa di epiteli ha permesso agli eumetazoi di compiere una regolazione fisiologica dei compartimenti interni extracellulari, come l’intestino e il celoma. Questa capacità di regolazione ha contribuito a migliorare l’efficacia della funzione digerente e di altre funzioni, ed ha, in una certa misura, affrancato gli eumetazoi dalla dipendenza dalla variabilità ambientale, permettendo loro di compiere attività sempre più complesse (Capitolo 6, Introduzione agli Eumetazoa). La comparsa della simmetria bilaterale negli eumetazoi ha condotto all’acquisizione di un corpo dotato di polarità direzionale e di organi di senso utili alla ricerca del cibo e di un compagno o alla fuga dagli avversari (Capitolo 9, Introduzione ai Bilateria). Gli artropodi, in particolare i 20 milioni e più di specie d’insetti, con le loro appendici mobili e gli esoscheletri di protezione e di supporto, hanno trovato le innovazioni chiave per la colonizzazione delle terre emerse e dell’aria (Capitolo 16, Introduzione agli Arthropoda). Particolare enfasi sulla scienza predittiva L’evoluzione delle strutture e delle funzioni degli orga-nismi animali rappresenta il concetto fondante di questo testo. Essa costituisce l’ossatura stessa della zoologia degli invertebrati e conferisce ad essa un altro valore e un nuovo significato, trasformandola da disciplina meramente descrittiva a scienza predittiva in continuo divenire. Ad esempio, disponendo di una semplice conoscenza della dimensione di un organismo e del suo livello di organizzazione, lo studente è in grado di prevedere se quell’organismo è dotato di un sistema circolatorio, escretore, respiratorio, di tessuti deputati alla locomozione e di alcuni aspetti della riproduzione, e come sono strutturati. Le poche ma inevitabili eccezioni sono un’occasione per lo studente di saggiare la bontà delle sue previsioni, di scoprire nuovi tipi di interazioni funzionali e di proporre nuovi modelli predittivi. Abbiamo osservato che questo approccio non solo rende più immediata la comprensione della diversità, organizzandola intorno a principi funzionali-evoluzionistici predittivi, ma è anche uno sprone per verificare la veridicità delle ipotesi formulate. Nuovi alberi filogenetici L’approccio funzionale-evoluzionistico poggia sulla fi-lo-genesi per il riconoscimento dei tratti fondamentali che caratterizzano ciascuna linea evolutiva principale. La settima edizione si basa sul metodo cladistico per la ricostruzione degli alberi filogenetici (cladogrammi); il Capitolo 1 (Introduzione agli Invertebrati) fornisce una introduzione semplificata al metodo cladistico, corredata da alcuni esercizi illustrati e commentati. In questo testo sono inclusi gli alberi filogenetici della maggior parte dei taxa principali, rappresentati in modo da risultare di facile lettura e comprensione, così da avvicinare gli studenti al loro studio ed analisi. I taxa terminali sono posti, come sempre, alle estremità dei rami, ma nei cladogrammi di questo testo sono menzionati anche gli adelphotaxa, posti a livelli paralleli all’interno degli alberi. Questo sistema convenzionale di rappresentazione permette un’immediata identificazione degli adelphotaxa, rafforzando l’obiettivo principale della cladistica: l’identificazione degli adelphotaxa e delle relazioni che li legano grazie al riconoscimento delle sinapomorfie. Gli alberi filogenetici inclusi in questo testo si basano su caratteri morfologici tradizionali e di recente identificazione, nonché sui dati molecolari. Nelle didascalie che accompagnano la rappresentazione dei cladogrammi sono inclusi i caratteri apomorfici corrispondenti a ciascun ramo, contrassegnati da un numero, e tutti i taxa sono identificati da un nome, in modo da fornire una descrizione sintetica – una sorta di guida allo studio – dei tratti principali che caratterizzano ciascun taxon. Nel caso in cui vi siano filogenesi contrastanti, ma di uguale validità, gli alberi corrispondenti comprendono e illustrano tutte le alternative. All’interno dei capitoli si trova, inoltre, una sezione dal titolo “Filogenesi di…”, in cui vengono discusse criticamente tutte le ipotesi filogenetiche principali, sia quelle che hanno ricevuto maggior consenso in passato che quelle più attuali. Si rammenti che tutte le filogenesi sono, in realtà, delle ipotesi, parte di un processo di scoperta in continuo divenire. Studenti e insegnanti dovranno essere pronti a modificare in maniera adeguata i cladogrammi rappresentati in questo testo, qualora emergessero nuovi fatti e nuove scoperte venissero divulgate. L’adozione e la diffusione del metodo cladistico hanno avuto come risultato la costruzione di classificazioni “naturali”, che rispecchiano le relazioni evolutive meglio di qualunque altro metodo filogenetico. Gli alberi filogenetici basati su sinapomorfie sono costituiti da adelphotaxa riuniti in coppie, spesso a livelli gerarchici, o ranghi, diversi. Questo tipo di alberi racchiude molteplici informazioni, ma spesso l’ordinamento dei taxa non coincide con le categorie linneane (regno, phylum, classe, ordine, e così via), tradizionalmente assegnate a quegli stessi taxa. Il numero complessivo dei ranghi gerarchici, inoltre, supera talvolta il numero delle relative categorie linneane. In parte proprio in virtù del gran numero di ranghi contemplati nelle filogenesi basate sul metodo cladistico, molti sistematici moderni evitano di assegnare a quei taxa le categorie linneane tradizionali. Come impone la pratica moderna, questa edizione di Zoologia degli Invertebrati tende a dare minore importanza all’attribuzione di categorie linneane ai taxa. La nostra personale esperienza dimostra che studenti e docenti apprezzano questo cambiamento. Per mantenere il legame con i relativi ranghi dei taxa, questo testo fornisce rappresentazioni di alberi filogenetici e una corrispondente classificazione in forma di tabella in una sezione del capitolo dal titolo “Gerarchia Filogenetica di …”. Per coloro i quali respingono questo sistema moderno, considerandolo in contrasto con gli insegnamenti ricevuti o con il proprio stile, abbiamo mantenuto i nomi abbreviati delle categorie linneane come indice superiore posto sui nomi dei taxa, e si possono trovare nelle sintesi iniziali del capitolo, nel titolo del capitolo e nelle sezioni “Diversità di…” all’interno dei capitoli. Standardizzazione della terminologia anatomica L’approccio funzionale-evoluzionistico implica necessariamente uno studio di tipo comparativo, e uno degli scopi di questo testo è stimolare sia il pensiero analitico dello studente che quello comparativo. Per rendere più immediato il confronto, in questa edizione molti termini anatomici sono stati standardizzati. Ad esempio, benché si tratti di strutture omologhe, gli organi escretori di filtrazione degli artropodi sono tradizionalmente descritti con nomi differenti nei diversi taxa. Pur menzionando questi nomi specializzati, in questo testo gli organi omologhi sono indicati con un unico nome, nefridio saccato. Analogamente, per dimostrare l’omologia delle cavità celomatiche di emicordati ed echinodermi, in questo testo usiamo i termini protocele, mesocele e metacele, tradizionalmente limitati agli emicordati, per riferirci alle cavità celomatiche embrionali e larvali degli echinodermi. Tali variazioni terminologiche, come pure alcuni termini di sostituzione coniati per chiarezza, sono stati adottati per aiutare gli studenti nell’apprendimento della zoologia degli invertebrati: ci auguriamo che gli specialisti siano comprensivi e accettino queste variazioni a scopo meramente didattico. In base alla nostra esperienza, sappiamo che gli studenti divenuti zoologi degli invertebrati hanno imparato e adottato senza alcuna difficoltà i termini classici, diffusi tra gli specialisti. Un nuovo sito Web con più di 600 immagini Gli invertebrati non sono solo animali curiosi e affasci-nanti: la maggior parte di essi sono dotati anche di straordinaria bellezza e di colori vivi e intensi, soprattutto ad un’osservazione dal vivo. Per molti studenti è proprio il primo contatto visivo con una lumaca, una stella di mare o con un calamaro vivo ad eccitare la loro curiosità e a trasformarla in un amore profondo per la zoologia degli invertebrati e, spesso, per la biologia in generale, destinato a durare per tutta la vita. Questa edizione permette al docente di accedere a un archivio in rete di circa 300 immagini originali a colori di invertebrati, soprattutto marini, osservati dal vivo, e di 300 figure di testo. Sia le foto che le immagini di testo possono essere condivise con gli studenti in vari modi. Il docente, ad esempio, può fornire agli studenti l’accesso per l’osservazione in rete o può scaricare le immagini e includerle nelle dispense per studenti o nelle presentazioni delle lezioni. Uno stimolo per la scoperta diretta La zoologia degli invertebrati rappresenta un territorio di frontiera per la scoperta, aperto a studenti e a scienziati competenti. L’obiettivo più ampio di questa nuova edizione di Zoologia degli Invertebrati è stimolare all’esplorazione di questo territorio di frontiera e fornire alcune indicazioni guida; ma si rammenti che la migliore fonte di scoperte sono gli animali stessi. Noi invitiamo i docenti, per quanto è loro possibile, a fare uso di invertebrati vivi nei loro laboratori didattici e a riunire studenti motivati in un corso estivo di zoologia degli invertebrati, organizzato presso un laboratorio marino. Questa interazione tra una mente curiosa e un organismo vivente è un fertile terreno di crescita per la scoperta. Abbiamo rilevato che la miscela di studenti motivati e di invertebrati viventi genera invariabilmente nuove osservazioni e nuove idee. Edward E. Ruppert Richard S. Fox
Maggiori Informazioni
| Autore | Ruppert Edward E.; Barnes Robert D.; Fox Richard S. |
|---|---|
| Editore | Piccin Editore |
| Anno | 2006 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | 1 INTRODUZIONE AGLI INVERTEBRATI
RICOSTRUZIONE DELLA FILOGENESI DEGLI INVERTEBRATI
Metodo cladistico
Ridimensionare l’importanza delle categorie linneane
UN ESERCIZIO DI CLADISTICA
2 INTRODUZIONE AI PROTOZOA
STRUTTURA DELLA CELLULA
EUCARIOTICA
Motilità cellulare
Assimilazione cellulare
Digestione endocellulare
Circolazione all’interno delle cellule18
Secrezioni cellulari
Comunicazione cellulare
Simbiosi tra le cellule
ORIGINE EVOLUTIVA DELLE CELLULE EUCARIOTICHE21
3 PROTOZOA
STRUTTURA E FUNZIONE
RIPRODUZIONE E CICLI VITALI
DIVERSITÀ DEI PROTOZOA
EuglenozoaP
ChlorophytaP
ChoanoflagellataP
RetortamonadaP e AssostylataP35
AlveolataP
Protozoa ameboidi
FILOGENESI DEI PROTOZOA
4 INTRODUZIONE AI METAZOA
PIANO STRUTTURALE FONDAMENTALE
Cellule, tessuti e strutture scheletriche
Riproduzione e sviluppo
CONSEGUENZE FUNZIONALI DELLA DIMENSIONE CORPOREA
Dimensione e compartimentazione
Dimensione, superficie e volume
Dimensione e trasporto
Dimensione e metabolismo<
Vantaggi derivanti da grandi dimensioni
ONTOGENESI E FILOGENESI - ORIGINI EVOLUTIVE
Origine dei Metazoa
Origine della polarità
e della specializzazione cellulare
Origine della complessità
BIBLIOGRAFIA
5 PORIFERA E PLACOZOA
PORIFERAP
Struttura
Parete del corpo
Pompaggio dell’acqua
Scheletro
Locomozione e tessuti dinamici
Compartimentazione fisiologica
Nutrizione
Trasporto interno, scambio gassoso
ed escrezione
Integrazione
Metaboliti bioattivi e associazioni biologiche
Bioerosione
Riproduzione
Diversità dei Porifera
Paleontologia e filogenesi dei Porifera
PLACOZOAP
6 INTRODUZIONE AGLI EUMETAZOA107
TESSUTO EPITELIALE
EPIDERMA, GASTRODERMA E INTESTINO
TESSUTO CONNETTIVO SCHELETRI
Scheletro idrostatico
Scheletro rigido
MOVIMENTO E DIMENSIONE
DEL CORPO112
CELLULE E TESSUTO MUSCOLARE
(MUSCOLATURA)
NEURONI E TESSUTO NERVOSO
(SISTEMA NERVOSO)114
CELLULE E ORGANI DI SENSO116
Struttura e funzione
Recettori di gravità
Fotorecettori e occhi
SVILUPPO
CRESCITA
7 CNIDARIAP
BIOLOGIA GENERALE
Struttura e simmetria degli individui solitari
Struttura degli individui coloniali
Scheletro
Muscolatura e movimento
Sistema nervoso
Cnidociti e cnidi
Cellule interstiziali
Celenteron: nutrizione e trasporto interno
Scambi gassosi ed escrezione
Riproduzione e sviluppo
ANTHOZOAC
Struttura a polipo
Muscolatura e sistema nervoso
Retrazione ed estensione
Nutrizione e trasporto interno
Scambi gassosi ed escrezione
Riproduzione e crescita
Diversità degli Anthozoa
Filogenesi degli Anthozoa
MEDUSOZOA
ScyphozoaC
HydrozoaC
FILOGENESI DEGLI CNIDARIA191
8 CTENOPHORAP - BIOLOGIA GENERALE
Parete del corpo e collociti
Muscolatura
Sistema nervoso
Locomozione
Celenteron
Cattura della preda, digestione, trasporto internp
Escrezione e regolazione del galleggiamento
Riproduzione e sviluppo
DIVERSITÀ DEGLI CTENOPHORA
FILOGENESI DEGLI CTENOPHORA
9 INTRODUZIONE AI BILATERIA214
SIMMETRIA BILATERALE – IMBATTERSI
NELLE RISORSE215
CEFALIZZAZIONE – OBIETTIVO
RISORSE217
Bilateria mobili
Bilateria sessili
MUSCOLATURA – CACCIA
ALLE RISORSE
TECNICHE D’INFOSSAMENTO220
COMPARTIMENTAZIONE – REGOLAZIONE
E SPECIALIZZAZIONE FISIOLOGICA221
Cnidaria
Bilateria
TRASPORTO INTERNO
Grandi Bilateria
Piccoli Bilateria
SCAMBI GASSOSI E PIGMENTI
RESPIRATORI
Grandi Bilateria
Piccoli Bilateria
ESCREZIONE
Generale
Grandi Bilateria
Piccoli Bilateria
RIPRODUZIONE E SVILUPPO
Riproduzione sessuale
Modelli di segmentazione e determinismo dello sviluppo
Gastrulazione
Segregazione del mesoderma
Destini del blastoporo
FILOGENESI DEI BILATERIA
Pareri unanimi e pareri contrastanti
Il progenitore: piccolo o grande?
10 PLATYHELMINTHESP,
ORTHONECTIDAP E DICYEMIDAP246
PLATYHELMINTHESP247
TurbellariaC248
Neodermata274
“MESOZOA”288
OrthonectidaP289
DicyemidaP289
Filogenesi di Orthonectida e DicyemidaP291
BIBLIOGRAFIA292
11 NEMERTEAP295
BIOLOGIA GENERALE296
Struttura296
Parete del corpo, locomozione
ed estensibilità297
Proboscide e rincocele298
Nutrizione e sistema digerente298
Scambi gassosi, trasporto interno
ed escrezione300
Sistema nervoso e organi di senso302
Riproduzione e sviluppo302
Piano funzionale dei Nemertea304
DIVERSITÀ DEI NEMERTEA305
FILOGENESI DEI NEMERTEA305
BIBLIOGRAFIA307
12 MOLLUSCAP308
MOLLUSCO GENERALIZZATO309
Mantello309
Conchiglia309
Cavità del mantello310
Branchie310
Osfradi312
Piede312
Nutrizione 312
Celoma314
Trasporto interno314
Escrezione315
Sistema nervoso e organi di senso315
Riproduzione316
Sviluppo317 APLACOPHORAC317 Struttura318 Diversità degli Aplacophora319 POLYPLACOPHORAC319 Mantello320 Conchiglia320< Piede e locomozione321 Cavità palleale e circolazione dell’acqua322 Nutrizione322 Trasporto interno323 Escrezione323 Sistema nervoso e organi di senso324 Riproduzione e sviluppo325 Diversità dei Polyplacophora325 MONOPLACOPHORAC325 GASTROPODAC328 Premessa alla sistematica dei Gasteropodi328 Origine ed evoluzione del piano strutturale dei gasteropodi329 Conchiglia339 Piede, locomozione e habitat343 Nutrizione e digestione346 Escrezione361 Trasporto interno362 Sistema Nervoso363 Organi di Senso363 Riproduzione365 Sviluppo369 Diversità ed evoluzione dei Gastropoda372 CEPHALOPODAC378 Forma378 Conchiglia379 Locomozione388 Diversificazione adattativa391 Nutrizione392 Scambi gassosi395 Trasporto interno396 Escrezione396 Sistema nervoso398 Organi di senso399 Tegumento e organi cromatici400 Riproduzione402 Sviluppo404 Diversità dei Cephalopoda404 Filogenesi dei Cephalopoda407 BIVALVIAC407 Struttura408 Mantello409 Conchiglia410 Piede412 Branchie e l’evoluzione delle modalità alimentari dei Bivalvi413 Nutrizione423 Radiazione adattativa dei Lamellibranchi425 Trasporto interno440 Scambi gassosi440 Escrezione441 Sistema nervoso441 Organi di Senso441 Riproduzione443 Sviluppo443 Diversità dei Bivalvia445 Filogenesi dei Bivalvia447 SCAPHOPODAC449 Struttura449 Mantello e cavità palleale450 Conchiglia450 Nutrizione451 Trasporto interno451 Escrezione451 Sistema nervoso e organi di senso452 Riproduzione e sviluppo453 Diversità degli Scaphopoda453 Filogenesi degli Scaphopoda453 FILOGENESI DEI MOLLUSCA453 Piano strutturale fondamentale dei molluschi453 Origine dei Mollusca454 Evoluzione all’interno dei Mollusca454 13 ANNELIDAP459 STRUTTURA E FUNZIONE460 Segmentazione460 Parete del corpo461 Sistema nervoso463 Celoma e sistema emale465 Sistema escretore465 Sistema digerente466 Riproduzione e sviluppo466 DIVERSITÀ DEGLI ANNELIDA466 FILOGENESI DEGLI ANNELIDA466 EVOLUZIONE E SIGNIFICATO DELLA SEGMENTAZIONE467 POLYCHAETAC469 Struttura e funzione469 Parete del corpo e tubi471 Muscolatura e locomozione471 Sistema nervoso e organi di senso473 Sistema digerente475 Nutrizione476 Scambi gassosi477 Trasporto interno478 Escrezione482 Riproduzione482 Diversità dei Polychaeta489 Filogenesi dei Polychaeta508 CLITELLATA509 OligochaetaC509 HirudinomorphaC522 Filogenesi dei Clitellata535 BIBLIOGRAFIA536 14 ECHIURAP E SIPUNCULAP541 ECHIURAP542 Struttura e funzione542 Riproduzione e sviluppo546 Diversità degli Echiura546 Filogenesi degli Echiura547 SIPUNCULAP548 Struttura e funzione548 Riproduzione e sviluppo552 Diversità dei Sipuncula553 Filogenesi dei Sipuncula553 15 ONYCHOPHORAP E TARDIGRADAP557 PANARTHROPODASP558 ONYCHOPHORAP558 Struttura559 Parete del corpo e locomozione560 Nutrizione560 Trasporto interno, scambi gassosi ed escrezione561 Sistema nervoso e organi di senso562 Riproduzione e sviluppo562 Diversità degli Onychophora563 Filogenesi degli Onychophora563 TARDIGRADAP564 Struttura565 Parete del corpo565 Muscolatura e locomozione566 Scambi gassosi ed escrezione568 Sistema nervoso e organi di senso568 Riproduzione e sviluppo569 Diversità dei Tardigrada570 Filogenesi dei Tardigrada570 16 INTRODUZIONE AGLI ARTHROPODA572 STRUTTURA573 Segmentazione573 Tagmosi575 Cefalizzazione575 Appendici segmentali575 PARETE DEL CORPO577 Ciglia e flagelli577 Esoscheletro577 MUSCOLATURA E MOVIMENTO582 Morfologia funzionale582 Fisiologia583 CELOMA E MESODERMA584 TRASPORTO INTERNO584 ESCREZIONE586 SCAMBI GASSOSI588 NUTRIZIONE588 SISTEMA NERVOSO589 ORGANI DI SENSO591 Esorecettori591 Endorecettori596 RIPRODUZIONE597 SVILUPPO597 FILOGENESI DEGLI ARTHROPODA598 17 TRILOBITOMORPHAsP602 STRUTTURA603 SVILUPPO607 ECOLOGIA608 DIVERSITÀ DEI TRILOBITOMORPHA610 FILOGENESI DEI TRILOBITOMORPHA612 18 CHELICERATAsP614 STRUTTURA615 XIPHOSURAC615 Struttura615 Nutrizione617 Trasporto interno617 Scambi gassosi617 Escrezione618 Sistema nervoso e organi di senso619 Riproduzione e sviluppo619 ARACHNIDAC620 Struttura621 Nutrizione621 Scambi gassosi622 Trasporto interno623 Escrezione623 Sistema nervoso e organi di senso623 Riproduzione e sviluppo626 EurypteridaO626 ScorpionesO627 UropygiO632 AmblypygiO633 AraneaeO634 PalpigradiO64 PseudoscorpionesO649 SolifugaeO651 OpilionesO654 RicinuleiO655 AcariO656 Filogenesi degli Arachnida661 PYCNOGONIDAC664 Struttura664 Struttura e funzioni interne665 FILOGENESI DEI CHELICERATA667 19 CRUSTACEAsP671 Biologia generale672 Struttura672 Nutrizione674 Trasporto interno678 Scambi gassosi678 Escrezione679 Sistema nervoso e organi di senso679 Riproduzione681 Sviluppo681 REMIPEDIAC682 CEPHALOCARIDAC683 ANOSTRACAC685 PHYLLOPODAC686 Locomozione687 Nutrizione688 Scambi gassosi, trasporto interno ed escrezione689 Riproduzione e sviluppo689 Notostracao691 Laevicaudatao e Spinicaudatao691 Cladoceraso692 Filogenesi dei Phyllopoda693 MALACOSTRACAC694 Leptostracao695 Stomatopodao696 Decapodao697 Syncaridaso723 Euphausiaceao723 Pancaridaso725 Peracaridaso72 Filogenesi dei Malacostraca743 MAXILLOPODASC745 Copepodac745< Mystacocaridac75 Tantulocaridac752 Ascothoracidac753 Cirripediac756 Ostracodac766 Branchiurac769 Pentastomidac770 Filogenesi dei Maxillopoda772 FILOGENESI DEI CRUSTACEA774 20 MYRIAPODASC781 TRACHEATAiP E MYRIAPODASC782 ChilopodaC782 SymphylaC790 DiplopodaC791 PauropodaC798 FILOGENESI DEI TRACHEATA800 21 HEXAPODASC804 BIOLOGIA GENERALE805 Struttura805 Ali e volo807 Nutrizione809< Trasporto interno815 Scambi gassosi817 Escrezione817 Sistema nervoso818 Organi di senso818 Riproduzione819 Sviluppo821 ECOLOGIA824 Coevoluzione824 Parassitismo825 Parassitoidismo826 Comunicazione827 Insetti sociali827 DIVERSITÀ DEGLI HEXAPODA830 22 CYCLONEURALIASP838 GASTROTRICHAP839 Diversità dei Gastrotricha843 NEMATODAP844 Struttura845 Parete del corpo846 Sistema nervoso e organi di senso848 Locomozione848 Nutrizione850 Escrezione851 Riproduzione e sviluppo853 Parassitismo855 Diversità dei Nematoda858 NEMATOMORPHAP859 Diversità dei Nematomorpha861 PRIAPULIDAP861 Diversità dei Priapulida865 LORICIFERAP866 Diversità dei Loricifera868 KINORHYNCHAP868< Diversità dei Kinorhyncha870 FILOGENESI DEI CYCLONEURALIA870 23 GNATHIFERASP874 GNATHOSTOMULIDAP875 Diversità degli Gnathostomulida877 MICROGNATHOZOA877 SYNDERMATA879< RotiferaP879 SeisonidaC892 AcanthocephalaP893 FILOGENESI DEGLI GNATHIFERA898 24 KAMPTOZOAP E CYCLIOPHORAP90 KAMPTOZOAP901 Struttura902 Struttura e funzioni interne903 Filogenesi dei Kamptozoa905 Diversità dei Kamptozoa905 CYCLIOPHORAP906 Struttura906 Riproduzione e cicli vitali907 Ecologia909 Filogenesi dei Cycliophora909 25 LOPHOPHORATASP910 PHORONIDAP911 BRACHIOPODAP916 Struttura919 Lofoforo e alimentazione921 Struttura e funzioni interne922 Riproduzione e sviluppo923 Diversità dei Brachiopoda924 BRYOZOAP924 Struttura926 Forme coloniali928 Polimorfismo degli zoidi930 Pori di comunicazione tra gli zoidi932 Sistema del funicolo933 Muscolatura934 Nutrizione934 Scambi gassosi, trasporto interno, sistema nervoso937 Escrezione937 Riproduzione e sviluppo937 Diversità dei Bryozoa943< Filogenesi dei Bryozoa944 FILOGENESI DEI LOPHOPHORATA944 26 CHAETOGNATHAP948 STRUTTURA E FUNZIONE949 RIPRODUZIONE E SVILUPPO954 FILOGENESI DEI CHAETOGNATHA955 27 INTRODUZIONE AI DEUTEROSTOMIA E AGLI HEMICHORDATAP957 ENTEROPNEUSTAC958 Struttura959 Celomi, muscolatura e locomozione959 Scheletro960 Sistema digerente e nutrizione961 Scambi gassosi962 Trasporto interno ed escrezione962 Sistema nervoso965 Riproduzione e sviluppo965 PTEROBRANCHIAC965 Struttura e funzioni dello zoide966 Struttura e locomozione della colonia967 Parete del corpo e struttura interna968 Sistema digerente e nutrizione968 Riproduzione e sviluppo969 FILOGENESI DI HEMICHORDATA E DEUTEROSTOMIA970 28 ECHINODERMATAP973 BIOLOGIA GENERALE974 ORIGINE ONTOGENETICA DELLA SIMMETRIA PENTAMERA975 ELEUTHEROZOA977 AsteroideaC977 Cryptosyringida993 CRINOIDEAC1025 Struttura1025 Parete del corpo1027 Muscolatura e locomozione1028 Sistema digerente e nutrizione1029 Sistema acquifero e trasporto interno1030 Scambi gassosi ed escrezione1031 Sistema nervoso1031 Riproduzione1031 Sviluppo1031 Diversità dei Crinoidea1033 PALEONTOLOGIA E FILOGENESI DEGLI ECHINODERMATA1033 29 CHORDATAP1039 PIANO STRUTTURALE FONDAMENTALE DEI CHORDATAP1040 CEPHALOCHORDATAsP1041 Struttura e locomozione1042 Sistema nervoso e organi di senso1042 Muscolatura e notocorda1044 Celoma1045 Sistema digerente e nutrizione1046 Sistema emale e trasporto interno1047 Escrezione1048 Riproduzione e sviluppo1048 Diversità dei Cephalochordata1050 TUNICATAsP (UROCHORDATA)1050 AscidiaceaC1051 ThaliaceaC1064 AppendiculariaC1067 FILOGENESI DEI CHORDATA1069 BIBLIOGRAFIA1073 |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
