Biologia Microbiologia Biotecnologie - Vol. 1 [Tinti - Piccin Editore]
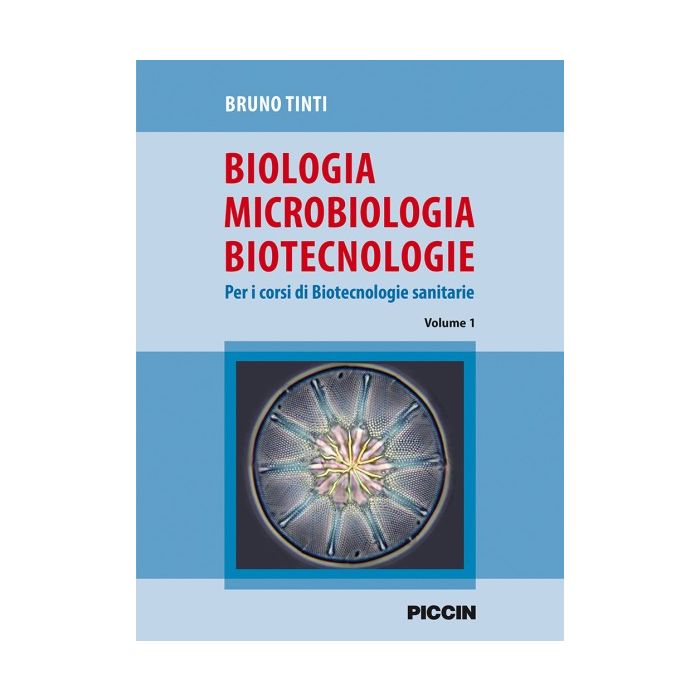
- ISBN/EAN
- 9788829927678
- Editore
- Piccin Editore
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2017
- Pagine
- 494
Disponibile
25,00 €
VOLUME 1
Le basi della biologia
Il laboratorio di biologia-microbiologia
La crescita microbica
Bioenergetica e metabolismo
Riproduzione ed ereditarietà
I microrganismi eucariotici
Tassonomia ed identifi cazione dei procarioti
Prefazione
La biologia (dal greco bìos = vita e lògos = discorso) è la scienza che studia tutto ciò che ri guarda la vita; studia, pertanto, le caratteristiche strutturali, funzionali e comportamentali degli organismi, oltre che la loro classificazione.
La scuola greca fu la prima a studiare i fenomeni naturali con due indirizzi diversi:
un indirizzo filosofico che mirava a scoprire le leggi della natura;
un indirizzo medico che studiava l’anatomia e la fisiologia.
Aristotele fu il primo a separare lo studio dei vi venti da quello della medicina. Fu in grado di ordinare più di 500 specie di animali in classi, nelle quali incluse anche l’uomo. Distinse gli animali con sangue da quelli senza sangue; divise gli animali con sangue in: pesci, animali terrestri che deponevano uova, uccelli e mammiferi.
Distinse, inoltre, i cetacei dai pesci.
Gli studi biologici furono scarsamente impor tanti nel periodo romano. Una figura di rilievo di questo periodo è rappresentata da Galeno, il me dico dei gladiatori, che dimostrò una notevole co noscenza del corpo umano.
Alla caduta dell’Impero Romano gli studi scientifici si spostarono nel mondo orientale; da personaggi del mondo arabo sorse la Scuola Medica Salernitana, la più importante istituzione medica del Medioevo.
Lo studio dell’anatomia umana fece notevoli progressi nel periodo rinascimentale con Leo nardo da Vinci (1452-1519); di lui restano impor tanti testimonianze degli studi anatomici eseguiti con grande cura sui cadaveri. Un’altra figura di ri lievo di questo periodo è rappresentata da Andrea Vesalio (Andreas van Wesel, 1514-1564) medico e anatomista fiammingo che deve essere conside rato il fondatore della moderna anatomia.
Di rilievo una sua pubblicazione (“De humani corporis fabrica”) basata su studi anatomici da lui stesso eseguiti.
Come tutte le altre scienze, quelle biologiche furono influenzate in modo decisivo dall’opera di Galileo Galilei (1564-1642), che evidenziò la ne cessità di giungere per qualsiasi attività scientifica a “sensate esperienze” insieme alla formulazione delle ipotesi.
Nel diciassettesimo secolo William Harvey dimostrò che nel corpo umano il sangue circolava continuamente.
Cartesio (René Descartes, 1596-1650) sostenne che il corpo umano funzionava come una macchina basata su leve e che ogni singola funzione potesse essere spiegata in modo meccanico. Georg Ernst Stahl (1660-1734) si contrappose in modo netto a Cartesio; affermò che le parti che compongono l’uomo sono indivisi bili e irriproducibili perché tenute insieme da un’anima e le funzioni vitali ubbidiscono a leggi diverse da quelle fisiche.
In questo stesso secolo Antony van Leeuwenhoek (1632-1723), impiegando microscopi dotati di una sola lente, da lui stesso costruiti, eseguì osservazioni su numerosi campioni che gli consentirono di scoprire l’esistenza di minuscoli organismi (batteri, protozoi, lieviti, ecc.). Con l’impiego del microscopio composto, Robert Hooke (1635-1703) studiò invece le cellule.
La sistematica fece notevoli progressi con l’opera di Linneo (Carl Nilsson Linnaeus, 1707-1778) che giunse alla classificazione dei viventi, mediante la creazione di un ordine gerarchico e l’impiego della nomenclatura binomiale.
Nel secolo diciannovesimo da Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1902) fu formulata la teoria cellulare, secondo cui gli organismi viventi sono costituiti da elementi cellulari ed ogni cellula de riva da una cellula preesistente. In questo secolo, anche grazie alla messa a punto di microscopi più potenti, si sviluppò lo studio dei microrganismi.
Nel secolo ventesimo gli studi biologici sono stati caratterizzati, in particolare, dal grande sviluppo delle conoscenze genetiche e molecolari, che hanno radicalmente cambiato il modo con cui eseguire le ricerche.
La moderna biologia è diretta conseguenza di questo tipo di approccio.
La nascita e lo sviluppo della microbiologia hanno preso origine dagli studi di Louis Pasteur (1822-1895) e Robert Koch (1843-1910), che si sono avvicinati ai microrganismi in quanto responsabili di malattie negli organismi superiori. In seguito i progressi sono stati innumerevoli ed il li vello delle conoscenze sempre più approfondito. Per la loro semplicità organizzativa, i batteri sono di venuti un modello di studio per tutta la ricerca biologica, tanto che le conoscenze acquisite sui procarioti sono state fonda mentali per la comprensione dei processi biologici presenti anche negli organismi più evoluti.
I microrganismi sono rappresentati da innumerevoli specie, distinguibili dal punto di vista morfologico, strutturale, metabolico, antigene, ecc.; spesso interagiscono con altri organismi viventi ed hanno un ruolo fondamentale nell’economia della biosfera, alcuni di essi partecipano attivamente alla sintesi della sostanza organica, altri alla de composizione della stessa, grazie alla notevole capacità degradativa che li caratterizza.
Nel corso degli studi i ricercatori si sono resi conto rapidamente del coinvolgimento dei microrganismi in diversi processi utilizzati dall’uomo da tempo immemorabile, come la produzione del vino, della birra, del pane, dello yogurt, dei formaggi. La possibilità di controllare tali processi ha aperto la strada alle moderne microbiotecnologie, vale a dire ad applicazioni finalizzate alla produzione di una grande varietà di beni e servizi.
Dagli anni ’70 in poi lo sviluppo delle tecniche di ricombinazione del DNA ha per messo di mettere a punto strategie dalle enormi possibilità applicative. In laboratorio geni molto lontani dal punto di vista evolutivo possono essere ricombinati permettendo processi del tutto inattuabili in natura. Siamo solo all’inizio di questo itinerario, ma, oltre alle grandi potenzialità, si possono in travedere anche impor tanti problematiche, per l’uomo e per la natura nel suo complesso, che devono rendere attente le di versi Istituzioni nazionali ed internazionali nella regolamentazione e nel controllo dei processi biotecnologici.
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Con la recente riforma della scuola secondaria superiore, ai corsi biologici e biologico-sanitari inseriti nel precedente ordinamento, sono subentrati i corsi biotecnologici ambientali e biotecnologici sanitari. Naturalmente la revisione dei corsi è stata accompagnata anche da una profonda revisione degli ambiti disciplinari. In particolare nel triennio dei corsi biotecnologici sanitari è stata introdotta una disciplina denominata “Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo sanitario”, mentre nei corsi biotecnologici ambientali è stata introdotta la “Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo ambientale”; entrambe le discipline prevedono la trattazione di una complessa serie di argomenti di cui, talora, risulta difficile trovare un filo conduttore. Pertanto il mio lavoro è stato attento a cercare di armonizzare tutto quanto doveva essere trattato, attraverso un itinerario che potesse essere il più organico possibile. In particolare il testo intende essere un supporto per l’insegnamento della “Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo sanitario”, una disciplina che concorre a far con seguire allo studente, al termine del per corso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 1. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 2. acquisire le competenze sull’uso di strumenti tecnologici finalizzato al miglioramento della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 3. saper intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, utilizzando al meglio gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo.
OBIETTIVI DEL TESTO
L’obiettivo fondamentale del testo è quello di fornire agli studenti strumenti teorico-pratici necessari a giungere alla comprensione del mondo biologico e microbiologico e delle tecniche alla base dei processi biotecnologici, ormai largamente impiegati nelle produzioni industriali ed agrarie. Alcuni contenuti presenti nel testo appaiono strettamente interconnessi a quelli di altri insegnamenti, come la Biochimica, la Biologia molecolare (ad es. bioenergetica e metabolismo microbico, genetica dei procarioti, ricombinazione del DNA), la Storia (ad es. aspetti storici connessi all’evoluzione della microbiologia), la Fisica (ad es. spettro elettromagnetico e lenti). Tutto questo per offrire una visione meno settoriale e permettere agli studenti di acquisire una conoscenza organica del mondo biologico e delle sue possibilità applicative nell’ambito dei processi produttivi attuali.
REALIZZAZIONE
Vista la complessa articolazione degli argomenti inseriti nell’ambito della disciplina, la realizzazione del testo ha necessariamente richiesto una lunga fase di ricerca bibliografica ed iconografica. Una significativa parte del presente testo, vale a dire la parte microbiologica, è derivata dalla revisione del precedente testo di microbiologia; di questo è stata rivista anche la parte iconografica per meglio armonizzare il rapporto tra contenuti ed immagini, cercando di rendere l’opera più accattivante possibile. Ho cercato di porre particolare attenzione alle illustrazioni inserendo, ove necessario, disegni e grafici, che potessero facilitare la comprensione dei contenuti proposti.
Le immagini all’M.O. sono state ottenute in parte utilizzando l’archivio della Casa Editrice Piccin Nuova Libraria, in parte direttamente presso il Laboratorio di Microscopia dell’ISTVAS di Ancona impiegando Microscopio Leica Laborlux in campo chiaro ed in contrasto di fase con fotocamera Leica EMC3. Una parte delle immagini all’M.O. sono state ottenute impiegando microscopio Zeiss Universal in campo chiaro, contrasto di fase e contrasto interferenziale con fotocamera Canon EOS 1000.
Una parte significativa delle immagini è tratta dal sito del Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention, USA.
Maggiori Informazioni
| Autore | Tinti Bruno |
|---|---|
| Editore | Piccin Editore |
| Anno | 2017 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | PARTE I LE BASI DELLA BIOLOGIA 1 Il mondo biologico . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1 Campi d’azione della biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.1 Relazioni tra i sistemi biologici . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Strutture e organizzazioni biologiche . . . . . . . . . . . . 4 1.2.1 Cellule e strutture acellulari . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.2 Dimensioni e morfologia delle strutture biologiche . . .. . . . 5 1.2.3 Organizzazioni pluricellulari . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Classificazione dei viventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3.1 Classificazione fenotipica di Whittaker . . . . . 7 1.3.2 Classificazione molecolare di Woese . . . . . . . 9 1.3.3 Posizione e ruolo degli acellulari nel mondo vivente . . . . . 9 1.4 Classificazione biologica e nomenclatura . . . . . . .10 1.5 Settori di studio della biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 2 Le molecole alla base della vita . . . . . . 13 2.1 L’acqua e le sue proprietà chimico-fisiche . . . . . . .13 2.2 Ionizzazione dell’acqua e dei soluti . . . . . . . . . . . . .16 2.2.1 Processi biochimici in cui è coinvolta l’acqua . .. . . .16 2.3 Elementi alla base della vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 2.3.1 Caratteristiche atomiche del carbonio . . . .18 2.3.2 Legami chimici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 2.3.3 Reazioni chimiche cellulari . . . . . . . . . . . . . . .19 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 3 Le biomolecole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.1 Carboidrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 3.1.1 Monosaccaridi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 3.1.2 Derivati monosaccaridici . . . . . . . . . . . . . . . . .24 3.1.3 Legame glicosidico e formazione dei disaccaridi .. . .25 3.1.4 Polisaccaridi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 3.1.5 Glicoproteine e glicolipidi . . . . . . . . . . . . . . . .27 3.2 Proteine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 3.2.1 Amminoacidi della serie L e D . . . . . . . . . . . .28 3.2.2 Classificazione degli amminoacidi . . . . . . . .28 3.2.3 Il legame peptidico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 3.2.4 Polimeri degli amminoacidi . . . . . . . . . . . . . . .30 3.2.5 Classificazione delle proteine . . . . . . . . . . . . .30 3.2.6 Struttura delle proteine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 3.3 Lipidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 3.3.1 Lipidi semplici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 3.3.2 Lipidi complessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 3.4 Nucleotidi ed acidi nucleici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 3.4.1 Nucleosidi e nucleotidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 3.4.2 Struttura del DNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 3.4.3 Struttura degli RNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 3.4.4 Altre funzioni dei nucleotidi . . . . . . . . . . . . . .40 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 4 La cellula eucariotica . . . . . . . . . . . . . . 43 4.1 Evoluzione delle cellule procariotiche . . . . . . . . . .43 4.2 Caratteri delle cellule eucariotiche . . . . . . . . . . . . .43 4.2.1 Composizione chimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 4.2.2 Compartimentazione della cellula eucariotica . . . . . . . .45 4.3 Struttura delle cellule eucariotiche . . . . . . . . . . . . .45 4.3.1 Membrana plasmatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 4.3.2 Citoplasma ed organuli citoplasmatici . . . .48 4.3.3 Membrana nucleare e nucleo . . . . . . . . . . . .53 4.3.4 Parete cellulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 5 La cellula procariotica . . . . . . . . . . . . . 57 5.1 Morfologia della cellula procariotica . . . . . . . . . . . .57 5.1.1 Dimensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 5.1.2 Morfologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 5.1.3 Composizione chimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 5.2 Struttura della cellula procariotica . . . . . . . . . . . . . .59 5.2.1 Parete cellulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 5.2.2 Membrana plasmatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 5.2.3 Area citoplasmatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 5.2.4 Area nucleare (nucleoide) . . . . . . . . . . . . . . . .64 5.2.5 Flagelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 5.2.6 Capsula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 5.2.7 Fimbrie (pili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 5.2.8 Spore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 PARTE II IL LABORATORIO DI BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA 6 Organizzazione e sicurezza nel laboratorio di biologia-microbiologia . . 75 6.1 Organizzazione del laboratorio di biologiamicrobiologia .. . . .75 6.1.1 Strumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 6.2 Sicurezza nel laboratorio di biologiamicrobiologia . . . .81 6.3 Fattori di rischio nel laboratorio di biologiamicrobiologia .. . .81 6.4 Rischio biologico nel laboratorio di biologiamicrobiologia . . . . .83 6.5 Classificazione degli agenti biologici . . . . . . . . . . .83 6.6 Sicurezza nel laboratorio di biologiamicrobiologia di base . . . . .84 6.6.1 Caratteristiche degli spazi e dotazioni . . . . .84 6.6.2 Misure di protezione e procedure . . . . . . . . .84 6.6.3 Cappe di sicurezza biologica . . . . . . . . . . . . . .87 6.7 Procedure da seguire nel caso di sversamento o di esposizione al materiale biologico . . . . . . . . . .88 6.7.1 Sversamento di materiale infetto . . . . . . . . .88 6.7.2 Esposizione al materiale biologico . . . . . . . .88 6.7.3 Rottura di provette o di altri contenitori all’interno di centrifughe . . . .89 6.8 Gestione dei rifiuti chimici e biologici in laboratorio . . . . . . . . . . .89 6.8.1 Trattamento dei rifiuti speciali (RSP e RSNP) chimici e biologici . . . .89 6.9 Decreto legislativo N° 81/2008 Allegato XLVI. Elenco degli agenti biologici classificati . . . . . . . . .90 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 7 Microscopia ottica ed elettronica . . . 105 7.1 Microscopia ottica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 7.2 Microscopio ottico composto . . . . . . . . . . . . . . . . 107 7.2.1 Componenti del microscopio ottico composto . . . . . . 108 7.3 Difetti e limiti delle lenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 7.4 Vari tipi di microscopia ottica . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 7.4.1 Microscopia in campo chiaro . . . . . . . . . . . 111 7.4.2 Microscopia in campo oscuro . . . . . . . . . . . 112 7.4.3 Microscopia a contrasto di fase . . . . . . . . . 112 7.4.4 Microscopia con luce polarizzata . . . . . . . . 114 7.4.5 Microscopia a contrasto di interferenza differenziale (DIC) . . . . . 115 7.4.6 Microscopia a fluorescenza . . . . . . . . . . . . . 115 7.4.7 Microscopia confocale . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 7.5 Microscopio stereoscopico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 7.6 Microscopia elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 7.6.1 Microscopia elettronica a trasmissione (TEM) . . . . . . 120 7.6.2 Microscopia elettronica a scansione (SEM) . . . . 121 7.6.3 Microscopia elettronica ad alta tensione . 123 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 8 Preparati microscopici . . . . . . . . . . . . 125 8.1 Esame al microscopio ottico di campioni biologici . . . . . . . . . . . . 125 8.2 Coloranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 8.2.1 Caratteri chimici dei coloranti . . . . . . . . . . . 125 8.2.2 Classificazione dei coloranti . . . . . . . . . . . . 126 8.2.3 Preparazione dei coloranti . . . . . . . . . . . . . . 126 8.2.4 Reagenti usati nelle colorazioni . . . . . . . . . 127 8.3 Esami citologicI ed istologici . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 8.4 Esami citologici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 8.4.1 Allestimento di vetrini per l’esame a fresco . . . . .. . . . . . . . . 128 8.4.2 Colorazioni batteriologiche . . . . . . . . . . . . . 129 8.4.3 Colorazioni di cellule eucariotiche . . . . . . 135 8.5 Allestimento di preparati istologici . . . . . . . . . . . 137 8.5.1 Tecnica con microtomo congelatore . . . . 139 8.5.2 Principali colorazioni istologiche . . . . . . . . 139 8.5.3 Colorazioni istochimiche . . . . . . . . . . . . . . . 141 8.6 Allestimento di preparati per il TEM . . . . . . . . . . . 141 8.6.1 Sezioni ultrasottili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 8.6.2 Colorazione positiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 8.6.3 Ombreggiatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 8.6.4 Colorazione negativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 8.7 Allestimento dei preparati per il SEM . . . . . . . . . 143 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 PARTE III LA CRESCITA MICROBICA 9 Le esigenze microbiche . . . . . . . . . . . 149 9.1 Esigenze energetiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9.1.1 Fotoautotrofismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 9.1.2 Chemiotrofismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 9.2 Esigenze nutrizionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 9.3 Assunzione dei nutrienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 9.3.1 Struttura della membrana . . . . . . . . . . . . . . 153 9.4 Esigenze chimico-fisiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 9.4.1 Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 9.4.2 Pressione osmotica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 9.4.3 pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 9.4.4 Potenziale redox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 10 Colture microbiche . . . . . . . . . . . . . . 163 10.1 Finalità delle colture microbiche . . . . . . . . . . . . 163 10.2 Terreni di coltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 10.2.1 Classificazione dei terreni di coltura . . . .. . . . . 164 10.2.2 Componenti dei terreni di coltura . . . . 167 10.3 Preparazione dei terreni di coltura . . . . . . . . . . . 168 10.4 Principali tecniche colturali . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 10.4.1 Allestimento delle colture . . . . . . . . . . . 171 10.4.2 Esame colturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 10.4.3 Conservazione delle colture . . . . . . . . . 174 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 11 Riproduzione microbica . . . . . . . . . . 179 11.1 Ciclo riproduttivo dei procarioti . . . . . . . . . . . . . 179 11.2 Dinamica delle popolazioni microbiche . . . . . 182 11.2.1 Aspetti matematici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 11.3 Determinazioni quantitative . . . . . . . . . . . . . . . . 183 11.3.1 Prelievo, trasporto e trattamento del campione . . . . . . . . . 183 11.3.2 Determinazione del numero . . . . . . . . . 184 11.3.3 Determinazione della massa . . . . . . . . . 191 11.4 Curva di crescita microbica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 12 Controllo della crescita microbica. . 197 12.1 Agenti antimicrobici fisici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 12.1.1 Alte temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 12.1.2 Basse temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 12.1.3 Essiccamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 12.1.4 Radiazioni elettromagnetiche . . . . . . . . 204 12.1.5 Filtrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 12.2 Agenti antimicrobici chimici . . . . . . . . . . . . . . . . 206 12.2.1 Disinfettanti e antisettici . . . . . . . . . . . . . 207 12.2.2 Farmaci antimicrobici . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 PARTE IV BIOENERGETICA E METABOLISMO 13 Elementi di bioenergetica . . . . . . . . . 219 13.1 Processi metabolici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 13.1.1 Le reazioni metaboliche . . . . . . . . . . . . . 220 13.2 Gli enzimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 13.2.1 Cinetica enzimatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 13.3 Bioenergetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 13.3.1 Additività delle variazioni di energia libera . . . . . . 224 13.3.2 Molecole ad alto contenuto energetico . . . . . . . . . 225 13.3.3 Processi biologici e reazioni redox . . . . 226 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 14 Chemioeterotrofi smo . . . . . . . . . . . . 231 14.1 Respirazione aerobica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 14.1.1 Glicolisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 14.1.2 Destino del piruvato e del NADH . . . . . 234 14.1.3 Decarbossilazione ossidativa del piruvato . . .. . . . . . 236 14.1.4 Ciclo degli acidi tricarbossilici . . . . . . . . 236 14.1.5 Catabolismo aerobico dei lipidi . . . . . . 237 14.1.6 Catena di trasporto degli elettroni . . . 239 14.1.7 Fosforilazione ossidativa . . . . . . . . . . . . . 242 14.2 Fermentazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 14.3 Respirazione anaerobica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 15 Fotosintesi e chemiosintesi . . . . . . . 251 15.1 Fotoautotrofismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 15.1.1 Pigmenti fotosintetici . . . . . . . . . . . . . . . . 252 15.1.2 Fotofosforilazione ossigenica (fase luminosa) . .. . . . . . 253 15.1.3 Fotofosforilazione anossigenica (fase luminosa) . . . . . . . . 256 15.1.4 Ciclo di Calvin-Benson (fase oscura) . . 258 15.2 Chemioautotrofismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 PARTE V RIPRODUZIONE ED EREDITARIETÀ 16 Riproduzione cellulare . . . . . . . . . . . 265 16.1 Riproduzione asessuata e sessuata . . . . . . . . . . 265 16.2 Divisione cellulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 16.2.1 Divisione cellulare nei procarioti . . . . . 266 16.2.2 Divisione cellulare negli eucarioti . . . . 267 16.3 Ciclo cellulare negli eucarioti . . . . . . . . . . . . . . . . 268 16.3.1 Interfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 16.3.2 Mitosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 16.4 Regolazione del ciclo cellulare . . . . . . . . . . . . . . 273 16.4.1 Chinasi ciclina-dipendenti (CDK) e cicline . . .. . . . . . 274 16.4.2 Inibitori delle CDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 16.5 Malattie proliferative (o tumorali) . . . . . . . . . . . 276 16.5.1 Diagnosi e trattamento delle neoplasie maligne . . . . . . . . . 276 16.6 Cromosomi somatici e gametici . . . . . . . . . . . . . 276 16.6.1 Cromosomi somatici . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 16.6.2 Cromosomi gametici . . . . . . . . . . . . . . . . 277 16.7 Meiosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 16.7.1 Fasi della meiosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 16.7.2 Meiosi e varietà della discendenza . . . 280 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 17 Genetica mendeliana e post-mendeliana . . . . . . . . . . . . . . 283 17.1 Genetica mendeliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 17.1.1 Leggi di Mendel: dalla dominanza all’assortimento indipendente . . . . . . . 285 17.1.2 Assortimento indipendente dei caratteri . . .. . . . . . . 286 17.1.3 Malattie monogeniche (mendeliane) . . 288 17.2 Genetica post-mendeliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 17.2.1 Dominanza incompleta (eredità intermedia) . . . .. . . . . 289 17.2.2 Poliallelia (o alleli multipli) e codominanza . . . . . . . . . 290 17.2.3 La pleiotropia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 17.2.4 Eredità poligenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 17.2.5 La riscoperta del lavoro di Mendel e le basi cromosomiche dell’ereditarietà. . 293 17.2.6 La determinazione del sesso . . . . . . . . . 296 17.2.7 I geni localizzati sui cromosomi sessuali . . . . . . . . . . . 297 17.2.8 Le malattie legate al sesso nell’uomo . . . . . . . . . . . 298 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 18 Genetica dei procarioti . . . . . . . . . . . 301 18.1 Genoma dei procarioti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 18.1.1 Cromosoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 18.1.2 Plasmidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 18.1.3 Elementi trasponibili . . . . . . . . . . . . . . . . 302 18.1.4 Dimensioni del genoma procariotico . . . . . . . 303 18.2 Ruolo del genoma procariotico . . . . . . . . . . . . . 303 18.3 Replicazione del DNA procariotico . . . . . . . . . . 304 18.3.1 Ruolo della membrana plasmatica batterica e delle proteine actina-like . .306 18.3.2 Replicazione bidirezionale del DNA in E. coli . . . . . . . . . . . 307 18.4 Alterazioni del DNA batterico . . . . . . . . . . . . . . . 309 18.4.1 Fattori mutageni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 18.5 Meccanismi riparativi del DNA . . . . . . . . . . . . . . 310 18.5.1 Reversione delle mutazioni . . . . . . . . . . 312 18.6 Le mutazioni genetiche batteriche . . . . . . . . . . 312 18.7 Ricombinazione del DNA nei procarioti . . . . . . 313 18.7.1 Trasformazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 18.7.2 Coniugazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 18.7.3 Trasduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 18.7.4 Conversione fagica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 19 Espressione e regolazione dell’espressione genica nei procarioti . . . . . . . 323 19.1 Trascrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 19.2 Trascrizione nei procarioti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 19.2.1 Trascrizione in E. coli . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 19.3 Traduzione nei procarioti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 19.3.1 Il codice genetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 19.3.2 RNA coinvolti nella sintesi proteica . . . 330 19.3.3 Ribosomi batterici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 19.4 Fasi della traduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 19.4.1 Attivazione degli amminoacidi . . . . . . . 331 19.4.2 Formazione del complesso d’inizio . . . 331 19.4.3 Allungamento della catena . . . . . . . . . . 333 19.4.4 Termine della sintesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 19.4.5 Maturazione della catena peptidica . . 335 19.4.6 Elementi distintivi tra la sintesi proteica dei procarioti e degli eucarioti . . . . . . . 335 19.5 Ruolo della regolazione dell’espressione genica . . . . . . . . . . 336 19.5.1 Regolazione dell’espressione genica nei procarioti . . . . . . . 338 19.5.2 Meccanismi di regolazione trascrizionale . . . . . . . . . . . 338 19.5.3 La regolazione co-trascrizionale . . . . . . 343 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 PARTE VI I MICRORGANISMI EUCARIOTICI 20 Il regno dei funghi (Fungi) . . . . . . . . 347 20.1 Morfologia e struttura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 20.1.1 Le muffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 20.1.2 I lieviti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 20.2 Ecologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 20.3 Nutrizione e metabolismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 20.4 Esigenze chimico-fisiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 20.5 Riproduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 20.5.1 Riproduzione asessuata . . . . . . . . . . . . . . 350 20.5.2 Riproduzione sessuata . . . . . . . . . . . . . . . 350 20.6 Classificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 20.6.1 Divisione Eumycota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 20.6.2 Divisione Myxomycota . . . . . . . . . . . . . . . 356 20.7 Impiego dei funghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 21 Le alghe eucariotiche . . . . . . . . . . . . 361 21.1 Caratteri morfologico-strutturali . . . . . . . . . . . . 361 21.2 Ruolo delle alghe in natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 21.3 Distribuzione in natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 21.4 Modalità riproduttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 21.4.1 Riproduzione asessuata . . . . . . . . . . . . . . 364 21.4.2 Riproduzione sessuata . . . . . . . . . . . . . . . 364 21.5 Importanza pratica delle alghe . . . . . . . . . . . . . . 364 21.6 Importanza patologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 21.7 Classificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 21.7.1 Pirrofite (Divisione Pyrrophyta) . . . . . . . 366 21.7.2 Euglenofite (Divisione Euglenophyta) 367 21.7.3 Crisofite (Divisione Chrysophyta) . . . . . 369 21.7.4 Clorofite (Divisione Chlorophyta) . . . . . 370 21.7.5 Feofite (Divisione Phaeophyta) . . . . . . . 371 21.7.6 Rodofite (Divisione Rhodophyta) . . . . . 372 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 22 I protozoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 22.1 Morfologia e struttura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 22.2 Ecologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 22.3 Nutrizione e metabolismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 22.4 Riproduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 22.4.1 Riproduzione asessuata . . . . . . . . . . . . . . 376 22.4.2 Riproduzione sessuata . . . . . . . . . . . . . . 376 22.5 Classificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 22.5.1 Flagellati (Subphylum Mastigophora vel Flagellata) . . .. . . . . . . 377 22.5.2 Ciliati (Subphylum Ciliophora) . . . . . . . . 378 22.5.3 Sarcodini (Subphylum Sarcodina) . . . . . 380 22.5.4 Sporozoi (Subphylum Sporozoa) . . . . . . 383 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 PARTE VII TASSONOMIA E IDENTIFICAZIONE DEI PROCARIOTI 23 Tassonomia dei procarioti . . . . . . . . 391 23.1 Classificazione e nomenclatura . . . . . . . . . . . . . . 391 23.2 Bacteria e Archaea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 23.2.1 Sequenziamento dei nucleotidi dell’rRNA 16S (18S) . . .. . . . . . 394 23.2.2 Nomenclatura batterica. . . . . . . . . . . . . . 395 23.3 Dominio Archaea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 23.3.1 Crenarchaeota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 23.3.2 Euryarchaeota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 23.4 Dominio Bacteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 23.4.1 Cocchi Gram+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 23.4.2 Bacilli Gram– fermentanti . . . . . . . . . . . . 409 23.4.3 Bacilli Gram− ossidanti . . . . . . . . . . . . . . 415 23.4.4 Spirochete (Phylum Spirochaetes) . . . . . 425 23.4.5 Bacilli sporigeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 23.4.6 Bacilli Gram+ non sporigeni . . . . . . . . . . 435 23.4.7 Batteri fototrofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 23.4.8 Rickettsie, clamidie e micoplasmi . . . . 443 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 24 Identifi cazione dei procarioti . . . . . . 449 24.1 Criteri impiegati nell’identificazione . . . . . . . . . 449 24.2 Identificazione microscopica diretta . . . . . . . . . 449 24.3 Esame colturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 24.4 Identificazione biochimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 24.4.1 Identificazione mediante sistemi miniaturizzati . . .. . . . . . 453 24.5 Identificazione sierologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 24.6 Tipizzazione fagica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 24.7 Identificazione molecolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 24.8 Considerazioni conclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Domande di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Bibliografi a e sitografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1 Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1 |
Questo libro è anche in:
