Teorie Del Valore E Della Distribuzione. Un Confronto Tra Classici E Neoclassici
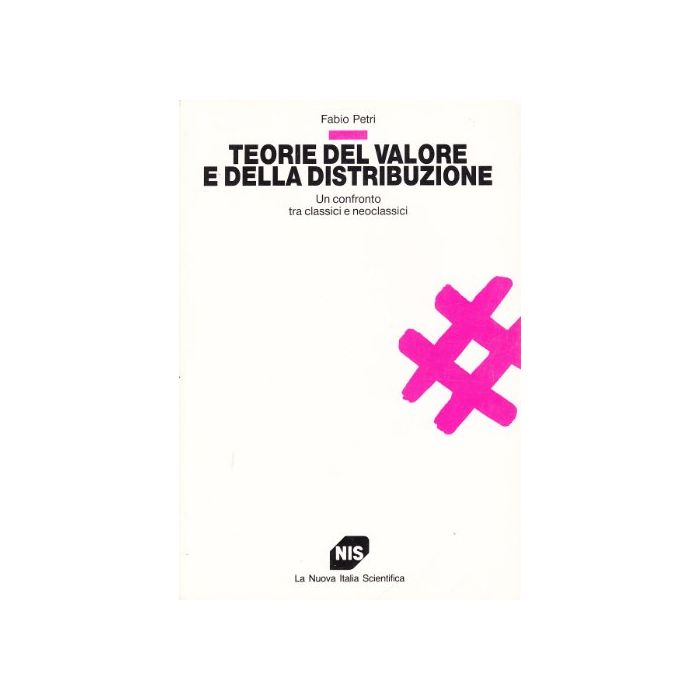
- ISBN/EAN
- 9788843009053
- Editore
- Carocci
- Collana
- Studi superiori
- Formato
- Brossura
- Anno
- 1989
- Pagine
- 308
Disponibile
29,70 €
Questo libro intende spiegare in modo rigoroso, ma per quanto possibile semplice, le due principali impostazioni in tema di valore, capitale e distribuzione: quella classica-marxiana-sraffiana e quella marginalista-neoclassica. Dopo una breve introduzione storica, la presentazione della prima impostazione, ivi inclusa la teoria del valore-lavoro di Marx, segue la linea interpretativa di Sraffa e Garegnani. Per la seconda, la trattazione si distacca considerevolmente da quelle usuali, incorporando le più recenti discussioni su luogo e breve periodo. In un capitolo conclusivo si evidenziano le radicali differenze tra le due impostazioni riguardo a disoccupazione, sfruttamento, differenziali salariali, crescita economica, effetti del progresso tecnico. Il libro, per il suo carattere di introduzione aggiornata e sistematica su valore, distribuzione, occupazione ed equilibrio generale, si rivolge a tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, hanno bisogno di approfondire questi argomenti affidandosi a una preparazione non specialistica.
Maggiori Informazioni
| Autore | Petri Fabio |
|---|---|
| Editore | Carocci |
| Anno | 1989 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | Studi superiori |
| Num. Collana | 72 |
| Lingua | Italiano |
| Indice | 1. Una breve introduzione storica 2. La ripresa dell’impostazione classica (o del sovrappiù) 2.1. Il concetto di sovrappiù 2.2. Saggio di profitto e prezzi di produzione 2.3. Beni e non-base, saggio di profitto e saggio d’interesse, curva salario-profitto e scelta delle tecniche 2.4. La spiegazione del saggio di salario 2.5. Il ’nucleo’ dell’impostazione classica e le teorie delle quantità e della tecnologia 2.6. Il ruolo della teoria del valore-lavoro negli autori classici 2.7. Sulla possibilità di considerare come dato il saggio di profitto 2.8. La merce tipo 2.9. Appendice: cenni sulla rendita differenziale e sul capitale fisso 3. Equilibrio di produzione e scambio 3.1. Caratteristiche generali dell’impostazione marginalista. Importanza della decrescenza delle curve di domanda dei fattori 3.2. La determinazione della distribuzione basata sulla sola sostituibilità diretta: il caso con lavoro e terra 3.3. Il caso con lavoro e capitale-grano 3.4. Giustificazione delle ipotesi di tecnologia comune, di rendimenti di scala costanti e di analisi di lungo periodo 3.5. La distribuzione determinata dalla sostituzione indiretta tra fattori: il ruolo delle scelte dei consumatori 3.6. Alcune perplessità sulla teoria presentata 3.7. L’equilibrio generale di produzione e scambio con n beni ed m fattori 3.8. Il ruolo della domanda nel determinare i prezzi dei prodotti 3.9. La necessità di introdurre disequazioni 3.10. Appendice: gli isoquanti spezzati 3.11. Appendice: la sostituzione indiretta e la curve di indifferenza indirette 4. Ottimo paretiano ed equilibrio generale di puro scambio 4.1. Equilibrio di puro scambio 4.2. L’ottimo paretiano in un’economia di puro scambio e di produzione e scambio 5. Equilibrio e saggio d’interesse con puro scambio e capitale omogeneo col prodotto 5.1. Il saggio d’interesse in un’economia di puro scambio 5.2. Il saggio d’interesse con produzione: il caso del capitale-grano 6. Il capitale eterogeneo e le posizioni di lungo periodo 6.1. Il metodo delle posizioni di lungo periodo 6.2. Metodo delle posizioni di lungo periodo e statica comparata 7. Walras 7.1. Introduzione 7.2. Modifiche alle equazioni (A)-(D) del modello di equilibrio generale senza beni capitali 7.3. Difficoltà dell’equilibrio generale con capitale in Walras 8. Il ’capitale’ come fattore omogeneo 8.1. Il capitale come fattore produttivo omogeneo ’cristallizzato’ nei singoli beni capitali 8.2. Le equazioni dell’equilibrio di lungo periodo (stazionario) 8.3. Difficoltà della nozione di ’capitale’ dal lato dell’offerta 8.4. Deficienze della nozione di ’capitale’ dal lato della domanda 8.5. La funzione di produzione aggregata e le implicazioni delle critiche 8.6. Implicazioni per il mercato del lavoro 8.7. Appendice: il periodo medio di produzione 9. L’equilibrio generale intertemporale 9.1. Nozione di equilibrio intertemporale e sua equivalenza formale con l’equilibrio di produzione e scambio senza capitale 9.2. L’introduzione esplicita dei beni intermedi 9.3. Molteplicità dei saggi d’interesse nell’equilibrio intertemporale 9.4. Alcune deficienze della nozione di equilibrio intertemporale 10. L’equilibrio generale temporaneo 10.1. L’incertezza, i mercati contingenti, l’equilibrio temporaneo 10.2. Walras equilibrio temporaneo’ 10.3. Deficienze della nozione di equilibrio temporaneo: mancanza di persistenza, aspettative, concorrenza 10.4. La stabilità del mercato risparmi-investimenti nell’equilibrio temporaneo: la critica di Garegnani 11. La moneta, Keynes e i modelli macroeconomici neoclassici di breve periodo 11.1. Il principio della domanda effettiva 11.2. Il ruolo della moneta negli economisti marginalisti prima di Keynes 11.3. Moneta e occupazione in Keynes 11.4. Il recupero neoclassico: anche in Keynes la colpa della disoccupazione è la rigidità dei salari (monetari) 11.5. Argomenti contro la ’sintesi neoclassica’. Importanza delle critiche al ’capitale’ 11.6. La domanda di lavoro nel breve periodo 11.7. Clower 11.8. Appendice: la funzione dell’investimento aggregato 12. Le differenze tra impostazione classica e impostazione marginalista 12.1. Alcune considerazioni conclusive 12.2. La differenza analitica di fondo tra le due impostazioni e le implicazioni per la disoccupazione 12.3. La questione dello sfruttamento 12.4. Altre differenze tra le due impostazioni |
Questo libro è anche in:
