Manipolazione Fasciale - Parte Pratica di Primo Livello - 2/Ed. [Stecco - Piccin Editore]
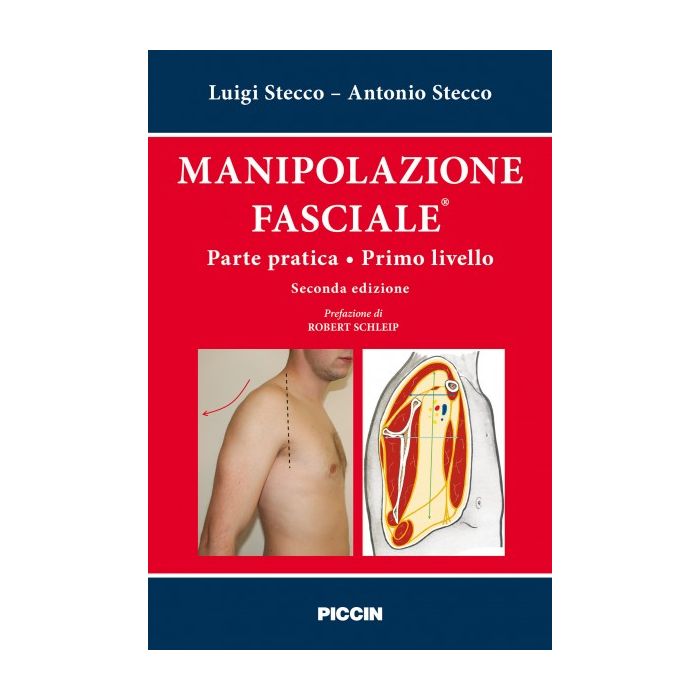
- ISBN/EAN
- 9788829928118
- Editore
- Piccin Editore
- Formato
- Cartonato
- Anno
- 2017
- Edizione
- 2
- Pagine
- 320
Disponibile
48,00 €
Benvenuti in un nuovo campo eccitante della terapia muscolo-scheletrica: l’affascinante mondo della fascia. La fascia forma una rete tensionale continua in tutto il corpo umano, che copre e colle- ga ogni singolo organo, ogni muscolo e anche ogni nervo o minuscola fibra muscolare. Dopo diversi decenni di grave trascuratezza, questo tessuto on- nipresente si è trasformato da “Cenerentola della scienza ortopedica” in super star nell’ambito della ricerca medica. A partire dai primi anni di questo secolo, il numero di articoli riguardanti le ricerche sulla fascia, in riviste peer-reviewed, ha registrato un aumento quasi esponenziale. Il 1° Congresso Internazionale “Fascia Research”, tenutosi pres- so l’Harvard Medical School nel mese di ottobre 2007, è stato celebrato con il riconoscimento in tutto il mondo. In parallelo alla rapida crescita nel campo della ricerca, vi è anche il riconoscimento che questo tessuto giochi un ruolo molto impor- tante per la salute, rispetto a quanto stimato nei decenni precedenti.
Ogni medico ricorda che la fascia, nei corsi di anatomia e di dissezione, era considerata come “roba di imballaggio” che bisognava prima pulire, al fine di “vedere qualcosa”. Allo stesso modo i li- bri di anatomia presentano l’apparato locomotore togliendo per bene la fascia biancastra, semi-tra- sparente. Mentre gli studenti apprezzano queste semplificazioni grafiche accattivanti, con i musco- li lucidi e rossi, i terapisti manuali sono frustrati quando vedono queste mappe semplificate, che non presentano il corpo reale come sentono du- rante la palpazione terapeutica.
I muscoli non trasmettono tutta la loro forza dai tendini allo scheletro, come di solito è evidenzia- to nei disegni dei libri di testo, ma distribuiscono una gran parte della loro contrazione alla fascia. La fascia trasmette queste forze ai muscoli an- tagonisti e ai muscoli sinergici e questa trasmis- sione può influenzare le regioni più lontane. Se guardiamo da vicino due muscoli potenti, come il grande gluteo e il tensore della fascia lata, ve- diamo che essi si inseriscono sulla fascia laterale
della coscia, chiamata tratto ileotibiale. Questo è parte dell’involucro fasciale della coscia, chia- mato fascia lata, che influenza il quadricipite, il comportamento del ginocchio e di tutta la parte inferiore della gamba.
Questa visione della fascia rende obsoleta la ricerca sulla partecipazione di un muscolo ad un particolare movimento. I muscoli non sono unità funzionali, in quanto la maggior parte dei movi- menti è generata da molte unità motorie distri- buite su alcune porzioni di un muscolo o su più muscoli. Le forze tensionali di queste unità moto- rie vengono poi trasmesse ad una complessa rete fasciale, che le trasforma in movimento finale del corpo.
Analogamente, è stato dimostrato che la rigidità ed elasticità fasciale svolgono un ruolo significati- vo in molti movimenti balistici del corpo. Da studi compiuti sui tessuti di vitelli, canguri, antilopi e ca- valli, è emerso che il rinculo fasciale gioca un ruo- lo impressionante in molti dei movimenti umani. La forza di gettare una pietra o di saltare in alto dipendono non solo dalla contrazione delle fibre muscolari, ma anche dal modo con cui l’elasticità della rete fasciale sostiene questi movimenti.
Se l’architettura della nostra rete fasciale è un fattore così importante nel comportamento mu- scolo-scheletrico, ci si chiede perché questo tes- suto sia stato trascurato per tanto tempo. Ci sono diverse risposte a questa domanda. La principale deriva dal metodo classico della ricerca anatomi- ca, cioè quella di separare il corpo in parti per po- tere dare a ciascuna un nome. Si può dare il nome alle ossa e ai muscoli, ma non alle fasce, in quanto il corpo fasciale è un grande organo, con centinaia di addensamenti “corda-like” e migliaia di logge, tutti collegati da setti robusti. Questa varietà di fasce ha favorito l’uso di molte terminologie diffe- renti per descrivere tipi di tessuto compresi sotto il termine “fascia”. Sia il sottile endomisio intra- muscolare sia la fascia superficiale possono esse- re considerati fascia o meglio tessuto connettivo lasso. Pure il tessuto connettivo denso irregolare
Introduzione
Questo libro è strutturato per essere d’aiuto agli allievi che frequentano i corsi di Manipolazione Fasciale.
Nei primi due capitoli si riportano le informazioni essenziali per poter comprendere l’anatomia e la fisiologia della fascia, si danno consigli su come attuare il trattamento e su come compilare la cartella.
Dal terzo all’ottavo capitolo si presentano le unità mf, che spostano i vari segmenti corporei nei tre piani dello spazio.
Ogni unità mf ha un Centro di Percezione (CP), che corrisponde al punto dove il paziente avverte il dolore, e un Centro di Coordinazione (CC), che corrisponde all’origine della disfunzione articolare.
La sede del CC è in un punto lontano dalla sede del dolore ed esso non è dolente fino a che non lo si trova con la palpazione.
La sede del dolore, o CP, è a livello dell’articolazione su cui agisce l’unità mf.
Su ogni articolazione operano sei unità mf: unità di antepulsione e di retropulsione, unità di latero pulsione e di mediopulsione, unità di intrarotazione e di extrarotazione.
In presenza di un dolore articolare, occorre effettuare una verifica motoria, per risalire all’unità mf responsabile di quel dolore. Essa non è un test per il singolo muscolo, ma valuta la funzionalità del complesso osteo-neuro-mio-fasciale, o unità mio-fasciale, che sposta un segmento in una precisa direzione.
Dopo il trattamento di Manipolazione Fasciale, molti pazienti affermano: “questo non è un massaggio”; in effetti questa terapia prevede una pressione profonda alla ricerca della densificazione della fascia. Una volta individuato il punto densificato, lo si lavora con le nocche o con i gomiti per vari minuti, fino alla scomparsa del dolore e il ripristino immediato della funzionalità articolare.
La seduta inizia con la raccolta dati, riportando il movimento doloroso che risveglia maggiormente il sintomo del paziente. Ogni unità mf attua lo spostamento di un segmento in una specifica direzione; quindi questo dato, riferito dal paziente, è un elemento utile per ipotizzare il coinvolgimento di una specifica unità mf.
L’ipotesi deve sempre essere convalidata dalla verifica motoria, prima di passare alla verifica palpatoria. Durante la verifica motoria si chiede al paziente di attuare il movimento doloroso riferito durante la raccolta dati. Alla fine della seduta si invita il paziente a rifare lo stesso movimento, il che serve a valutare il risultato post-trattamento. In presenza di dolori distribuiti in più segmenti, è utile trovare il piano dello spazio e la sequenza lungo la quale si dispongono questi dolori. In questi casi si chiede al paziente di attuare la verifica motoria dei segmenti più mobili.
Per facilitare la localizzazione dei punti, o cc, su cui effettuare la verifica palpatoria e poi il trattamento, si riportano varie immagini anatomiche.
Nelle immagini anatomiche del terzo capitolo sono riportati i tre CC che attuano, per ogni segmento del corpo umano, lo schema motorio di ante-medio-intra. Essendo il terzo capitolo dedicato alla sequenza di antepulsione, di conseguenza il lettore esaminerà soprattutto le fibre mono e biarticolari, che convergono nel CC di antepulsione (an).
Quando nel quinto capitolo si studierà la sequenza di mediopulsione e nel settimo quella di intrarotazione, allora lo studente si rifarà alle immagini anatomiche del terzo capitolo per trovare i muscoli che concorrono alla formazione dei CC di medio e di intra. Si è adottata questa strategia in modo da presentare al lettore una volta sola la localizzazione reciproca dei tre CC anteriori del corpo.Nelle immagini anatomiche del quarto capitolo sono riportati i tre cc, che attuano per ogni segmento lo schema motorio di retro-latero-extra.
Essendo il quarto capitolo dedicato alla sequenza di retropulsione, di conseguenza il lettore esaminerà soprattutto le fibre mono e biarticolari, che convergono nel CC di retropulsione. Quando nel sesto capitolo si studierà la sequenza di lateropulsione e nell’ottavo quella di extrarotazione, allora lo studente si rifarà alle immagini anatomiche del quarto capitolo per trovare i muscoli che concorrono alla formazione dei CC di latero e di extra.
Nelle immagini anatomiche del quinto capitolo sono riportati i tre CC anteriori del segmento in esame e i tre CC del segmento successivo. Questa scelta ha lo scopo di allenare lo studente ad attuare la verifica palpatoria non solo in senso trasversale dei tre CC di ante-medio-intra, ma anche in senso longitudinale lungo le stesse sequenze. Facciamo presente che la sede del dolore è sempre manifesta, mentre la sua origine è sempre nascosta o silente; quindi il tempo che si dedica alla verifica palpatoria non è mai sprecato.
Nelle immagini anatomiche del sesto capitolo sono riportati i tre CC posteriori del segmento in esame e i tre CC del segmento successivo. A queste immagini il lettore si rifà quando studia i CC del quarto e dell’ottavo capitolo. Nella patologia si verifica spesso che siano attivi entrambi i CC segnalati lungo la stessa sequenza.
Nelle immagini anatomiche del settimo capitolo sono riportati i sei CC di ogni segmento analizzato in sezione orizzontale. In questo capitolo sono presi in considerazione i tre CC di ante-medio-intra. Si fa presente che nelle sezioni orizzontali la loro localizzazione può essere un po’ più prossimale o distale rispetto a dove è disegnata; il CC viene riportato ugualmente sia per mostrare i suoi rapporti con i setti e i muscoli sottostanti, sia per mostrare la sua posizione rispetto al CC antagonista. In alcune immagini (7.20, 7.50, 7.60, ecc.) abbiamo anche inserito delle frecce per evidenziare la disposizione speculare del CC agonista rispetto al CC antagonista.
Nell’ottavo capitolo le sezioni orizzontali sono dedicate alla spiegazione dei tre CC di retro-latero-extra. I CC di questo schema motorio sono disposti negli arti e nel tronco nella parte posteriore rispetto ai CC di ante-medio-intra.
Il nono capitolo è dedicato alla presentazione delle verifiche motorie e palpatorie comparative.
La verifica motoria è chiamata comparativa, in quanto essa testa in contemporanea le sei unità mf che agiscono sui segmenti più mobili. La verifica palpatoria comparativa mette in confronto i CC di un emisoma con quelli dell’emisoma opposto.Quando si spiega la verifica palpatoria, dal terzo all’ottavo capitolo, si riporta fra parentesi il punto agopuntureo corrispondente al CC. Questo inserimento è utile in quanto qualche CC corrisponde a due o tre punti di agopuntura. In questi casi la verifica palpatoria deve ispezionare per primo il CC principale e poi il punto prossimale (p) e quello distale (d). Ad esempio, il CC re-ta si trova nella convergenza mio-tendinea dei due gastrocnemi; questo CC corrisponde al punto agopuntureo BL 57. Dal momento che la retropulsione del talo è attuata per diversi gradi lungo il piano sagittale, di conseguenza il centro di coordinazione può essere più prossimale, fra i due ventri dei gastrocnemi (BL 56) o più distale sopra il ventre del soleo (BL 58). Se si è trattato solo il CC principale, allora nella cartella si scrive re-ta; se si è trattato il CC prossimale, si scrive re-ta p.
Nel tronco, dove ogni vertebra è mossa dai propri muscoli profondi, ogni CC principale può essere dislocato leggermente in senso prossimale o distale.
Queste variabili del CC principale vengono presentate in quanto rendono la verifica palpatoria più libera e meno vincolata da confini prestabiliti.
Nella precedente edizione di questo volume mancavano le tavole anatomiche; ora ci sono, grazie ai disegni anatomici presi dal testo
Istituzioni di Anatomia dell’Uomo di G. Chiarugi e L. Bucciante.
Ringraziamo l’editore Piccin per averci concesso il loro utilizzo.
Gli Autori
Maggiori Informazioni
| Autore | Stecco Luigi; Stecco Antonio |
|---|---|
| Editore | Piccin Editore |
| Anno | 2017 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | 1. - Anatomia della fascia – Istologia della fascia – Modello biomeccanico . . . 1 Anatomia della fascia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Istologia della fascia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Biomeccanica della fascia . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. - Fisiologia della fascia – Dolore mio-fasciale – Cartella della MF . 35 Fisiologia della fascia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Dolore mio-fasciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Cartella per la MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3. - Sequenza mio-fasciale di antepulsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Unità mf di ante-capo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Unità mf di ante-capo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Unità mf di ante-capo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Unità mf di ante-collo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Unità mf di ante-torace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Unità mf di ante-lombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Unità mf di ante-pelvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Unità mf di ante-coxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Unità mf di ante-genu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Unità mf di ante-talo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Unità mf di ante-piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Unità mf di ante-scapola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Unità mf di ante-humerus . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Unità mf di ante-cubito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Unità mf di ante-carpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Unità mf di ante-dita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Strategie di trattamento per la sequenza di antepulsione . . . . . . . . . . . 106 4 - Sequenza mio-fasciale di retropulsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Unità mf di retro-capo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Unità mf di retro-capo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Unità mf di retro-capo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Unità mf di retro-collo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Unità mf di retro-torace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Unità mf di retro-lombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Unità mf di retro-pelvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Unità mf di retro-coxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Unità mf di retro-genu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Unità mf di retro-talo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Unità mf di retro-piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Unità mf di retro-scapola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Unità mf di retro-humerus . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Unità mf di retro-cubito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Unità mf di retro-carpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Unità mf di retro-dita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Strategie di trattamento per la sequenza di retropulsione . . . . . . . . . . . . . . . 140 5. - Sequenza mio-fasciale di mediopulsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Unità mf di medio-capo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Unità mf di medio-capo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Unità mf di medio-capo 2 retro . . . . . . . . . . . . . 145 Unità mf di medio-capo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Unità mf di medio-capo 3 retro . . . . . . . . . . . . . 147 Unità mf di medio-collo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Unità mf di medio-collo retro . . . . . . . . . . . . . . . 149 Unità mf di medio-torace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Unità mf di medio-torace retro . . . . . . . . . . . . . 151 Unità mf di medio-lombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Unità mf di medio-lombi retro . . . . . . . . . . . . . . 153 Unità mf di medio-pelvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Unità mf di medio-pelvi retro . . . . . . . . . . . . . . . 155 Unità mf di medio-coxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Unità mf di medio-genu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Unità mf di medio-talo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Unità mf di medio-piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Unità mf di medio-scapola . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Unità mf di medio-humerus . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Unità mf di medio-cubito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Unità mf di medio-carpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Unità mf di medio-dita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Strategie di trattamento per la sequenza di mediopulsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 6 - Sequenza mio-fasciale di lateropulsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Unità mf di latero-capo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Unità mf di latero-capo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Unità mf di latero-capo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Unità mf di latero-collo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Unità mf di latero-torace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Unità mf di latero-lombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Unità mf di latero-pelvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Unità mf di latero-coxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Unità mf di latero-genu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Unità mf di latero-talo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Unità mf di latero-piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Unità mf di latero-scapola . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Unità mf di latero-humerus . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Unità mf di latero-cubito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Unità mf di latero-carpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Unità mf di latero-dita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Strategie di trattamento per la sequenza di lateropulsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 7. - Sequenza mio-fasciale di intrarotazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Unità mf di intra-capo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Unità mf di intra-capo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Unità mf di intra-capo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Unità mf di intra-collo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Unità mf di intra-torace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Unità mf di intra-lombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Unità mf di intra-pelvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Unità mf di intra-coxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Unità mf di intra-genu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Unità mf di intra-talo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Unità mf di intra-piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Unità mf di intra-scapola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Unità mf di intra-humerus . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Unità mf di intra-cubito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Unità mf di intra-carpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Unità mf di intra-dita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Strategie di trattamento per la sequenza di intrarotazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 8. - Sequenza mio-fasciale di extrarotazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Unità mf di extra-capo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Unità mf di extra-capo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Unità mf di extra-capo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Unità mf di extra-collo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Unità mf di extra-torace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Unità mf di extra-lombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Unità mf di extra-pelvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Unità mf di extra-coxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Unità mf di extra-genu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Unità mf di extra-talo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Unità mf di extra-piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Unità mf di extra-scapola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Unità mf di extra-humerus . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Unità mf di extra-cubito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Unità mf di extra-carpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Unità mf di extra-dita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Strategie di trattamento per la sequenza di extrarotazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 9. - Verifiche motorie e verifiche palpatorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Verifiche motorie comparative . . . . . . . . . . . . . 278 Verifiche motorie comparative per il tronco: segmento cervicale . . . . . . . . . . 279 Verifiche motorie comparative per il tronco: segmento lombare . . . . . . . . . . . 280 Verifiche motorie in controresistenza delle sequenze del tronco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Scorciatoie per il tronco . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Ispezioni posturali del tronco . . . . . . . . . . . . . 283 Verifiche motorie comparative per l’arto inferiore: segmento coxa . . . . . . . . . . . . . . 284 Verifiche motorie comparative dell’arto inferiore: segmento talo . . . . . . . . . . . . . . 285 Verifiche motorie delle sequenze dell’arto inferiore in controresistenza . . . . . . . . . . . 286 Scorciatoie per l’arto inferiore . . . . . . . . . . . . 287 Ispezioni dell’allineamento dell’arto inferiore 288 Verifiche motorie comparative per l’arto superiore: segmento omerale . . . . . . . . . . 289 Verifiche motorie comparative per l’arto superiore: segmento carpale . . . . . . . . . . 290 Verifiche motorie delle sequenze dell’arto superiore in controresistenza . . . . . . . . . . 291 Scorciatoie per l’arto superiore . . . . . . . . . . . 292 Ispezioni delle deviazioni dell’arto superiore 293 Verifiche palpatorie comparative . . . . . . . . . . . . 294 Segmento oculare CP 1 bi . . . . . . . . . . . . . . . 295 Segmento mascellare CP 2 bi . . . . . . . . . . . . . 296 Segmento mandibolare CP 3 . . . . . . . . . . . . . 297 Segmento cervicale CL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Verifica comparativa longitudinale: segmenti toraco-lombare TH LU. . . . . . . . 299 Verifica comparativa longitudinale: segmenti lombo-pelvico LU PV . . . . . . . . . 300 Verifica comparativa longitudinale: segmenti coscia-genu CX GE . . . . . . . . . . . 301 Segmento del talo TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Segmento del piede PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Segmento della scapola SC . . . . . . . . . . . . . . . 304 Segmento dell’omero HU . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Segmento del cubito CU . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Segmento del carpo CA . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Segmento delle dita DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Conclusione 309 Bibliografia 310 |
Questo libro è anche in:
