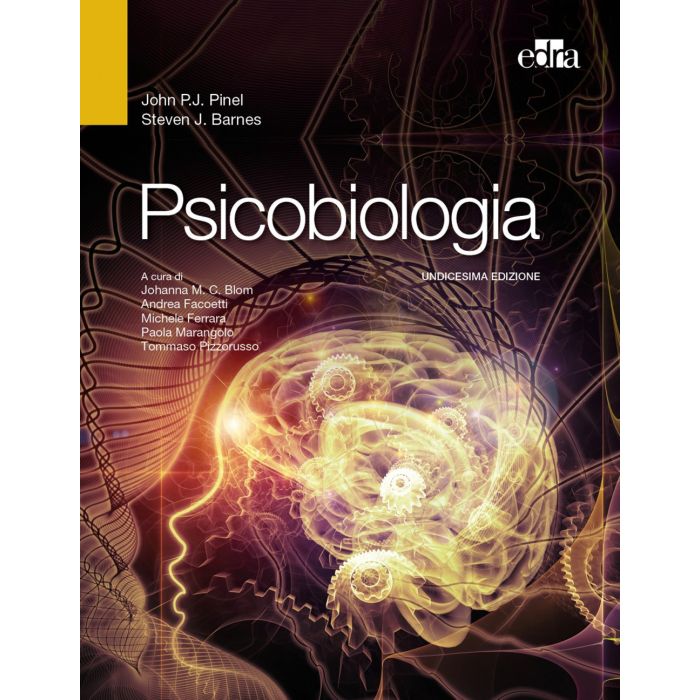| Indice |
Presentazione dell’edizione italiana v
Prefazione vii
Per gli studenti xxiii
Gli autori xxiii
PARTE I - COS'E' LA PSICOBIOLOGIA ?
1 PSICOBIOLOGIA COME NEUROSCIENZA
Che cos’è la psicobiologia?
Il caso di Jimmie G., l’uomo congelato nel tempo 3
Le quattro tematiche principali di questo testo 3
PENSIERO CREATIVO IN PSICOBIOLOGIA 3
• IMPLICAZIONI CLINICHE 3
• PROSPETTIVA EVOLUZIONISTICA 4
• NEUROPLASTICITÀ 4
Che cos’è la psicobiologia? 4
Definizione di psicobiologia 4
Quali sono le origini della psicobiologia? 4
In che modo la psicobiologia è correlata alle altre discipline delle neuroscienze? 4
Quali tipi di ricerca caratterizzano l’approccio psicobiologico? 5
Soggetti umani e non umani 5
Studi sperimentali e non sperimentali 6
Ricerca pura e applicata 8
Quali sono le branche della psicobiologia? 9
Psicologia fisiologica 10
Psicofarmacologia 10
Neuropsicologia 10
Il caso di R., lo studente con danno cerebrale che passò alla facoltà di architettura 10
Psicofisiologia 11
Neuroscienze cognitive 11
Psicologia comparata 12
In che modo lavorano gli psicobiologi? 13
Operazioni convergenti: in che modo gli psicobiologi collaborano tra loro? 13
Deduzione scientifica: in che modo gli psicobiologi studiano i processi non osservabili del cervello? 14
Pensiero critico sulle affermazioni della psicobiologia 16
Caso 1: José e il toro 16
Caso 2: Becky, Moniz e la lobotomia prefrontale 17
Riassunto dei temi affrontati 18 • Parole chiave 19
PARTE II - FONDAMENTI DI PSICOBIOLOGIA
2 EVOLUIZONE, GENETICA ED ESPERIENZA 20
Il pensiero sulla biologia del comportamento
Il pensiero sulla biologia del comportamento: dalle dicotomie alle interazioni 21
Le origini del pensiero dicotomico 21
È FISIOLOGICO O PSICOLOGICO? 21
• È INNATO O APPRESO? 22
Problemi insiti nel pensiero dicotomico applicato alla biologia del comportamento 22
IL PENSIERO “FISIOLOGICO O PSICOLOGICO” INCONTRA DEI PROBLEMI 22
Il caso dell’uomo che cadde dal letto 23
Il caso degli scimpanzé davanti allo specchio* 23
IL PENSIERO “NATURA O CULTURA” INCONTRA DEI PROBLEMI 24
Il caso della studentessa pensante 24
UN MODELLO DI BIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO 25
L’evoluzione dell’uomo 25
La teoria dell’evoluzione di Darwin 25
Evoluzione e comportamento 26
DOMINANZA SOCIALE 26
• RITUALI DI CORTEGGIAMENTO 27
Il percorso dell’evoluzione dell’uomo 27
EVOLUZIONE DEI VERTEBRATI 28
• EVOLUZIONE DEGLI ANFIBI 28
• EVOLUZIONE DEI RETTILI 28
• EVOLUZIONE DEI MAMMIFERI 28
• ORIGINE DEL GENERE UMANO 29
Il pensiero sull’evoluzione dell’uomo 30
Evoluzione del cervello umano 32
Psicologia evoluzionistica: comprendere i legami a scopo riproduttivo 33
POLIGAMIA E POLIANDRIA 34
• MONOGAMIA 34
• IL PENSIERO SULLA PSICOLOGIA EVOLUZIONISTICA 35
Genetica fondamentale 36
Genetica mendeliana 36
Cromosomi 36
RIPRODUZIONE E RICOMBINAZIONE 36
• STRUTTURA E REPLICAZIONE 37
• CROMOSOMI SESSUALI E CARATTERI LEGATI AL SESSO 39
Codice genetico ed espressione genica 39
Il progetto genoma umano 40
Genetica moderna: lo sviluppo dell’epigenetica 41
Epigenetica dello sviluppo del comportamento: interazione tra fattori genetici ed esperienza 44
Selezione artificiale dei ratti in base alla capacità di percorrere un labirinto 44
Fenilchetonuria: un disturbo metabolico a trasmissione monogenica 45
Lo sviluppo del canto negli uccelli 46
Genetica delle differenze psicologiche nell’uomo 47
Sviluppo degli individui e sviluppo di differenze tra gli individui 48
Stime di ereditabilità: il Minnesota Study of Twins Reared Apart 48
Uno sguardo al futuro: due tipi di studi sui gemelli 49
STUDI SUI GEMELLI RELATIVI AGLI EFFETTI EPIGENETICI 49
• STUDI SUI GEMELLI RELATIVI AGLI EFFETTI DELL’ESPERIENZA SULL’EREDITABILITÀ 50
3 - ANATOMIA DEL SISTEMA NERVOSO 52
Sistemi, strutture e cellule che costituiscono
il sistema nervoso
Struttura generale del sistema nervoso 53
Le divisioni del sistema nervoso 53
Meningi 54
Ventricoli e liquido cerebrospinale 55
Barriera emato-encefalica 56
Le cellule del sistema nervoso 57
Morfologia dei neuroni 57
MORFOLOGIA ESTERNA DEI NEURONI 57
• MORFOLOGIA INTERNA DEI NEURONI 57
• MEMBRANA CELLULARE DEI NEURONI 57
• CLASSI DI NEURONI 58
• NEURONI E STRUTTURA NEURO-ANATOMICA 60
Glia: le cellule dimenticate 60
Tecniche e orientamenti in neuroanatomia 62
Tecniche neuroanatomiche 62
COLORAZIONE DI GOLGI 62
• COLORAZIONE DI NISSL 63
• MICROSCOPIA ELETTRONICA 63
• TECNICHE DI TRACCIAMENTO NEUROANATOMICO 64
Orientamenti nel sistema nervoso dei vertebrati 64
Anatomia del sistema nervoso centrale 66
Midollo spinale 66
Le cinque divisioni principali dell’encefalo 66
Mielencefalo 67
Metencefalo 67
Mesencefalo 68
Diencefalo 69
Telencefalo 70
CORTECCIA CEREBRALE 70
Sistema limbico e nuclei della base 72
Riassunto dei temi affrontati 76 • Parole chiave 76
4 - CONDUZIONE NERVOSA E TRASMISSIONE SINAPTICA 77
In che modo i neuroni inviano e ricevono segnali
La lucertola, un caso di malattia di Parkinson* 78
Potenziale di membrana a riposo 79
Registrazione del potenziale di membrana 79
Le basi ioniche del potenziale di riposo 79
Generazione, conduzione e integrazione dei potenziali postsinaptici 80
Generazione e conduzione dei potenziali postsinaptici 80
Integrazione dei potenziali postsinaptici e generazione dei potenziali d’azione 81
Conduzione dei potenziali d’azione 84
Le basi ioniche dei potenziali d’azione 84
Periodi refrattari 84
Conduzione assonica dei potenziali d’azione 85
CONDUZIONE NEGLI ASSONI MIELINIZZATI 86
• VELOCITÀ DELLA CONDUZIONE ASSONICA 87
• CONDUZIONE NEI NEURONI PRIVI DI ASSONI 87
Il modello di Hodgkin-Huxley in prospettiva 87
Trasmissione sinaptica: trasmissione chimica di segnali tra i neuroni 87
Struttura delle sinapsi 88
Sintesi, impacchettamento e trasporto dei neurotrasmettitori 88
Rilascio dei neurotrasmettitori 90
Attivazione dei recettori da parte dei neurotrasmettitori 90
Ricaptazione, degradazione enzimatica e riciclaggio dei neurotrasmettitori 92
Glia, giunzioni comunicanti e trasmissione sinaptica 92
Neurotrasmettitori 94
Nozioni generali sulle diverse classi di neurotrasmettitori 94
Ruoli e funzioni dei neurotrasmettitori 95
NEUROTRASMETTITORI AMMINOACIDICI 95
• NEUROTRASMETTITORI MONOAMINICI 95
• ACETILCOLINA 96
• NEUROTRASMETTITORI NON CONVENZIONALI 96
• NEUROPEPTIDI 96
Farmacologia della trasmissione sinaptica e del comportamento 97
In che modo i farmaci influenzano la trasmissione sinaptica 97
Farmacologia comportamentale: tre linee di ricerca influenti 97
RUGHE E FRECCE: LA SCOPERTA DEI SOTTOTIPI
RECETTORIALI 97 • PIACERE E DOLORE: LA SCOPERTA DEGLI OPPIOIDI ENDOGENI 98
• TREMORI E MALATTIE MENTALI: LA SCOPERTA DEI FARMACI
ANTISCHIZOFRENICI 100
Riassunto dei temi affrontati 101
• Parole chiave 101
5 - METODI DI RICERCA IN PSICOBIOLOGIA 102
Che cosa fanno gli psicobiologi?
Il caso ironico del professor P. 104
PARTE I Metodi di studio del sistema nervoso 104
Metodi di visualizzazione e stimolazione del cervello umano in vivo 104
Tecniche basate sui raggi X 104
RADIOGRAFIA CON CONTRASTO 105
• TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA 105
Tecniche basate sulla radioattività 106
TOMOGRAFIA A EMISSIONE DI POSITRONI 106
Tecniche basate sui campi magnetici 106
RISONANZA MAGNETICA 106
• RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE 107
• IMAGING CON TENS0RE DI DIFFUSIONE 108
Stimolazione transcranica 108
Registrazione dell’attività psicofisiologica nell’uomo 109
Misure psicofisiologiche dell’attività cerebrale 109
ELETTROENCEFALOGRAFIA DI SUPERFICIE 109
• MAGNETOENCEFALOGRAFIA 111
Misure psicofisiologiche dell’attività del sistema nervoso somatico 111
TENSIONE MUSCOLARE 111
• MOVIMENTI OCULARI 111
Misure psicofisiologiche dell’attività del sistema nervoso autonomo 112
CONDUTTANZA CUTANEA 112
• ATTIVITÀ CARDIOVASCOLARE 112
Metodi invasivi di ricerca fisiologica 112
Chirurgia stereotassica 112
Metodi di lesione 113
LESIONI DA ASPIRAZIONE 113
• LESIONI DA RADIOFREQUENZA 113
• TAGLI DA BISTURI 113
• LESIONI REVERSIBILI 113
• INTERPRETAZIONI DEGLI EFFETTI DELLE LESIONI 114
• LESIONI BILATERALI E MONOLATERALI 114
Stimolazione elettrica 114
Metodi invasivi di registrazione elettrofisiologica 114
RESPIRAZIONE INTRACELLULARE MONOUNITARIA 114
• RESPIRAZIONE EXTRACELLULARE MONOUNITARIA 115
• REGISTRAZIONE MULTIUNITARIA 115
• REGISTRAZIONE ELETTROENCEFALOGRAFICA INVASIVA 115
Metodi di ricerca farmacologica 115
Vie di somministrazione dei farmaci 116
Lesioni chimiche selettive 116
Misurazione dell’attività chimica del cervello 116
TECNICA DEL 2-DESOSSIGLUCOSIO 116
• DIALISI CEREBRALE 116
Localizzazione dei neurotrasmettitori e dei recettori nel cervello 116
IMMUNOCITOCHIMICA 117
• IBRIDAZIONE IN SITU 117
Ingegneria genetica 118
Tecniche di knockout genico e di sostituzione genica 118
TECNICHE DI KNOCKOUT GENICO 118
• TECNICHE DI SOSTITUZIONE GENICA 118
Fluorescenza fantastica: la tecnica brainbow 119
Optogenetica: un interruttore nervoso 120
PARTE II Metodi di ricerca comportamentale in psicobiologia 120
Test neuropsicologici 121
Approccio moderno ai test neuropsicologici 121
APPROCCIO CON TEST SINGOLO 121
• APPROCCIO CON UNA BATTERIA DI TEST STANDARDIZZATA 121
• APPROCCIO CON UNA BATTERIA DI TEST
PERSONALIZZATA 121
Test neuropsicologici della batteria di base 122
INTELLIGENZA 122
• MEMORIA 123
• LINGUAGGIO 123
• LATERALIZZAZIONE DEL LINGUAGGIO 123
Test per la valutazione di specifiche funzioni neuropsicologiche 123
MEMORIA 123 • LINGUAGGIO 124
Funzione del lobo frontale 124
Metodi comportamentali delle neuroscienze cognitive 125
Tecnica di sottrazione di immagini 125
Default Mode Network 125
Immagine di differenza media 125
Paradigmi psicobiologici per lo studio del comportamento animale 126
Paradigmi per la valutazione di comportamenti di specie 126
TEST DELL’OPEN-FIELD 127
• TEST DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI AGGRESSIVI E DIFENSIVI 127
• TEST DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SESSUALE 127
Paradigmi di condizionamento tradizionali 127
Paradigmi seminaturali di apprendimento negli animali 128
AVVERSIONE CONDIZIONATA AL GUSTO 128
• LABIRINTO A BRACCI RADIALI 128
• LABIRINTO ACQUATICO DI MORRIS 129
• SOTTERRAMENTO CONDIZIONATO DIFENSIVO 129
Riassunto dei temi affrontati 130
• Parole chiave 130
PARTE III - SISTEMA SENSOMOTORIO
6 - SISTEMA VISIVO 132
Come vediamo
Il caso della signora Richards: gli spettri di fortificazione e l’astronomo 134
La luce entra nell’occhio e raggiunge la retina 134
Pupilla e cristallino 135
Posizione dell’occhio e disparità binoculare 136
La retina e la trasduzione della luce in segnali nervosi 138
La struttura della retina 138
Coni e bastoncelli 139
Sensibilità spettrale 141
Movimenti oculari 142
Trasduzione visiva: la conversione della luce
in segnali nervosi 143
Dalla retina alla corteccia visiva primaria 144
Sistema retino-genicolo-striato 144
Organizzazione retinotopica 144
I canali M e P 145
Visione dei margini 146
Inibizione laterale e aumento di contrasto 146
Campi recettivi dei neuroni visivi 147
Campi recettivi: i neuroni del sistema retino-genicolo-striato 148
Campi recettivi 149
CELLULE CORTICALI SEMPLICI 149 • CELLULE
CORTICALI COMPLESSE 150
Organizzazione della corteccia visiva primaria 150
Il caso della signora Richards, rivisitato 151
Cambiare il concetto dei campi recettivi visivi: le influenze contestuali nell’elaborazione visiva 151
Visione dei colori 152
Teoria dei componenti e della elaborazione dell’opponenza 152
Costanza del colore e teoria retinex 153
Meccanismi corticali della visione e consapevolezza cosciente 156
Tre diverse classi della corteccia visiva 156
Danni alla corteccia visiva primaria: scotomi e completamento 156
Il caso dello fisiologo e psicologo che faceva scomparire i volti 157
Il caso di D.B., l’uomo confuso dal suo blindsight 157
Aree funzionali della corteccia visiva secondaria e associativa 158
Via dorsale e via ventrale 158
Il caso di D.F., la donna che poteva afferrare gli oggetti che non vedeva in modo cosciente 160
Il caso di A.T., la donna che non sapeva afferrare accuratamente gli oggetti non familiari che vedeva 160
Prosopoagnosia 160
LA PROSOPOAGNOSIA È SPECIFICA PER I VOLTI? 161
R.P., un tipico prosopoagnosico 162
QUALE PATOLOGIA DEL CERVELLO È ASSOCIATA CON LA PROSOPOAGNOSIA? 162
• I PROSOPOAGNOSICI POSSONO PERCEPIRE I VOLTI IN ASSENZA DI UNA CONSAPEVOLEZZA COSCIENTE? 162
Achinetopsia 162
Due casi di achinetopsia indotta dai farmaci 162
7 - MECCCANISMI DELLA PERCEZIONE: udire, sentire, annusare, assaporare e l’attenzione 165
Il caso dell’uomo che poteva vedere soltanto una cosa per volta 167
Principi di organizzazione del sistema sensoriale 167
Tipologie di aree sensoriali della corteccia 167
Caratteristiche dell’organizzazione del sistema sensoriale 167
ORGANIZZAZIONE GERARCHICA 167
Il caso dell’uomo che scambiò sua moglie per un cappello* 168
SEGREGAZIONE FUNZIONALE 168
• ELABORAZIONE IN PARALLELO 168
• MODELLO RIASSUNTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SENSORIALE 168
Sistema uditivo 169
Dimensioni fisiche e percettive del suono 169
L’orecchio 170
Dall’orecchio alla corteccia uditiva primaria 172
Meccanismi subcorticali di localizzazione del suono 172
La corteccia uditiva 173
ORGANIZZAZIONE DELLA CORTECCIA UDITIVA NEI PRIMATI 173
• QUALI SONO I SUONI CHE DOVREBBERO
ESSERE USATI PER STUDIARE LA CORTECCIA UDITIVA? 173
• LE DUE VIE DELLA CORTECCIA UDITIVA 173
• L’INTERAZIONE VISUO-UDITIVA 174
• DOVE AVVIENE LA PERCEZIONE DELL’ALTEZZA DEL SUONO? 174
Gli effetti delle lesioni al sistema uditivo 174
LESIONI ALLA CORTECCIA UDITIVA 175
• SORDITÀ NELL’UOMO 175
Sistema somatosensoriale: tatto e dolore 176
Recettori cutanei 176
DERMATOMERI 177
Le due vie somatosensoriali principali 177
Aree corticali somatosensoriali 178
EFFETTI DEI DANNI ALLA CORTECCIA SOMATOSENSORIALE PRIMARIA 180
Sistema somatosensoriale e corteccia associativa 181
Il caso di W.M. che riduceva il suo scotoma con la mano 181
Agnosie somatosensoriali 181
Il caso di zia Betty, che perse metà del suo corpo* 181
L’illusione della mano di gomma 181
Percezione del dolore 182
ADATTABILITÀ DEL DOLORE 182
• LA MANCANZA DI UNA CHIARA RAPPRESENTAZIONE CORTICALE DEL DOLORE 183
Il caso della signorina C., la donna che non sentiva il dolore 182
LA MANCANZA DI UNA CHIARA RAPPRESENTAZIONE CORTICALE DEL DOLORE 183
• CONTROLLO DISCENDENTE DEL DOLORE 183
Il dolore neuropatico 184
Sensi chimici: olfatto e gusto 184
Ruolo adattivo dei sensi chimici 185
Sistema olfattivo 185
Sistema gustativo 187
Sintonizzazione ampia versus specifica 188
Danni cerebrali e sensi chimici 189
L’attenzione selettiva 189
Caratteristiche dell’attenzione selettiva 189
Cecità al cambiamento 190
Meccanismi neurali dell’attenzione 190
Simultaneoagnosia 192
Riassunto dei temi affrontati 192 • Parole chiave 192
8 - SISTEMA SENSOMOTORIO 194
Come funziona il movimento
Il caso di Rhonelle, l’abile cassiera 196
I tre principi della funzione sensomotoria 196
Il sistema sensomotorio è organizzato gerarchicamente 196
L’output motorio è guidato dall’input sensoriale 197
Il caso di G.O., l’uomo con un feedback insufficiente 197
L’apprendimento modifica la natura e la sede del controllo sensomotorio 197
Modello generale della funzione del sistema sensomotorio 197
Corteccia associativa sensomotoria 198
Corteccia associativa parietale posteriore 198
Il caso della signora S., la donna che girava in cerchio 199
Corteccia associativa prefrontale dorsolaterale 200
Corteccia motoria secondaria 201
Identificazione delle aree della corteccia motoria secondaria 201
Neuroni specchio 202
Corteccia motoria primaria 203
Visione tradizionale della funzione della corteccia motoria primaria 203
Visione attuale della funzione della corteccia motoria primaria 204
Belle: la scimmia che controllava un robot con la mente 205
EFFETTI DELLE LESIONI DELLA CORTECCIA MOTORIA PRIMARIA 205
Cervelletto e nuclei della base 205
Cervelletto 206
Nuclei della base 206
Vie motorie discendenti 207
Tratto corticospinale dorsolaterale e tratto corticorubrospinale dorsolaterale 207
Tratto corticospinale ventromediale e tratto cortico-troncoencefalo-spinale ventromediale 207
Confronto tra le due vie motorie dorsolaterali e le due vie motorie ventromediali 208
Circuiti sensomotori spinali 210
Muscoli 210
Organi recettori dei tendini e dei muscoli 211
Riflesso da stiramento 212
Riflesso di evitamento 213
Innervazione reciproca 213
Inibizione collaterale ricorrente 214
La deambulazione: un complesso riflesso sensomotorio 214
Programmi sensomotori centrali e apprendimento 216
Una gerarchia di programmi sensomotori centrali 216
Caratteristiche dei programmi sensomotori centrali 216
I PROGRAMMI SENSOMOTORI CENTRALI SONO
CAPACI DI EQUIVALENZA MOTORIA 216
• LE INFORMAZIONI SENSORIALI CHE CONTROLLANO I
PROGRAMMI SENSOMOTORI CENTRALI NON SONO NECESSARIAMENTE COSCIENTI 216
• I PROGRAMMI SENSOMOTORI CENTRALI POSSONO SVILUPPARSI IN
ASSENZA DI PRATICA 217
• LA PRATICA È IN GRADO DI CREARE PROGRAMMI SENSOMOTORI CENTRALI 217
Neuroimaging funzionale dell’apprendimento
sensomotorio 218
Il caso di Rhonelle rivisitato 219
Riassunto dei temi affrontati 219 • Parole chiave 219
PARTE IV - PLASTICITA' CEREBRALE
9 - SVILUPPO DEL SISTEMA NERVOSO 221
Dalla fecondazione all’essere umano
Il caso di Genie 222
Cinque fasi del neurosviluppo 223
Induzione della placca neurale 223
Proliferazione neuronale 224
Migrazione e Aggregazione 224
MIGRAZIONE 224
• AGGREGAZIONE 226
Crescita assonale e formazione delle sinapsi 226
CRESCITA ASSONALE 226
• FORMAZIONE DELLE SINAPSI 228
Morte neuronale e riorganizzazione sinaptica 229
MORTE NEURONALE 229
Sviluppo cerebrale postnatale negli infanti 230
Crescita postnatale del cervello umano 231
Sviluppo della corteccia prefrontale 231
Effetti dell’esperienza sullo sviluppo postnatale dei circuiti neurali 232
Periodo critico contro periodo sensibile 232
Primi studi degli effetti dell’esperienza sul neurosviluppo: deprivazione e arricchimento 232
Natura competitiva dell’esperienza sul neurosviluppo: le colonne di dominanza oculare 232
Effetti dell’esperienza sulle mappe topografiche della corteccia sensoriale 233
Regolazione del neurosviluppo tramite l’esperienza 234
Neuroplasticità negli adulti 234
Neurogenesi nei mammiferi adulti 234
Effetti dell’esperienza sulla riorganizzazione della corteccia adulta 236
Disturbi del neurosviluppo: il disturbo dello spettro autistico e la sindrome di Williams 236
Disturbo dello spettro autistico 237
Il caso di Alex: siete pronti al rock? 237
IL DSA È UN DISTURBO ETEROGENEO 238
• DSA SAVANT 238
Casi di straordinarie abilità savant 238
BASI GENETICHE DEL DSA 238
• MECCANISMI NEURALI DEL DSA 238
Sindrome di Williams 239
Il caso di Anne Louise McGarrah: abilità incostanti 239
EPILOGO 240
Riassunto dei temi affrontati 240
• Parole chiave 241
10 - LESIONI CEREBRALI E NEUROPLASTICITA' 242
Il cervello può guarire da una lesione?
L’ironico caso del Professore P. 243
Cause di un danno cerebrale 244
Tumori cerebrali 244
Disturbi cerebrovascolari: ictus 245
EMORRAGIA CEREBRALE 246
• ISCHEMIA CEREBRALE 246
Traumi cranici chiusi 247
Il caso di Junior Seau 248
Infezioni del cervello 248
INFEZIONI BATTERICHE 248 • INFEZIONI VIRALI 248
NEUROTOSSINE 249
Fattori genetici 249
Morte cellulare programmata 250
Disturbi neurologici 250
Epilessia 250
CRISI FOCALI 251
La sottigliezza delle crisi parziali complesse: due casi 251
CRISI GENERALIZZATE 251
Morbo di Parkinson 252
Corea di Huntington 253
Sclerosi multipla 254
Malattia di Alzheimer 254
Modelli animali dei disturbi neurologici 257
Modello “kindling” dell’epilessia 257
Modelli di topo transgenico della malattia di Alzheimer 258
Modello MPTP del morbo di Parkinson 258
I casi dei tossicodipendenti “bloccati” 258
Risposte a un danno del sistema nervoso: degenerazione, rigenerazione,
riorganizzazione e recupero 259
Degenerazione neuronale 259
Rigenerazione neuronale 259
Riorganizzazione neuronale 261
RIORGANIZZAZIONE CORTICALE A SEGUITO DI UNA
LESIONE IN ANIMALI DA LABORATORIO 262
• RIORGANIZZAZIONE CORTICALE A SEGUITO DI UNA LESIONE NEGLI UMANI 263
• MECCANISMI DI RIORGANIZZAZIONE NEURONALE 263
Recupero di una funzione dopo una lesione all’SNC 263
Neuroplasticità e trattamento di un danno all’SNC 264
Trapianto neuronale come trattamento di un danno all’SNC: le prime ricerche 265
Il caso di Roberto Garcia d’Orta: la lucertola che ottenne l’autotrapianto 265
Ricerca moderna sul neurotrapianto 266
Promuovere il recupero da una lesione all’SNC attraverso trattamenti riabilitativi 266
TRATTAMENTO DELL’ICTUS 266
• TRATTAMENTO DELLE LESIONI ALLA COLONNA VERTEBRALE 267
• Il caso di Carlos e Philip: arti fantasma e Ramachandran 268
L’ironico caso del Professor P.: il recupero 268
Riassunto dei temi affrontati 269 • Parole chiave 269
11 - APPRENDIMENTO, MEMORIA E AMNESIA 271
In che modo il cervello immagazzina le informazioni
Effetti amnesici della lobectomia temporale mediale bilaterale 273
Il caso di H.M., l’uomo che cambiò lo studio della memoria 273
Valutazione formale dell’amnesia anterograda di H.M.:
la scoperta dei ricordi inconsci 274
TEST DELLO SPAN DI CIFRE + 1 274
• TEST DEI CUBETTI 274
• TEST DEL DISEGNO ALLO SPECCHIO 274
• TEST DELLE FIGURE INCOMPLETE 274
I tre principali contribuiti scientifici apportati dal caso di H.M. 275
Amnesia del lobo temporale mediale 276
Memoria semantica e memoria episodica 277
Il caso di K.C., l’uomo che non riusciva a viaggiare nel tempo 277
Il caso del neuropsicologo scaltro: come individuare i deficit di memoria episodica 277
Effetti dell’ischemia cerebrale globale sull’ippocampo e sulla memoria 278
Il caso di R.B., il prodotto di un intervento malriuscito 278
Amnesia nella sindrome di Korsakoff e nella malattia di Alzheimer 279
Amnesia nella sindrome di Korsakoff 279
Il caso di N.A., l’uomo con un’amnesia indotta “su per il naso” 279
Amnesia nella malattia di Alzheimer 280
Amnesia da concussione cerebrale: evidenze a supporto del consolidamento 280
Amnesia post-traumatica 280
Gradienti di amnesia retrograda e consolidamento della memoria 281
IPPOCAMPO E CONSOLIDAMENTO 282
• RICONSOLIDAMENTO 282
Prospettive in evoluzione sul ruolo dell’ippocampo nella memoria 283
Modelli animali di amnesia nel riconoscimento di oggetti: il test di corrispondenza differita
con stimoli diversi dallo stimolo campione 283
TEST DI CORRISPONDENZA DIFFERITA CON STIMOLI DIVERSI DALLO STIMOLO CAMPIONE NELLE SCIMMIE 283
• TEST DI CORRISPONDENZA DIFFERITA CON STIMOLI DIVERSI DALLO STIMOLO CAMPIONE NEL RATTO 285
Basi neuroanatomiche dei deficit di riconoscimento
degli oggetti derivanti dalla lobectomia temporale mediale bilaterale 287
Neuroni dei lobi temporali mediali e memoria 288
TEST DEL LABIRINTO ACQUATICO DI MORRIS 288
• TEST DEL LABIRINTO A BRACCI RADIALI 289
Cellule di posizione dell’ippocampo e cellule griglia della corteccia entorinale 289
Studi comparativi sull’ippocampo e sulla memoria spaziale 290
I neuroni di Jennifer Aniston: le cellule di concetto 290
Cellule engramma 291
Dove vengono conservati i ricordi? 292
Cinque aree cerebrali coinvolte nella memoria 292
CORTECCIA INFEROTEMPORALE 292
• AMIGDALA 293
• CORTECCIA PREFRONTALE 293
Il caso della cuoca che non poteva cucinare 293
CERVELLETTO E CORPO STRIATO 293
Meccanismi sinaptici dell’apprendimento e della memoria 294
Potenziamento a lungo termine 294
Induzione dell’LTP: apprendimento 296
Mantenimento ed espressione dell’LTP: immagazzinamento e richiamo 298
Variabilità dell’LTP 298
Conclusione: la psicobiologia della memoria e voi 298
Amnesia infantile 299
Droghe intelligenti: funzionano? 299
AMNESIA POST-TRAUMATICA E MEMORIA EPISODICA 299
Il caso di R.M., lo psicobiologo che si ricordò di H.M. 300
Riassunto dei temi affrontati 300
PARTE V - PSICOBIOLOGIA DELLA MOTIVAZIONE
12 - FAME, ALIMENTAZIONE E SALUTE 302
Perché molte persone mangiano troppo?
Il caso dell’uomo che si scordava di aver già mangiato 304
Digestione, immagazzinamento e utilizzo dell’energia 304
Digestione e immagazzinamento energetico nel corpo 304
DIGESTIONE 304
• L’IMMAGAZZINAMENTO ENERGETICO
DEL CORPO 304
Tre fasi del metabolismo energetico 305
Teorie sulla fame e sull’alimentazione: set points o incentivi positivi? 306
Teoria del set-point 306
TEORIA GLUCOSTATICA 308
• TEORIA LIPOSTATICA 308
• LE PROBLEMATICHE DELLE TEORIE DEL SET-POINT
DELLA FAME E DELL’ALIMENTAZIONE 308
Prospettiva dell’incentivo positivo 309
Fattori che determinano che cosa, quando e quanto mangiamo 309
Fattori che influenzano che cosa mangiamo 309
PREFERENZA E AVVERSIONE APPRESE AL SAPORE 309
• IMPARARE A MANGIARE VITAMINE E SALI MINERALI 309
Fattori che influenzano quando mangiamo 310
LA FAME CHE PRECEDE IL PASTO 310
• IL CONDIZIONAMENTO PAVLOVIANO DELLA FAME 310
Fattori che influenzano quanto mangiamo 311
SEGNALI DI SAZIETÀ 311
• FALSI PASTI 311
• EFFETTO ANTIPASTO E SAZIETÀ 311
• PORZIONE E SAZIETÀ 311
• INFLUENZE SOCIALI E SAZIETÀ 311
• SAZIETÀ SENSORIALE SPECIFICA 311
Fisiologia della fame e della sazietà
Ruolo dei livelli ematici di glucosio nella fame e nella sazietà 313
Il mito della fame ipotalamica e dei centri della sazietà 313
IL VMH COME CENTRO DELLA SAZIETÀ 313
• L’LH COME CENTRO DELL’ALIMENTAZIONE 314
• REINTERPRETAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE LESIONI DEL VMH E DELL’LH 314
• LA MODERNA RICERCA SUL RUOLO DELL’IPOTALAMO NELLA FAME E NELLA SAZIETÀ 315
Ruolo del tratto gastrointestinale nella sazietà 315
Peptidi della fame e della sazietà 316
Serotonina e sazietà 317
Sindrome di Prader-Willi: i pazienti con fame insaziabile 317
La sindrome di Prader-Willi: il caso della signorina A. 317
Regolazione del peso corporeo: le teorie dei set-point e dei punti di equilibrio 318
Le ipotesi del set-point sul peso corporeo e sull’alimentazione 318
VARIABILITÀ DEL PESO CORPOREO 318
• IL SET-POINT E LA SALUTE 318
• REGOLAZIONE DEL PESO CORPOREO PER MEZZO DI CAMBIAMENTI NELL’EFFICIENZA DI UTILIZZO DELL’ENERGIA 319
Set-point e punti di equilibrio nel controllo del peso 319
Obesità umana: cause, meccanismi e trattamenti 322
Obesità: chi dovrebbe preoccuparsene? 322
Obesità: perché c’è un’epidemia? 322
Perché alcune persone diventano obese mentre ad altre non accade? 323
DIFFERENZE NELL’ASSUNZIONE DI ALIMENTI 323
• DIFFERENZE NEL CONSUMO ENERGETICO 323
• DIFFERENZE NELLA COMPOSIZIONE DEL MICROBIOMA INTESTINALE 323
• FATTORI GENETICI ED EPIGENETICI 323
Perché i programmi di perdita di peso sono spesso inefficaci? 324
Leptina e regolazione del grasso corporeo 324
TOPI OBESI E LA SCOPERTA DELLA LEPTINA 324
• LEPTINA, INSULINA E IL SISTEMA MELANOCORTINERGICO DEL NUCLEO ARCUATO 325
• LA LEPTINA COME TRATTAMENTO PER L’OBESITÀ UMANA 325
Il caso della bambina senza leptina 326
Trattamento dell’obesità 326
AGONISTI SEROTONINERGICI 326 • LA CHIRURGIA
GASTRICA 326
Anoressia e bulimia nervosa 326
Anoressia e bulimia nervosa 327
ANORESSIA NERVOSA 327 • BULIMIA NERVOSA 327
La relazione tra anoressia e bulimia 328
Anoressia e incentivo positivo 328
Anoressia nervosa: un’ipotesi 329
Il caso della studentessa con anoressia 329
Riassunto dei temi affrontati 330 • Parole chiave 330
13 - GLI ORMONI E IL SESSO 331
Cos’è che non va con il Mamawawa? Sistema neuroendocrino 333
L’IPOTESI CHE GLI UOMINI-SIANO-UOMINI-E-LEDONNESIANO-DONNE 333
• EFFETTI DEGLI ORMONI SESSUALI SULLO SVILUPPO E SULL’ATTIVAZIONE DEL COMPORTAMENTO DI RIPRODUZIONE 333
Ghiandole 333
LE GONADI 334
Ormoni 334
STEROIDI SESSUALI 334
Ipofisi 335
I LIVELLI DEGLI ORMONI GONADICI FEMMINILI SONO CICLICI, I LIVELLI DEGLI ORMONI GONADICI MASCHILI SONO STABILI 335
Controllo dell’ipofisi 335
CONTROLLO DELL’IPOFISI ANTERIORE E POSTERIORE DA PARTE DELL’IPOTALAMO 336
La scoperta dei fattori di rilascio ipotalamici 336
Regolazione dei livelli ormonali 337
REGOLAZIONE DA SEGNALI NEURALI 337
• REGOLAZIONE DA SEGNALI ORMONALI 337
• REGOLAZIONE DA PARTE DELLE SOSTANZE CHIMICHE NON ORMONALI 338
• RILASCIO PULSATILE DEGLI ORMONI 338
Modello riassuntivo della regolazione degli ormoni gonadici 338
Ormoni sessuali e sviluppo corporeo 338
La differenziazione sessuale 339
GLI ORMONI FETALI E LO SVILUPPO DEGLI ORGANI RIPRODUTTIVI 339
• I DOTTI RIPRODUTTIVI 339
• ORGANI RIPRODUTTIVI ESTERNI 340
Pubertà: gli ormoni e lo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie 340
Gli ormoni sessuali e lo sviluppo del cervello e del comportamento 341
Differenze sessuali nel cervello 341
LA PRIMA SCOPERTA DI UNA DIFFERENZA SESSUALE NELLA FUNZIONE DEL CERVELLO DEI MAMMIFERI 342
• IPOTESI DELL’AROMATIZZAZIONE 342
• DIFFERENZE SESSUALI NEL CERVELLO: LE TEORIE MODERNE 343
Sviluppo delle differenze sessuali nel comportamento 344
SVILUPPO DEI COMPORTAMENTI RIPRODUTTIVI IN ANIMALI DA LABORATORIO 344
• SVILUPPO DELLE DIFFERENZE SESSUALI NEL COMPORTAMENTO UMANO 344
Casi di sviluppo sessuale umano eccezionale 345
Casi eccezionali di sviluppo sessuale umano 346
Il caso di Anne S., la donna che non era donna 346
Il caso della bambina che divenne un bambino 346
Il caso del gemello che perse il pene 347
QUESTI CASI ECCEZIONALI CONFERMANO LA REGOLA? 348
Effetti degli ormoni gonadici sugli adulti 348
Comportamento sessuale maschile e testosterone 348
Il caso dell’uomo che ha perso e riacquistato la sua “virilità” 349
Comportamento sessuale femminile e ormoni gonadici 349
Abuso di steroidi anabolizzanti 350
Meccanismi cerebrali del comportamento sessuale 352
Quattro strutture cerebrali associate all’attività sessuale 352
CORTECCIA CEREBRALE E ATTIVITÀ SESSUALE 352
• IPOTALAMO E ATTIVITÀ SESSUALE 352
• AMIGDALA E ATTIVITÀ SESSUALE 353
• STRIATO VENTRALE E ATTIVITÀ SESSUALE 354
Orientamento sessuale e identità di genere 354
Orientamento sessuale 354
GENI E ORIENTAMENTO SESSUALE 354
• ORIENTAMENTO SESSUALE E ORMONI PRECOCI 355
Che cosa innesca la comparsa dell’attrazione sessuale durante lo sviluppo? 355
C’è differenza tra i cervelli delle persone omosessuali ed eterosessuali? 355
Identità di genere 356
Indipendenza dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere 356
Riassunto dei temi affrontati 357
14 - SONNO, SOGNI E RITMI CIRCADIANI 359
Il caso della donna che non dormiva 361
Stadi del sonno 362
Le tre misure psicofisiologiche standard del sonno 362
I tre stadi elettroencefalografici del sonno 362
Attività onirica 363
SONNO REM E ATTIVITÀ ONIRICA 363
• VERIFICA DELLA VALIDITÀ DI ALCUNE CONVINZIONI COMUNI RELATIVE AI SOGNI 364
• INTERPRETAZIONE DEI SOGNI 364
Perché dormiamo? E perché lo facciamo quando lo facciamo? 365
I due tipi di teorie sul sonno 365
Analisi comparativa del sonno 365
Effetti della deprivazione del sonno 366
Interpretazione degli effetti della deprivazione del sonno: il problema dello stress 366
Previsioni delle teorie recuperative in merito alla deprivazione del sonno 367
Due classici casi di studio riguardanti la deprivazione del sonno 367
Il caso degli studenti deprivati del sonno 367
Il caso di Randy Gardner 367
Studi sperimentali sulla deprivazione del sonno nell’uomo 367
Studi di deprivazione del sonno negli animali da laboratorio 369
Deprivazione del sonno REM 369
La deprivazione del sonno aumenta l’efficienza del sonno 370
Cicli circadiani del sonno 372
Ritmi circadiani 372
Cicli circadiani sonno-veglia free-running 372
Jet lag e lavoro a turni 373
Un orologio circadiano nei nuclei soprachiasmatici 373
Meccanismi nervosi della sincronizzazione dei ritmi circadiani 374
Genetica dei ritmi circadiani 375
Le quattro aree del cervello coinvolte nel sonno 375
Le due aree dell’ipotalamo coinvolte nel sonno 375
Il caso di Constantin von Economo, l’acuto neurologo 376
La formazione reticolare e il sonno 376
Nuclei reticolari del sonno REM 377
Farmaci che influenzano il sonno 379
Farmaci ipnotici 379
Farmaci antipnotici 379
Melatonina 380
Disturbi del sonno 381
Insonnia 381
Il signor B., un caso di insonnia iatrogena 381
Ipersonnia 382
Disturbi correlati al sonno REM 383
Il caso del paziente che, durante
il sonno, superò un placcaggio 383
Effetti della riduzione a lungo termine del sonno 384
Differenze tra brevi e lunghi dormitori 384
Riduzione a lungo termine del sonno notturno 384
Riduzione a lungo termine del sonno attraverso il suo frazionamento 385
Effetti di una minore quantità di sonno sulla salute 385
Riduzione a lungo termine del sonno: un caso di studio personale 386
Il caso dell’autore che ridusse le sue ore di sonno 386
Riassunto dei temi affrontati 387
15 - USO DI DROGA, TOSSICODIPENDENZA E I CIRCUITI CEREBRALI DELLA RICOMPENSA 389
Il caso degli insegnanti delle scuole superiori drogati 390
Principi fondamentali dell’azione delle droghe 391
Somministrazione, assorbimento e ingresso
nel sistema nervoso centrale 391
INGESTIONE ORALE 391
• INIEZIONE 391 • INALAZIONE 391
• ASSORBIMENTO ATTRAVERSO LE MUCOSE 391
Azione, metabolismo ed eliminazione delle droghe 391
INGRESSO DELLE DROGHE NEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 391
• MECCANISMO DI AZIONE DELLE DROGHE 391
• METABOLISMO ED ELIMINAZIONE DELLE DROGHE 392
Assuefazione alla droga, effetti dell’astinenza e dipendenza fisica 392
ASSUEFAZIONE ALLA DROGA 392
• EFFETTI DELL’ASTINENZA E DIPENDENZA FISICA 392
La dipendenza dalle droghe: cos’è? 393
Il ruolo dell’apprendimento nell’assuefazione alla droga 394
Assuefazione contingente alla droga 394
Assuefazione condizionata alla droga 395
RIFLESSIONI SUL CONDIZIONAMENTO ALLA DROGA 396
Cinque droghe usate comunemente 396
Il tabacco 397
L’alcool 397
La marijuana 399
La cocaina e altre sostanze stimolanti 401
Gli oppioidi: eroina e morfina 402
Confronto dei pericoli per la salute di droghe comunemente utilizzate 404
Analisi dei rischi per la salute provocati dalle droghe 404
Confronto dei pericoli del tabacco, dell’alcool, della marijuana, della cocaina e dell’eroina 405
Le prime ricerche psicobiologiche sulla dipendenza 406
Dipendenza fisica e prospettiva dell’incentivo positivo nella dipendenza 406
L’autostimolazione intracranica e il sistema dopaminergico mesotelencefalico 407
Le prime prove del coinvolgimento della dopamina nella tossicodipendenza 408
Il nucleo accumbens e la dipendenza dalla droga 408
Gli approcci più recenti ai meccanismi di dipendenza 409
Tre fasi nello sviluppo di una dipendenza 410
PARTE VI - DISTURBI COGNITIVI ED EMOTIVI
16 - LATERALIZZAZIONE EMISFERICA, LINGUAGGIO E SPLIT BRAIN 416
Lateralizzazione cerebrale delle funzioni: introduzione 419
Scoperta degli specifici effetti del danno all’emisfero sinistro nell’afasia e nell’aprassia 419
Test per la lateralizzazione cerebrale 419
TEST DELL’AMITAL SODICO 419
• TEST DELL’ASCOLTO DICOTICO 420
• NEUROIMAGING FUNZIONALE 420
Scoperta della relazione tra lateralizzazione del linguaggio e preferenza manuale 420
Differenze di genere nella lateralizzazione cerebrale 420
Split-brain 421
Il rivoluzionario esperimento di Myers e Sperry 421
Commissurotomia in soggetti umani con epilessia 423
Evidenza a sostegno che gli emisferi di pazienti split-brain possono funzionare in modo indipendente 424
Suggerimento crociato (cross-cuing) 425
Fare due cose alla volta 425
La lente Z 426
Doppio funzionamento mentale e il conflitto nei pazienti split-brain 427
Il caso di Peter, il paziente split-brain tormentato dal conflitto 427
Indipendenza degli emisferi divisi: prospettiva attuale 427
Differenze tra l’emisfero sinistro e l’emisfero destro 428
Esempi di lateralizzazione cerebrale delle funzioni 428
SUPERIORITÀ DELL’EMISFERO SINISTRO NEL
CONTROLLO DEL MOVIMENTO IPSILATERALE 429
• SUPERIORITÀ DELL’EMISFERO DESTRO NELLE ABILITÀ SPAZIALI 429
• SPECIALIZZAZIONE DELL’EMISFERO DESTRO PER LE EMOZIONI 429
• LA SUPERIORITÀ DELL’EMISFERO DESTRO NELL’ABILITÀ MUSICALE 429
• DIFFERENZE EMISFERICHE NELLA MEMORIA 430
• L’EMISFERO SINISTRO INTERPRETE 430
Che cos’è lateralizzato: un grande insieme di abilità o singoli processi cognitivi? 430
Asimmetrie anatomiche del cervello 431
Prospettiva evolutiva della lateralizzazione cerebrale e linguaggio 432
Teorie dell’evoluzione della lateralizzazione cerebrale 432
TEORIA ANALITICO-SINTETICA 432
• TEORIA MOTORIA 433
• TEORIA LINGUISTICA 433
Il caso di W.L., l’uomo con afasia
per il linguaggio dei segni 433
Quando si è evoluta la lateralizzazione cerebrale? 433
Quali sono i vantaggi per la sopravvivenza di una lateralizzazione cerebrale? 433
Evoluzione del linguaggio umano 434
COMUNICAZIONE VOCALE IN PRIMATI NON UMANI 434
• LA TEORIA MOTORIA DELLA PERCEZIONE DEL LINGUAGGIO 434
• LINGUAGGIO GESTUALE 435
Localizzazione corticale del linguaggio: il modello Wernicke-Geschwind 436
Gli antecedenti storici del modello Wernicke-Geschwind 436
Il modello Wernicke-Geschwind 437
Modello Wernicke-Geschwind: la dimostrazione 438
Effetti di un danno corticale e della stimolazione cerebrale sulle abilità di linguaggio 438
EVIDENZE DAGLI STUDI DEGLI EFFETTI DEL DANNO CORTICALE 439
• EVIDENZE DAGLI STUDI DI NEUROIMAGING FUNZIONALE 439
• EVIDENZE DAGLI STUDI DI STIMOLAZIONE ELETTRICA DELLA CORTECCIA 440
Stato attuale del modello Wernicke-Geschwind 442
Neuroscienze cognitive del linguaggio 442
Tre premesse che definiscono l’approccio delle neuroscienze cognitive al linguaggio 443
Neuroimaging funzionale e localizzazione del linguaggio 443
GLI STUDI DI BAVELIER SULLA LETTURA ATTRAVERSO L’USO DELLA RMF 443
• GLI STUDI DI DAMASIO SULLA DENOMINAZIONE ATTRAVERSO L’USO DELLA PET 444
Neuroscienze cognitive della dislessia 445
Dislessia evolutiva: cause e meccanismi neurali 445
Dislessia evolutiva e cultura 445
Neuroscienze cognitive della dislessia profonda e superficiale 446
Il caso di N.I., la donna che leggeva con l’emisfero destro 447
Riassunto dei temi affrontati 447
17 - PSICOBIOLOGIA DELLE EMOZIONI, DELLO STRESS E DELLA SALUTE 449
La paura: il lato oscuro delle emozioni Psicobiologia delle emozioni: introduzione 450
Le prime pietre miliari nella ricerca psicobiologica sulle emozioni 450
Lo strabiliante caso di Phineas Gage 450
LA TEORIA DI DARWIN SULL’EVOLUZIONE DELLE EMOZIONI 451
• LE TEORIE DI JAMES-LANGE E CANNONBARD 452
• FALSA RABBIA 452
• SISTEMA LIMBICO ED EMOZIONI 453
• SINDROME DI KLÜVER-BUCY 453
Un caso umano di sindrome di Klüver-Bucy 454
Emozioni e sistema nervoso autonomo 454
SPECIFICITÀ EMOTIVA DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO 454
• POLIGRAFIA 454
Emozioni ed espressioni facciali 455
UNIVERSALITÀ DELLE ESPRESSIONI FACCIALI 455
• ESPRESSIONI FACCIALI PRIMARIE 455
• IPOTESI DEL FEEDBACK FACCIALE 455
• CONTROLLO VOLONTARIO DELL’ESPRESSIONE FACCIALE 455
• ESPRESSIONI FACCIALI: PROSPETTIVE ATTUALI 456
Paura, difesa e aggressività 457
Tipi di comportamenti aggressivi e difensivi - Aggressività e testosterone 458
Meccanismi nervosi del condizionamento alla paura 460
Amigdala e condizionamento alla paura 460
Condizionamento contestuale alla paura e ippocampo 460
Complesso dell’amigdala e condizionamento alla paura 461
Meccanismi cerebrali delle emozioni umane 462
Neuroscienze cognitive delle emozioni 462
Amigdala ed emozioni umane 463
Il caso di S.P., la donna che non percepiva la paura 463
Lobi prefrontali mediali ed emozioni umane 463
Lateralizzazione delle emozioni 464
Meccanismi nervosi delle emozioni umane: prospettive attuali 464
Stress e salute 465
La risposta di stress 465
Modelli animali di stress 466
Disturbi psicosomatici: il caso dell’ulcera gastrica 466
Psiconeuroimmunologia: stress, sistema immunitario e cervello 467
SISTEMA IMMUNITARIO INNATO 467
• SISTEMA IMMUNITARIO ADATTIVO 468
• CHE EFFETTO HA LO STRESS SULLA FUNZIONE IMMUNITARIA: DANNOSO O BENEFICO? 468
• IN CHE MODO LO STRESS INFLUENZA LA FUNZIONE IMMUNITARIA? 469
• LO STRESS INFLUENZA LA SUSCETTIBILITÀ ALLE MALATTIE INFETTIVE? 469
Esperienze precoci di stress 470
Stress e ippocampo 470
CONCLUSIONE 471
Il caso di Charles Whitman, il cecchino della Texas Tower 471
Riassunto dei temi affrontati 471
18 - PSICOBIOLOGIA DEI DISTURBI PSICHIATRICI 473
Il cervello sconvolto
Schizofrenia 475
Schizofrenia: il caso di Lena 475
Che cos’è la schizofrenia? 476
Fattori causali nella schizofrenia 476
La scoperta dei primi farmaci antipsicotici 477
Teoria dopaminergica della schizofrenia 477
Schizofrenia: ricerca attuale e trattamento 479
ANTIPSICOTICI ATIPICI 479
• L’INTERESSE RINNOVATO VERSO LE SOSTANZE ALLUCINOGENE 480
• MECCANISMI DEI GENI CORRELATI ALLA SCHIZOFRENIA 480
• SCHIZOFRENIA E ALTERAZIONI NELLA STRUTTURA CEREBRALE 481
Disturbi depressivi 481
Definizione dei disturbi depressivi 481
Il caso di S.B., lo studente di psicobiologia che soffriva di depressione 482
Fattori causali nel disturbo depressivo maggiore 482
Farmaci antidepressivi 483
INIBITORI DELLE MONOAMINO OSSIDASI 483
• ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI 483
• INIBITORI SELETTIVI DELLA RICAPTAZIONE DELLE MONOAMINE 483
• ANTIDEPRESSIVI ATIPICI 483
• AGONISTI DEL RECETTORE NMDA 484
• EFFICACIA DEI FARMACI NEL
TRATTAMENTO DEI DISTURBI DEPRESSIVI 484
Differenze cerebrali nella depressione 484
Teorie della depressione 485
TEORIA MONOAMINERGICA DELLA DEPRESSIONE 485
• TEORIA DELLA NEUROPLASTICITÀ DELLA DEPRESSIONE 485
Trattamento della depressione mediante stimolazione cerebrale 486
STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA 486
• STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA 486
Disturbi bipolari 487
Definizione dei disturbi bipolari 487
Il caso di S.B. rivisitato: lo studente di psicobiologia affetto da disturbo bipolare 487
Fattori causali nei disturbi bipolari 488
Stabilizzanti dell’umore 488
Differenze cerebrali associate ai disturbi bipolari 489
Teorie sui disturbi bipolari 489
Disturbi d’ansia 489
Il caso di M.R., la donna che aveva paura di uscire 490
Quattro disturbi d’ansia 490
Eziologia dei disturbi d’ansia 490
Trattamento farmacologico dei disturbi d’ansia 490
BENZODIAZEPINE 491
• AGONISTI SEROTONINERGICI 491
• FARMACI ANTIDEPRESSIVI 491
Modelli animali dei disturbi d’ansia 491
Basi nervose dei disturbi d’ansia 492
Disturbo di Tourette 492
Il caso di R.G., il ragazzo che abbaiava come un cane 492
Che cos’è il disturbo di Tourette? 493
Basi nervose del disturbo di Tourette 493
Trattamento del disturbo di Tourette 494
Il caso di P.H., il neuroscienziato affetto dal disturbo di Tourette 494
Sperimentazioni cliniche: sviluppo di nuovi farmaci psicoterapeutici 494
Sperimentazioni cliniche: le tre fasi 495
FASE 1: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 495
• FASE 2: DETERMINAZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE 495
• FASE 3: VERIFICA FINALE 496
Aspetti controversi delle sperimentazioni cliniche 496
NECESSITÀ DI UN DISEGNO IN DOPPIO CIECO E DI CONTROLLI TRATTATI CON PLACEBO 496
• NECESSITÀ DI UN PLACEBO ATTIVO 496
• QUANTITÀ DI TEMPO RICHIESTA 496
• ASPETTI ECONOMICI 497
• TARGET DELLA PSICOFARMACOLOGIA 497
Efficacia delle sperimentazioni cliniche 497
CONCLUSIONE 498
Conclusione del caso di S.B.: lo studente di psicobiologia che prese il controllo della situazione 498
Riassunto dei temi affrontati 499
• Parole chiave 499 |