Perchè la sessualità?
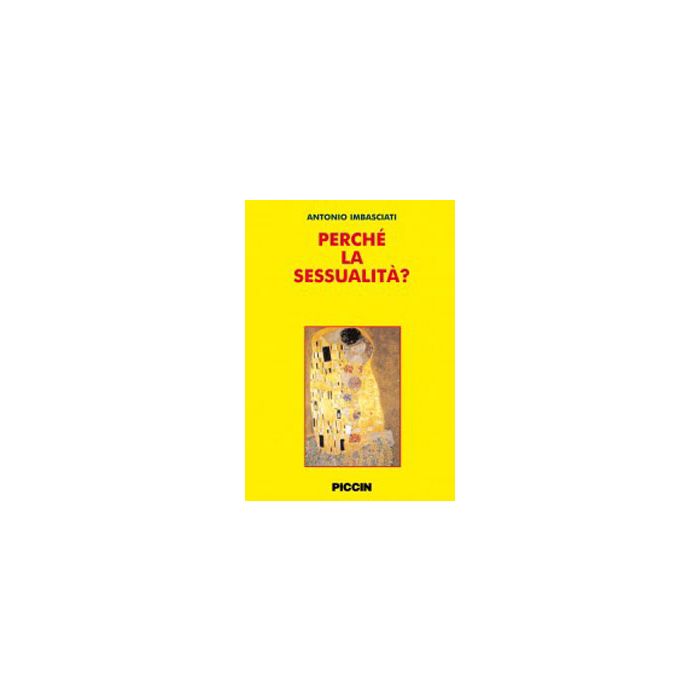
- ISBN/EAN
- 9788829920624
- Editore
- Piccin Editore
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2010
- Pagine
- 216
Disponibile
20,00 €
Sulla sessualità e sull’amore si è scritto fin da quando si è inventata qualche forma di scrittura. Ancor prima l’homo sapiens ha voluto raffigurarli, già in qualche incisione rupestre, poi con lo sviluppo delle arti plastico-figurative, e ha sentito il bisogno di celebrarlo, nel canto, nella danza, nella poesia; di regolamentarlo negli ordinamenti sociali e nelle religioni, in alcune per esaltarlo in tutte le sue forme. L’argomento sembra aver occupato la mente dell’uomo in modo pregnante e continuativo. Perché? Per la semplice sopravvivenza inerente la riproduzione della specie? Una volta che l’homo sapiens poté ben conoscerla e prendersene controllo e cura, perché mai ha continuato a parlarne, scrivere, fantasticare, legiferare? Istinto iscritto nella specie? A maggior ragione, se fosse stato istinto, come tale predeterminato, perché mai l’argomento avrebbe dovuto interessare e preoccupare proprio la parte più sapiens del genere umano? Si può invocare la complessità, l’ambivalenza e l’opacità degli affetti che vi si muovono: ma in che cosa ciò consiste? Come in ogni civiltà, fino ai giorni nostri sulla sessualità, e sull’amore, è stato e tuttora viene scritto un mare di letteratura: da quella romanzesca, a quella poetica, a quella pornografica, a quella scientifica. In quest’ultima ci si aspetterebbe serietà e chiarezza: tutt’altro. Le scienze che si arrogano spesso esclusivamente, il marchio doc della scientificità, ovvero quelle medico-biologiche, presentano produzioni tutt’altro che omogenee, ma soprattutto riduttive: genetica e biologia poco ci dicono su quell’umano che su questo tema sembra aver occupato, affascinato e preoccupato la mente delle persone. Medicina e fisiologia si limitano a dirci come funzionano gli organi genitali, o come dovrebbero; e quando qualche persona ne patisce (= paziente), più che indagarne le ragioni originarie, cercano di correggere il funzionamento degli organi, trascurando proprio la “persona”. Le neuroscienze e la psicologia sperimentale hanno ampiamente dimostrato come tutte le manifestazioni sessuali dipendano dal S.N.C., cioè dal neuropsichico: tuttavia perdura l’idea, oggi ancor più di ieri, che la sessualità umana sia questione di organi, come per il fegato o lo stomaco. Perché mai tale resistenza ad accettare la scienza in questo campo? D’altra parte in altre scienze, come in sociologia, in antropologia e soprattutto nelle varie scienze psicologiche, abbiamo una congerie di contributi, quasi sempre settoriali, in cui spesso, con la scusa della divulgazione si slitta nel pettegolezzo seduttivo, se non nella ciarlataneria reclamistica. Lungo il mio percorso scientifico, ormai verso la sua fine, ho scritto alcune decine di saggi sulla sessualità: tra questi tre dei miei volumi sono stati interamente dedicati al tema (cfr. www.imbasciati.it). La mia duplice formazione di psicoanalista e di psicologo sperimentalista, e anche le mie origini mediche, mi hanno permesso di constatare, sia l’enormità dei problemi di vario ordine all’argomento connessi, sia il caos di molta letteratura scientifica. Gran parte della suddetta congerie è dovuta ad una malintesa necessità di dare una risposta chiara e rapida: questo si traduce in una parcellizzazione dei problemi e in un riduzionismo metodologico per trovare subito una risposta univoca. Vale la pena dunque porsi un perché. Al di là delle considerazioni ingenue, questo “perché” promette ancor oggi così tanti sviluppi che rispondervi subito sarebbe una disgrazia: un arresto della Ricerca della mente dell’homo sapiens. Recentemente la letteratura psicologico-sperimentale sull’Attaccamento sembra raccogliere e favorire un’integrazione tra le varie metodologie sperimentali e i rilievi clinici, soprattutto psicoanalitici. Le ipotesi teoriche della psicoanalisi sono state d’altra parte largamente riformulate. Ancor più recentemente le neuroscienze, la neuropsicoanalisi in particolare, e in genere lo studio del cervello emotivo e delle capacità relazionali, sembrano promettere maggiori conoscenze. In questo quadro, col presente testo ho scelto stralci di miei lavori degli ultimi lustri per collegarli ai più recenti contributi della Psicologia Clinica Perinatale e delle Neuroscienze della Relazione in un unico filo conduttore, che dimostri la complessa evoluzione della ricerca scientifica in questo campo. Molti interrogativi rimangono aperti ed altri ne ho proposti, in ipotesi antropologiche concernenti il futuro dell’umanità. Il volume è indirizzato in primo luogo agli specialisti dell’argomento, i sessuologi, agli psicologi clinici che vi fanno ricerca e a quelli che professionalmente si trovano a fronteggiarlo, nonché ai medici, che su questi temi, ancorché non aggiornati sono di fatto i consulenti più frequenti. Pur attenendomi a rigorosità scientifica, ho curato un’esposizione chiara, accessibile a qualunque pubblico colto: credo pertanto che il libro, nella sua visione interdisciplinare, possa essere utilizzato da tutti coloro che operano nel campo dell’educazione, della salute, dei servizi sociali, nonché da chi voglia a livello personale documentarsi su propri problemi, o più ancora da chi, pensando ai propri figli nella società attuale, ne abbia a cuore un loro sano sviluppo. Brescia, Dicembre 2009 Antonio Imbasciati
Maggiori Informazioni
| Autore | Imbasciati Antonio |
|---|---|
| Editore | Piccin Editore |
| Anno | 2010 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Capitolo 1 DOVE E COME CERCARE IL PERCHÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1 Istinto?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Apprendimento primario? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Capitolo 2 MASCHIO E FEMMINA ALLE ORIGINI DELL’HOMO SAPIENS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.1 Sesso e potere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2 Il pregiudizio androcentrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.3 Lo stupro primordiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.4 Civiltà matriarcali e civiltà patriarcali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.5 L’evoluzione della donna acquatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.6 L’aggressività nel sesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.7 Preistoria delle specie e preistoria della mente. . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.8 Guerra tra i sessi o dialettica?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Capitolo 3 DALLA PSICOANALISI BIOLOGISTICA ALLO STUDIO DELLO SVILUPPO COGNITIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.1 La vis a tergo freudiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.2 Il corpo apprende per la mente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Capitolo 4 LA COMUNICAZIONE EROTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.1 Amore o seduzione? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.2 La seduzione come promessa di piacere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.3 Lo studio psicoanalitico della dimensione simbolica . . . . . . . . . . . 49 4.4 Il piacere come significante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4.5 Decodifica della comunicazione erotica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Capitolo 5 IL PIACERE SESSUALE: UNA COSTRUZIONE DELLA MENTE EMOTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5.1 Sessualità e piacere come costrutti mentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5.2 Percezione ed emozione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 5.3 Percezione, emozione, affetto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5.4 Emozione e percezione come elaborazioni di informazioni. . . . . . 70 5.5 Sessualità: percezione o emozione? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 5.6 La “qualità erotica”: elaborazione di informazioni e attribuzione di significato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 5.7 Reificazione del piacere come difesa dall’emozione erotica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 5.8 Il piacere come epifenomeno cosciente di processi inconsci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 5.9 Un paradosso per la percezione degli effetti somatici dell’emozione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Capitolo 6 L’AMBIGUO LINGUAGGIO DELL’EROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 6.1 La comunicazione erotica e la sua possibile bugia. . . . . . . . . . . . . 91 6.2 La seduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6.3 Il piacere: significato, significante, referente . . . . . . . . . . . . . . . . 100 6.4 Simbolopoiesi, creatività e perversione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6.5 Piacere e bugia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6.6 Quale decodifica della comunicazione erotica? . . . . . . . . . . . . . . 119 6.7 Un futuro dell’Eros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 6.8 Il significante olfattivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Capitolo 7 ATTACCAMENTO E SESSUALITÀ: RAPPRESENTAZIONE, FANTASMI, OGGETTI INTERNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 7.1 Gli apprendimenti precoci nell’attaccamento . . . . . . . . . . . . . . . . 135 7.2 La fantasmatica relazionale nell’attaccamento e nella sessualità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 7.3 Dal fantasma all’engramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 7.4 Engramma e oggetto interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 7.5 Simbolopoiesi e sessualità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 7.6 Fare un figlio: il fantasma della generatività . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Capitolo 8 QUALE SESSUOLOGIA? A CHE SERVIRÀ LA SESSUALITÀ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 8.1 La sessualità nella cultura sanitaria italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 8.2 Perché l’etero-sessualità? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 8.3 La buona sessualità e le cosiddette disfunzioni sessuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 8.4 La sessualità come emozione negata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 8.5 L’ottimalità sessuale della coppia come prognosi della capacità di allevamento dei figli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 8.6 Intesa amorosa, intesa amorevole, transgenerazionalità. . . . . . . . 179 |
Questo libro è anche in:
