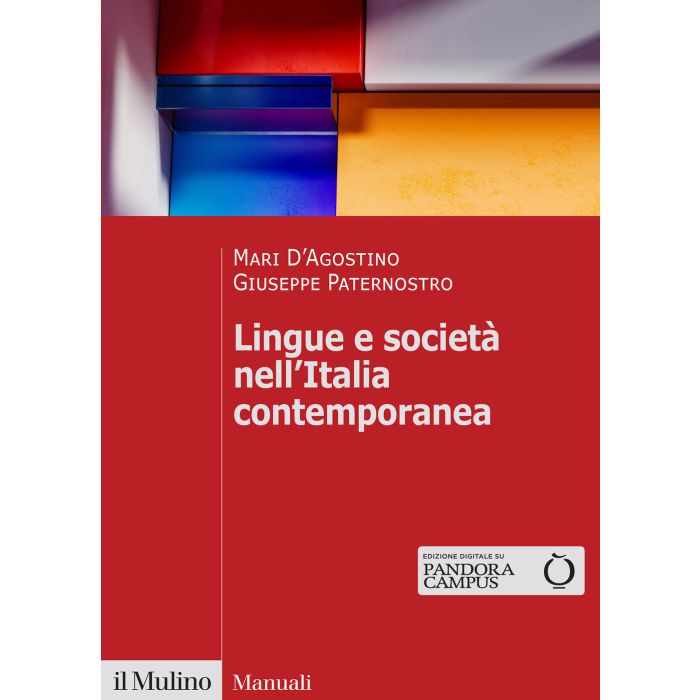PARTE PRIMA. L'ITALIANO, GLI ITALIANI, GLI ITALOFONI
I. La nascita dello Stato nazionale
1. Nazione, lingue, popolo
2. Le molte Italie: economia, istruzione, idiomi
3. «Una d’arme, di lingua, d’altare»?
4. Quanti dialetti, quante altre lingue
5. Che cos’è una lingua? Che cos’è un dialetto?
II. L’italiano e la sua diffusione
1. Una questione complessa: quanti italiani erano italofoni nel 1861?
2. L’istruzione: una questione nazionale
3. La burocrazia e l’esercito del nuovo Stato
4. La stampa periodica e il suo pubblico
5. Uomini e donne in movimento
6. Le guerre: dalla Libia alla Prima guerra mondiale
7. Un italiano scritto di massa?
8. Apprendere una lingua
III. Il fascismo e la nascita della comunicazione di massa
1. Il fascismo e la sua politica linguistica
2. Strumenti di comunicazione (orale) di massa: la radio e il cinema
3. La guerra totale e le lingue altre
4. Politiche linguistiche, pianificazione dall’alto, spinte dal basso
PARTE SECONDA. LINGUE, DEMOCRAZIE, EGUAGLIANZA
IV. La ripresa della vita politica e la Costituzione
1. La riorganizzazione della vita politica
2. La Costituzione tra forma e sostanza
3. L’italiano e le minoranze linguistiche storiche
4. Diritti linguistici: lingue, comunità, parlanti, storia
V. L’Italia in movimento. Persone, territori, lingue
1. Il doppio volto dell’Italia negli anni Cinquanta-Settanta
2. La scuola: obblighi e diseguaglianze
3. Ascoltare e leggere fuori dalle aule scolastiche
4. Il repertorio linguistico: testi, numeri, pratiche, emozioni
VI. L’Italia cambia, cambiamo l’Italia
1. La scuola per Gianni e per i «fuori norma»
2. L’italiano per includere: la comunicazione pubblica
3. Genere e lingua: fra sessismo e nuove minoranze
4. Diritti linguistici, fra moltiplicazione, modelli teorici e pratiche
VII. Nuove connessioni, migrazioni transnazionali e vecchie diseguaglianze
1. L’Italia in rete
2. I «nuovi italiani»: fra risorsa e povertà
3. L’istruzione: un confronto internazionale
4. Apprendere più lingue
VIII. Che lingue parliamo? Un quadro quantitativo
1. Le inchieste linguistiche autovalutative
2. Parlare italiano e/con dialetto
3. Parlare altre lingue
4. L’Italia linguistica in numeri: un quadro riassuntivo
5. La gerarchia delle lingue: diglossia, dilalia
IX. L’Italia delle altre lingue
1. Multilinguismo e plurilinguismo fra vecchie e nuove minoranze
2. L’Alto Adige: un bilinguismo bi-comunitario
3. La Valle d’Aosta: un bilinguismo mono-comunitario
4. Timau: un’isola linguistica trilingue
5. Fra due lingue di partenza e due di arrivo: i tunisini a Mazara
6. Vitalità e morte delle lingue
X. Diseguaglianze e povertà: sociale, educativa, linguistica
1. Quante parole conosce l’operaio? Quante il bambino afro-americano?
2. Disparità sociale, fallimento scolastico e modelli della sociolinguistica in USA
3. Misurare la povertà
4. Storia linguistica e povertà educativa
PARTE TERZA. MODELLI, PRATICHE, METODI
XI. L’Italia linguistica contemporanea: stereotipi, persistenze, nuovi paradigmi
1. Dinamiche in corso nello spazio linguistico dell’Italia contemporanea
2. Le lingue come strumento di contesa politica
3. L’italiano della politica: dal paradigma della superiorità al paradigma del rispecchiamento
4. Lingua toscana in bocca roman(esc)a
5. Gli stereotipi nel dibattito pubblico sulle lingue
6. Una lingua in movimento
XII. Variazione, contatto, passaggi di codice
1. Premessa
2. I modelli variazionisti
2.1. Il modello basato sulla «variabile»
2.2. Il congiuntivo come variabile sociolinguistica?
2.3. Il modello centrato sulle «varietà»
3. Contatti fra lingue e parlanti
3.1. Dialetto e italiano in contatto
3.2. Passaggi di codice e mescolamenti
4. Dalla lingua al languaging
XIII. Testo e discorso: scritto, parlato e digitato
1. Testo e discorso: sinonimia o dicotomia?
1.1. Definizione di «testo»
1.2. I criteri di buona formazione di un testo
1.3. Contesto/contesti
1.4. Tipi e generi testuali
2. Scritto e parlato
2.1. Scritto/parlato fra vicinanza e distanza comunicativa
XIV. L’italiano diffuso: cinema, radio e televisione
1. Mass media e italiano parlato
2. L’italiano al cinema
3. L’italiano alla radio
4. L’italiano alla televisione
XV. Italiano e dialetto: una nuova (pacifica?) convivenza
1. I dialetti italiani: dalla morte (intravista) alla «risorgenza» (iniziata?)
2. Il dialetto fra vecchi e nuovi usi
2.1. Dialetto e cinema
2.2. Dialetto e canzone
2.3. Dialetto e pubblicità
2.4. Dialetto in rete
XVI. Un nuovo italiano scritto di massa: l’italiano digitale
1. Dallo scritto al digitato
2. Un nuovo concetto di «comunità»
3. Nuove testualità, nuovi generi, nuovi usi?
4. Verso una nuova nozione di «testo (scritto)»?
5. La co-costruzione del testo scritto digitale
6. Interagire, co-costruire, comprendere, fraintendere
7. Il plurilinguismo in rete
XVII. Multilinguismi/plurilinguismi: pratiche, politiche, rappresentazioni
1. Dall’Italia «una d’arme, di lingua e di altare» all’Italia dei multilinguismi/plurilinguismi
2. Sguardi plurali contro modelli globalizzanti
3. L’Italia multilingue delle grandi aree urbane
4. Comunità, lingue e spazi multilingui nel rap dei «nuovi italiani»
5. Capirsi sotto un baobab o su Meet
6. La svolta multilingue a scuola
XVIII. Costruire, osservare, documentare
1. Parlanti, lingue, pratiche sociali
2. Pratiche e dati linguistici
3. Registrazione e videoregistrazione
4. Trascrivere il parlato
4.1. La trascrizione conversazionale
4.2. La trascrizione fonetica
5. L’etica della ricerca
Riferimenti bibliografici
Indice analitico
Indice dei nomi |