L'espropriazione per pubblica utilità e i provvedimenti ablatori
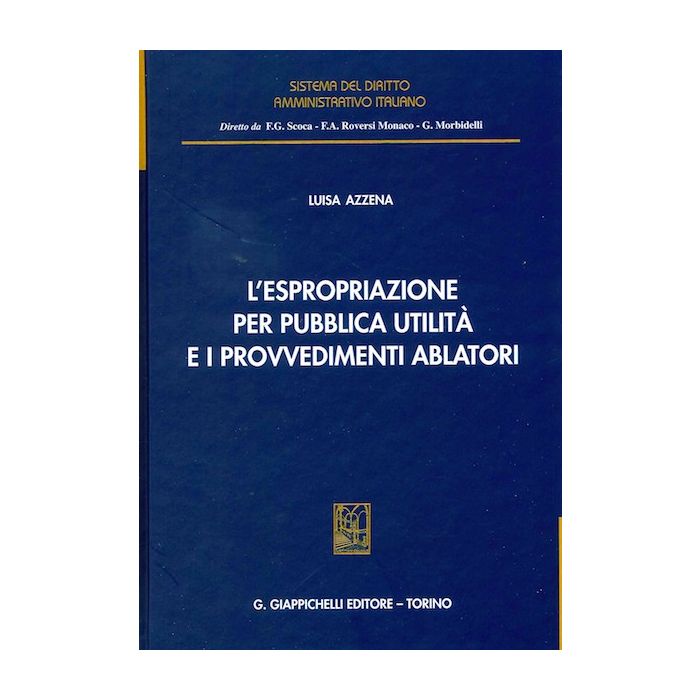
- ISBN/EAN
- 9788892140028
- Editore
- Giappichelli
- Collana
- Sistema del diritto amministrativo italiano
- Formato
- Libro rilegato
- Anno
- 2021
- Pagine
- 416
Disponibile
54,00 €
PRESENTAZIONE
L’espropriazione per pubblica utilità, per la sua immanenza al diritto
di proprietà e alla sua stessa concezione, costituisce da sempre uno spec-
chio dell’evoluzione, non solo giuridica, ma anche economica, sociale,
politica dell’ordinamento. È istituto nel quale confluiscono le esigenze
mutevoli, i valori diversi di ogni momento storico; in esso si esprime la
sintesi tra le varie tensioni, riconducibili, in definitiva, con qualche ap-
prossimazione, ad una sola: quella della perenne ricerca di un equilibrio
tra l’interesse della collettività e quello del privato proprietario.
Concetto enunciato a chiare lettere in Costituzione: della proprietà la
legge “determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale”, ammettendone l’espropriazione “per mo-
tivi di interesse generale”. Non diversamente, lo Statuto albertino preve-
deva che la proprietà dovesse essere ceduta quando “l’interesse pubblico
legalmente accertato”, lo esigesse.
L’interesse per l’espropriazione è perciò sempre attuale e, si potrebbe di-
re, “trascendente”, andando oltre quello per l’istituto in sé, involvendo quel-
lo per l’ordinamento giuridico e per la realtà sociale nel quale si colloca.
Quella dell’istituto è la storia stessa dell’idea di Stato e della forma da
questo assunta, quali sono andate sviluppandosi nell’esperienza dell’ordi-
namento italiano. Del quale, sin dall’unificazione del Regno, l’espropria-
zione ha sempre significativamente riflesso i caratteri, nell’evoluzione del-
lo stato liberale così come nell’affermazione dello stato sociale e nelle vi-
cende della sua attuazione, nonché in quelle, più recenti, dell’integrazio-
ne sovranazionale europea.
Ed invero, nel tempo, l’istituto dell’espropriazione si è evoluto, ade-
guandosi ai diversi momenti storici, chiamato a rispondere a esigenze di-
verse, nell’alternarsi di periodi di crescita economico-sociale e di crisi.
Lo sviluppo dell’urbanistica, in particolare, ha inciso profondamente
sulla morfologia dell’istituto, da un lato, consentendone la razionalizza-
zione, ma, dall’altro, rendendo più aspro il conflitto tra l’interesse pub-
blico e quello privato. Conflitto aggravato ulteriormente, e reso pressoché
irriducibile, dalla funzionalizzazione del diritto di proprietà e dal potere
conformativo attribuito al legislatore. Le difficoltà poste dal tema dei li-
miti alla proprietà e, per converso, al potere del legislatore nel definirli,
delineandone lo statuto, ne costituiscono riprova.
Con il passare degli anni, il susseguirsi di interventi normativi partico-
lari e spesso derogatori rispetto alla disciplina contenuta nella legge fon-
damentale del 1865 ha “frantumato” la disciplina dell’istituto, aprendo
grandi spazi al sostanziale contributo pretorio dei giudici.
La giurisprudenza, prima solo nazionale (specialmente della Corte di
Cassazione e del Consiglio di Stato, cui si è affiancata, con un apporto
decisivo, dopo la sua istituzione, la Corte costituzionale) poi anche so-
vranazionale (specie della Corte Edu), ha svolto, in questo ambito più che
in altri, un fondamentale ruolo, di interprete, spesso ai limiti della crea-
zione, del sistema normativo, talvolta vanificando le scelte legislative e
contestualmente esercitando una funzione di “supplenza” nei confronti
delle lacune normative venutesi a creare anche per effetto delle stesse pro-
nunce giudiziarie.
Né è da sottovalutarsi il ruolo della dottrina, che, spinta nel momento
post-costituzionale dall’esigenza di studiare le nuove categorie imposte
dalla forma di stato sociale che necessitava di affermarsi e, successiva-
mente, da quella di dare ad essa concreta attuazione, ha offerto, in un di-
battito tra i più interessanti, importanti riflessioni.
L’attenzione della giurisprudenza e degli studiosi si è appuntata so-
prattutto, da un lato, sulla vexata quaestio della determinazione dell’in-
dennità di esproprio (in relazione alla quale è evidente la sottostante dia-
lettica ideologica tra le due visioni, sociale e liberale, della proprietà), dal-
l’altro, sulla caratterizzazione e delimitazione dell’istituto, che alla giuri-
sprudenza deve la sua genesi, dell’occupazione acquisitiva (o espropria-
zione “illegittima”).
Entrambe questioni che, più di altre, hanno risentito di un approccio
spesso ideologicamente orientato che, nella ricerca del contemperamento
tra l’interesse della collettività e quello del privato proprietario, ha deter-
minato l’instabilità della disciplina e, in alcuni momenti, un vero e pro-
prio svilimento del diritto di proprietà.
Al quale, con riferimento al problema della determinazione dell’in-
dennità di esproprio, ha solo in parte posto rimedio l’intervento della
Corte costituzionale, con l’affermazione dell’esistenza di un “contenuto
minimo” del diritto di proprietà, al quale hanno però fatto seguito insod-
disfacenti tentativi del legislatore di individuare un ristoro per il sacrifi-
cio imposto al proprietario che fosse “serio” e “non meramente irrisorio”.
Del pari insoddisfacenti si sono rivelati inevitabilmente gli esiti dello
sforzo profuso al fine di dotare di coerenza la disciplina di un istituto,
quale l’occupazione acquisitiva, illegittimo per sua stessa genesi.
Se, nel 2001, con l’emanazione del testo unico, tali questioni, e in ge-
nere la materia espropriativa, sembravano aver finalmente trovato una si-
stemazione stabile e organica, la costituzionalizzazione, nel medesimo
anno, del principio della prevalenza del diritto sovra e internazionale su
quello interno, ne ha subito imposto la ridefinizione.
In particolare, la protezione della proprietà predisposta dalla Cedu, as-
sicurata dagli interventi del giudice Edu e quindi della nostra Corte costi-
tuzionale, ha costretto a rivedere la disciplina appena predisposta dal te-
sto unico, sia con riferimento ai criteri indennitari che all’occupazione
“sanante”, istituto introdotto al fine di legalizzare le fattispecie illegitti-
me, imponendo una rinnovata riflessione sulla proprietà privata quando
non anche sulla stessa forma di stato sociale.
Meno sensibili all’evoluzione dell’ordinamento, e perciò (a causa o in
conseguenza di ciò) oggetto di minore attenzione da parte degli studiosi e
dello stesso Costituente, gli altri provvedimenti ablatori, diversi dall’e-
spropriazione ma al pari di essa incidenti sulla proprietà, sono stati an-
ch’essi oggetto dell’intervento “conformativo” del giudice europeo (in par-
ticolare l’istituto della confisca), il quale ha evidenziato come anche ad
essi occorra guardare nella anzidetta prospettiva del ripensamento del di-
ritto di proprietà e dei suoi limiti nell’ottica sovranazionale.
Per tali motivi, uno studio dedicato alla disciplina attuale dell’espro-
priazione per pubblica utilità, istituto che un tempo apparteneva all’es-
senza profonda dell’ordinamento statale, di cui rifletteva gli orientamenti
sociali, non può che essere condotto nella diversa, e più ampia, prospetti-
va dell’interazione tra fonti (e giudici) nazionali e sovranazionali.
E se davanti a questo radicale mutamento taluno in dottrina si è mostra-
to preoccupato per la sovrapposizione della visione europea del diritto di
proprietà, considerato (come già nell’ordinamento statutario) diritto in-
violabile dell’uomo, a quella adottata dalla nostra Costituzione, che lo in-
serisce invece nell’ambito dei “Rapporti economici”, altri, al contrario, ha
guardato con favore agli interventi del giudice Edu, che hanno consentito
di rimediare all’eccessivo sacrificio che la legislazione italiana aveva im-
posto ai proprietari, in nome di ragioni di interesse pubblico non sempre
meritevoli di tutela. Ciò che, con riferimento alle fattispecie acquisitive o-
riginate da un illecito dell’amministrazione, pare difficilmente confutabile.
Ad ogni modo, i recenti sviluppi giurisprudenziali e normativi eviden-
ziano come il quadro ordinamentale in cui il tema della tutela della pro
Maggiori Informazioni
| Autore | Azzena Luisa |
|---|---|
| Editore | Giappichelli |
| Anno | 2021 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | Sistema del diritto amministrativo italiano |
| Lingua | Italiano |
| Larghezza | 0 |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
