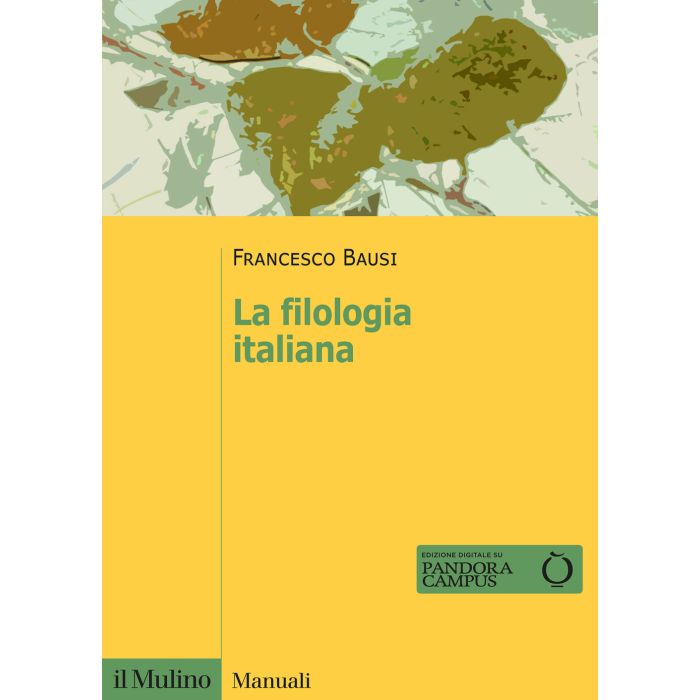I. Il testo nel tempo
1. La trasmissione testuale
2. La tradizione
2.1. Le diverse tipologie di tradizione
2.2. I testimoni
3. Innovazioni di trasmissione (e d’autore)
3.1. L’errore
3.2. Incertezza dell’errore
3.3. La variante
3.4. Valutazione delle varianti
3.5. Altri tipi di innovazione
II. L’edizione del testo
1. Le tipologie di edizione
2. Edizione come interpretazione
3. L’edizione critica
3.1. Definizione e parti
3.2. La Nota al testo
3.3. L’apparato
3.4. Apparati multipli
3.5. La dialettica fra testo e apparato
4. Utilità dell’edizione critica
III. La filologia della copia
1. Il metodo di Lachmann
1.1. Censimento
1.2. Collatio e recensio
1.3. Approssimazioni all’originale: l’emendatio
1.4. Approssimazioni all’originale: la selezione delle varianti
2. Il metodo di Bédier
3. Lachmannismo sostanziale, bédierismo formale
4. Il testimone unico
5. Altri metodi
IV. I metodi: problemi teorici e limiti applicativi
1. Problemi e limiti del metodo di Lachmann
1.1. La trasmissione degli errori
1.2. L’archetipo
1.3. La contaminazione
1.4. Le varianti d’autore
1.5. Il iudicium
2. Problemi e limiti del metodo di Bédier
2.1. La scelta del «buon manoscritto»
2.2. Errori, varianti, lezioni singolari
2.3. La difesa a oltranza del «buon manoscritto»
2.4. Storicità apparente
V. Dai testi ai metodi: una consapevole empiria
1. Oltre Lachmann e oltre Bédier
2. Lo stemma
2.1. I descripti
3. Scegliere le varianti
3.1. Pesare o contare?
3.2. Quel sottile confine tra iudicium e arbitrio
3.3. Uso (e abuso) della lectio difficilior
4. La congettura
4.1. Se e quando congetturare
4.2. Come congetturare
4.3. La congettura difficilior
4.4. Conservatori e congetturatori
5. Lingua e grafia
5.1. Conservare o modernizzare?
5.2. La veste linguistica del testo, fra autore e copisti
6. Fideismo e scetticismo
VI. La filologia dell’originale
1. Fini, forme, metodi
1.1. Filologia genetica e critica delle varianti
1.2. Filologia dell’originale e interpretazione
1.3. Dalla micro- alla macrostruttura
1.4. I presupposti estetici della critica delle varianti
1.5. Tradizioni autografe e apografe
2. La filologia dell’originale senza gli originali
3. L’edizione critica nella filologia dell’originale
3.1. Testo e apparato
3.2. Edizione integrale delle diverse redazioni
3.3. La scelta del testo
3.4. Opere incompiute, abbozzi, minute
4. La filologia dell’originale e i «metodi»
VII. Miti filologici: il primo originale, l’ultima volontà dell’autore, la verità del documento
1. Il mito delle origini
2. Le volontà dell’autore (e quelle degli altri)
3. La verità nel documento
3.1. Verità del testimone e verità del testo
3.2. A ciascuno il suo canzoniere
VIII. La filologia dei testi a stampa. La filologia digitale
1. La filologia dei testi a stampa
1.1. La specificità del libro e delle tradizioni a stampa
1.2. Filologia d’autore nelle stampe
2. La filologia digitale
2.1. Filologia e computer
2.2. Il testo e la filologia nel mondo digitale
IX. Linguistica, metrica e filologia. La filologia attributiva
1. Linguistica e filologia
1.1. Storia della lingua, ecdotica, storia della tradizione
1.2. Filologia e lessici
2. Metrica e filologia
2.1. Il ruolo della metrica nella constitutio textus
2.2. Anisosillabismo (vero o presunto) e irregolarità apparenti
3. La filologia attributiva
Epilogo. Per una filologia sostenibile
Riferimenti bibliografici
Indice delle cose notevoli
Indice dei nomi |