Interazioni Piante - Ambiente
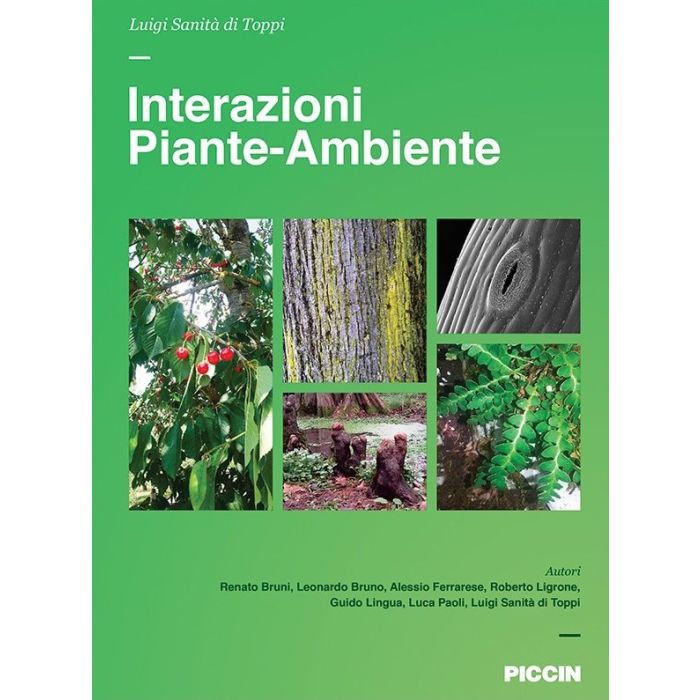
- ISBN/EAN
- 9788829928705
- Editore
- Piccin Editore
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2018
- Pagine
- 355
Disponibile
39,00 €
Sicuramente lo stile di vita sessile di quegli eu- carioti fotoautotrofi denominati piante richiede una loro particolare capacità nel percepire prontamente e gestire “con criterio” tutti gli stimoli provenienti dall’ambiente circostante, dovendo esse discernere con chiarezza, e spesso in fretta, tra stimoli positivi (in certi casi addirittura indispensabili alla loro so- pravvivenza) e stimoli negativi, perlopiù causati da fattori di stress abiotici e biotici.
La miriade di segnali provenienti dall’esterno deve essere anche rapidamente integrata per generare un pool, spesso assai articolato, di risposte molecolari, (epi)genetiche, biochimiche, funzionali, istoanatomi- che, morfologiche, ecologiche, ecc. In definitiva, il fine ultimo di una pianta (e di una comunità di piante) è quello di ottenere il massimo con il minore sforzo energetico – compatibilmente con quanto l’ambiente può offrire nel breve, medio e lungo periodo.
Di qui la straordinaria plasticità, le disparate strategie adattative e, non da ultimo, l’ecceziona- le attitudine biosintetica delle piante, in grado di produrre una pletora di metaboliti che governano le loro interazioni con l’ambiente, molti dei quali – tra l’altro – noi umani impieghiamo opportunisticamente come farmaci, coloranti, nutraceutici, ecc.
Insomma, le piante sono organismi straordi- nari che, continuamente e nascostamente rispetto alle nostre abilità percettive, instaurano importanti relazioni con il mondo che le circonda e con gli organismi che vivono nel loro intorno: si pensi in proposito ai funghi micorrizici, ai batteri azotofissatori, agli insetti pronubi e a tanti altri organismi, anche filogeneticamente molto lontani dalle piante, con cui esse intessono intime e continue relazioni. Nello stesso tempo, le piante sanno ben difendersi da parassiti e patogeni, inviando segnali d’allarme ad hoc anche ad organi distanti dai siti di attacco, e in taluni casi addirittura a piante vicine o ad organismi “protettori”, per allertarli.
Non ultimo, in un “Antropocene” sempre più governato dal cambiamento climatico e dalla con- taminazione ambientale, le piante sono in grado di percepire queste alterazioni e “comportarsi” di conseguenza, con idonee strategie di difesa e adattamento, che non di rado potremmo persino sfrut- tare per sanare molti guasti ambientali e per cre- are, si spera, un futuro migliore al nostro Pianeta. Oltre alle piante, affascinanti quanto poco cono- sciuti sono i licheni, ovvero funghi sui generis che albergano simbioticamente al loro interno organismi fotosintetici, come microalghe e/o cianobatteri. Le loro straordinarie capacità di bioindicazione dell’inquinamento, nonché di bioaccumulo di vari contaminanti aerodispersi, fanno sì che essi possa- no essere considerati interessantissimi “campanelli d’allarme” della salute ambientale.
Ciò premesso, ad oggi non esiste un’opera didattica in lingua italiana che proponga un excursus sufficientemente completo sull’affascinante mondo delle “Interazioni Piante-Ambiente”. Conseguente- mente, curando la stesura di questo testo, mi sono assunto il non facile compito di tentare di colmare almeno in parte tale lacuna, elaborando uno strumento didattico indirizzato prevalentemente a studenti di Lauree Magistrali biologiche, biotecnologiche, ambientali, ecologiche ed agrarie. Tuttavia, l’opera può essere validamente utilizzata anche per integrare la “Materia Botanica” impartita nelle Lauree Triennali degli indirizzi/discipline di cui sopra, nonché fornire uno strumento conoscitivo a tutte le figure professionali che si occupano di “Interazioni Piante-Ambiente”, e perché no, a curiosi e appassionati. Con la lettura di questo testo didattico, dunque, mi auguro che studenti e fruitori pos- sano acquisire una buona conoscenza dei principali processi che governano le disparate interazioni tra le piante e l’ambiente che le circonda.
Desidero espressamente sottolineare che di certo non avrei concluso granché senza l’indispensabile e qualificato contributo di alcuni colleghi, sia per quel che attiene alla stesura dei Capitoli, sia per la “costruzione” dei Box integrativi, nei quali sono stati sapientemente approfonditi certi argomenti trattati più in generale nel Capitolo di riferimento. Voglio inoltre richiamare il fatto che tutto il testo è stato revisionato da illustri colleghi, scelti per la loro comprovata perizia nei loro rispettivi ambiti, e che ringrazio sentitamente per l’impegno prodigato e i loropreziosi i suggerimenti, tenuti sempre in gran conto. Eventuali difetti, errori ed omissioni – che spero comunque possano essere il più possibile contenuti – sono di mia esclusiva responsabilità, e gradirei davvero che colleghi, esperti e studenti me li segnalassero schiettamente e direttamente.
Un grande grazie alla Dr.ssa Sara Menon, che con le sue straordinarie qualità di illustratrice ha “confezionato” una ricca iconografia originale, di certo in grado di conferire valore aggiunto alla valenza didattica del testo. Tengo infine a ringraziare vivamente il Dr. Nicola Piccin, che fin dall’inizio ha creduto entusiasticamente nella mia idea e mi ha sempre sostenuto affinché portassi a compimento il lavoro; e tutto lo staff della Piccin Nuova Libraria S.p.A., in modo speciale la Sig.ra Mariangela Frigo che, con una puntuale assistenza editoriale, mi ha consentito di lavorare al meglio.
Luigi Sanità di Toppi
Ordinario di Botanica Generale Dipartimento di Biologia Università di Pisa
Maggiori Informazioni
| Autore | Sanità di Toppi Luigi; Renato Bruni; Leonardo Bruno; Alessio Ferrarese; Roberto Ligrone; Guido Lingua; Luca Paoli |
|---|---|
| Editore | Piccin Editore |
| Anno | 2018 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Presentazione di Telmo Pievani, Università di Padova .............................. VII Prefazione di Luigi Sanità di Toppi, Università di Pisa........... IX -------------------------------- Capitolo 1 Interazioni piante-ambiente in un contesto filogenetico.............................1 Roberto Ligrone 1.1. Introduzione ............................................................................................1 1.2. Origine delle piante.................................................................................3 1.1. Cianobatteri: tra gli organismi più versatili del Pianeta....................7 1.3. Cicli riproduttivi e adattamenti delle piante all’ambiente terrestre....... 11 1.4. Filogenesi delle piante terrestri ............................................................. 13 Box 1.2. Fossili, orologi molecolari e datazione delle piante terrestri.......... 18 1.5. Le piante terrestri e l’acqua................................................................... 20 Box 1.3. La lignina ........................................................................................ 23 1.6. Cuticola, stomi e controllo degli scambi gassosi .................................. 24 1.7. Origine degli stomi e degli spazi aeriferi .............................................. 27 1.8. Il trasporto dell’acqua sulla lunga distanza........................................... 30 1.9. Efficienza idraulica e architettura del sistema vascolare nelle piante arboree........... 34 1.10. Piante terrestri e piovosità ................................................................... 37 1.11. Piante terrestri come “agenti geochimici” ........................................... 38 Letture per approfondimenti ....................................................................... 46 Capitolo 2 Interazioni delle piante con i principali fattori di stress abiotico.............49 Leonardo Bruno, Luigi Sanità di Toppi 2.1. Introduzione .......................................................................................... 49 Box 2.1. Exaptation ed epigenetica come “serbatoi” di variabilità nelle piante ............ 56 2.2. Carenza di acqua................................................................................... 59 Box 2.2. Richiami sul potenziale idrico........................................................ 61 2.3. Adattamenti alla carenza d’acqua ......................................................... 63 2.4. Acclimatamenti alla carenza di acqua .................................................. 68 2.5. Risposte di natura acclimatativa e adattativa al deficit idrico .............. 69 2.6. Le euxerofite ......................................................................................... 72 2.7. La percezione e la trasduzione dello stress da carenza idrica ............... 72 2.8. Stress salino .......................................................................................... 73 2.9. Adattamenti alla salinità ...................................................................... 74 2.10. Acclimatamenti alla salinità ................................................................ 79 2.11. La percezione e la trasduzione dello stress salino ............................... 80 2.12. Stress da alte temperature.................................................................... 83 2.13. Adattamenti alle alte temperature........................................................ 84 2.14. Acclimatamenti alle elevate temperature ........................................... 86 2.15. La percezione e la trasduzione dello stress da alte temperature .......... 90 2.16. Stress da freddo e congelamento ......................................................... 91 2.17. Adattamenti al freddo e al congelamento ............................................ 93 2.18. Acclimatamenti al freddo e al congelamento ...................................... 95 2.19. La percezione e la trasduzione dello stress da basse temperature ....... 97 2.20. Stress da eccesso di acqua................................................................... 97 2.21. Adattamenti al flooding....................................................................... 98 2.22. Risposte cellulari e molecolari di natura acclimatativa e adattativa al flooding............101 2.23. La percezione e la trasduzione dello stress da carenza di ossigeno ..........104 2.24. Stress da luce......................................................................................104 2.25. Adattamenti e acclimatamenti a differenti condizioni di luce ........... 105 2.26. Lo stress da elevata irradianza ........................................................... 109 2.27. Prevenzione e riparazione dei danni da eccesso di luce ..................... 111 2.27.1 Quenching non fotochimico........................................................... 111 2.27.2 Scavenging delle ROS ................................................................... 111 2.27.3 Riparazione del danno fotochimico e sintesi di specifiche proteine............ 111 2.28. Stress da radiazione ultravioletta (UV)..............................................113 Box 2.3. Comunità vegetali e stress abiotici................................................ 114 Letture per approfondimenti ...................................................................... 117 Capitolo 3 Principali inquinanti ambientali e loro impatto sulle piante...................119 Luigi Sanità di Toppi 3.1. Cenni generali sull’inquinamento ambientale...................................... 119 Box 3.1. “L’inquinamento dell’aria provoca il cancro”................................122 3.2. Tipologie di inquinanti e loro impatto sulle piante..............................123 3.3. Ossidi di azoto ..................................................................................... 124 3.4. Ossidi di azoto: inquinanti fitotossici, fertilizzanti azotati o molecole “segnale” per le piante? ........ 128 Box 3.2. L’ossido nitrico endogeno come molecola-segnale.......................129 3.5. Ozono troposferico .............................................................................. 132 Box 3.3. Lo smog fotochimico.....................................................................135 3.6. Parametri e sistemi sperimentali di fumigazione delle piante con ozono.................139 3.7. Effetti dell’ozono sulle piante spontanee e coltivate............................141 3.7.1. Effetti cronici .................................................................................... 142 3.7.2. Effetti acuti.......................................................................................145 3.7.3. Macrosintomatologia e diagnostica fogliare dei danni da ozono ............ 150 3.8. Biomonitoraggio dell’inquinamento da ozono .................................... 152 3.9. Elevate concentrazioni atmosferiche di biossido di carbonio (CO2) ... 155 3.10. Alte concentrazioni di CO2 e sistemi sperimentali per lo studio delle risposte nelle piante ......... 159 3.11. Effetti delle alte concentrazioni atmosferiche di CO2 sulle piante ..... 162 3.11.1 Disponibilità di acqua e alte concentrazioni di CO2 .............................. 166 3.11.2 Elevate temperature e alte concentrazioni di CO2.................................167 3.11.3 Tenore di azoto/altri nutrienti minerali e alte concentrazioni di CO2 ......167 3.11.4 Produttività e alte concentrazioni di CO2.............................................167 3.11.5. Comunità vegetali, alte concentrazioni di CO2 e global change............168 3.12. Particolati............................................................................................171 3.13. Metalli pesanti .................................................................................... 173 3.14. Acclimatamenti e adattamenti delle piante a metalli pesanti e metalloidi ............183 3.15. Le piante escluditrici ed iperaccumulatrici di metall(oid)i.................193 3.16. Cenni agli effetti di alcuni inquinanti organici sulle piante................197 Box 3.4A. Fitotecnologie e piante per la decontaminazione ambientale dei metalli pesanti ............199 Box 3.4B. Cenni alla fitodecontaminazione degli inquinanti organici .........201 Box 3.4C. Mycoremediation: le potenzialità dei funghi nella decontaminazione ambientale.............202 3.17. Aerosol marini ..............203 Letture per approfondimenti ....................204 Capitolo 4 Il metabolismo secondario nelle interazioni piante-ambiente.................207 Renato Bruni 4.1. Introduzione .........................................................................................207 4.2. Acidi organici ......................................................................................208 4.3. Fenoli ..................................................................................................210 4.4. Glicosidi ..............................................................................................210 4.5. Flavonoidi............................................................................................212 4.6. Antociani..............................................................................................214 4.7. Catechine o catecoli ............................................................................214 4.8. Tannini e lignine ..................................................................................214 4.9. Alcaloidi .............................................................................................216 4.10. Isoprenoidi..........................................................................................219 4.11. Carotenoidi .........................................................................................221 Box 4.1. I composti organici volatili prodotti dalle piante...........................222 4.12. Biosintesi e destino dei metaboliti secondari: produzione, trasporto e accumulo.............228 Box 4.2. I metaboliti secondari come strumenti competitivi negli habitat: il caso dei composti allelopatici ...............229 4.13. I metaboliti secondari nell’interfaccia tra le piante e l’ambiente .......231 Box 4.3. Organizzazione tissutale e comunicazione: guaranà e tucani........234 4.14. Esigenze ecologiche: attrazione/repulsione, comunicazione e difesa da stress biotici e abiotici ............237 Letture per approfondimenti ......................................................................238 Capitolo 5 Interazioni biotiche delle piante.................................................................239 Guido Lingua 5.1. Introduzione .........................................................................................239 5.2. Le relazioni tra piante e microrganismi si generano secondo un continuum che va dal mutualismo al parassitismo ............241 5.3. Interazioni negative tra piante e altri organismi ..................................243 5.4. Difese costitutive .................................................................................249 5.4.1. Le difese strutturali costitutive ...........................................................249 5.4.2. Le difese chimiche costitutive ...........................................................250 5.5. Difese elicitate ....................................................................................252 5.5.1. Il riconoscimento del patogeno ...........................................................252 5.5.2. Il burst ossidativo .............................................................................254 Box 5.1. La morte cellulare programmata....................................................256 5.5.3. Generalità sui meccanismi di difesa elicitati........................................257 5.5.4. Le difese strutturali elicitate...............................................................258 5.5.5. Le difese chimiche e biochimico-molecolari elicitate...........................258 5.5.6. La risposta ipersensibile .................................................................... 259 5.5.7. I meccanismi di difesa contro virus e fitoplasmi...................................259 5.8.1. Le simbiosi azotofissatrici .................................................................. 264 5.8.2. Formazione dei noduli nelle leguminose.............................................266 5.8.3. La fissazione dell’azoto ad opera della nitrogenasi...............................267 5.8.4. Evoluzione della simbiosi radici-noduli .............................................. 268 Box 5.2. Il ruolo delle HSP nella risposta ai patogeni ................................. 260 5.6. L’induzione di resistenza e il priming..................................................261 5.7. Interazioni benefiche piante-microrganismi.........................................263 5.8. I batteri che promuovono la crescita delle piante ................................ 264 Box 5.3. Interazione tra fiori ed animali impollinatori: un sistema fondamentale, in parte sconosciuto ......... 269 5.9. Le micorrize.........................................................................................271 5.9.1. Micorrize delle orchidee .................................................................... 273 5.9.2. Micorrize ericoidi ............................................................................. 274 5.9.3. Le micorrize arbuscolari....................................................................275 5.9.4. Le ectomicorrize...............................................................................278 5.10. Vie di segnalazione associate all’instaurarsi delle simbiosi benefiche ............................................................................................. 280 5.11. Effetti dei microrganismi del suolo sullo sviluppo dell’apparato radicale............. 284 5.12. Aspetti evolutivi, ecologici e applicativi delle simbiosi micorriziche arbuscolari ................. 286 Ringraziamenti........................................................................................... 288 Letture per approfondimenti ...................................................................... 288 Capitolo 6 I licheni come “biomonitor” dell’inquinamento atmosferico..................289 Luca Paoli, Alessio Ferrarese e Luigi Sanità di Toppi 6.1. Introduzione.........................................................................................289 6.2. Il contesto evolutivo e la sistematica attuale .......................................290 6.3. Organizzazione del tallo lichenico.......................................................292 6.4. Forme di crescita ................................................................................. 293 6.5. Riproduzione nei licheni......................................................................294 6.6. Strutture secondarie del tallo lichenico ............................................... 297 6.7. Interazioni tra i licheni e l’ambiente ....................................................297 6.7.1. Idratazione del tallo e stress idrico..................................................297 6.7.2. Temperatura....................................................................................298 6.7.3. Radiazione solare ...........................................................................300 6.8. Ecologia dei licheni e loro interazioni con il substrato........................300 6.9. Accrescimento del tallo........................................................................302 6.10. Interazioni con gli animali..................................................................303 6.10.1. Predazione ..................................................................................... 303 6.10.2. Commensalismo ...........................................................................304 6.10.3. Mimetismo .................................................................................... 304 6.11. Sostanze licheniche e adattamenti all’ambiente ................................. 304 6.12. Licheni e inquinamento atmosferico..................................................307 6.13. Risposte dei licheni agli inquinanti .................................................... 308 6.14. Parametri cellulari correlati agli stress ambientali .............................308 6.15. Bioaccumulo.......................................................................................311 6.16. Aspetti metodologici del bioaccumulo: i campioni nativi..................313 6.17. La tecnica del trapianto lichenico .......................................................313 6.18. Interpretazione dei dati di bioaccumulo .............................................315 6.19. Studio degli isotopi.............................................................................317 6.20. Bioindicazione....................................................................................317 6.21. Il metodo IBL (Indice di Biodiversità Lichenica) e le strategie di campionamento.................319 6.21.1. Selezione dell’area di studio .........................................................320 6.21.2. Selezione degli alberi su cui effettuare i rilievi ...........................321 6.21.3. Criteri di rilevabilità degli alberi......................................................... 322 6.21.4. Il reticolo di campionamento (o di rilevamento) ..........................322 6.21.5. Il calcolo dell’Indice di Biodiversità Lichenica............................324 6.21.6. Elaborazione e interpretazione dei dati di bioindicazione............324 6.22. Integrità degli habitat .........................................................................326 Letture per approfondimenti ......................................................................328 Indice analitico .........................................................................................330 |
Questo libro è anche in:
