Fondamenti di Biologia Molecolare [Allison - Zanichelli]
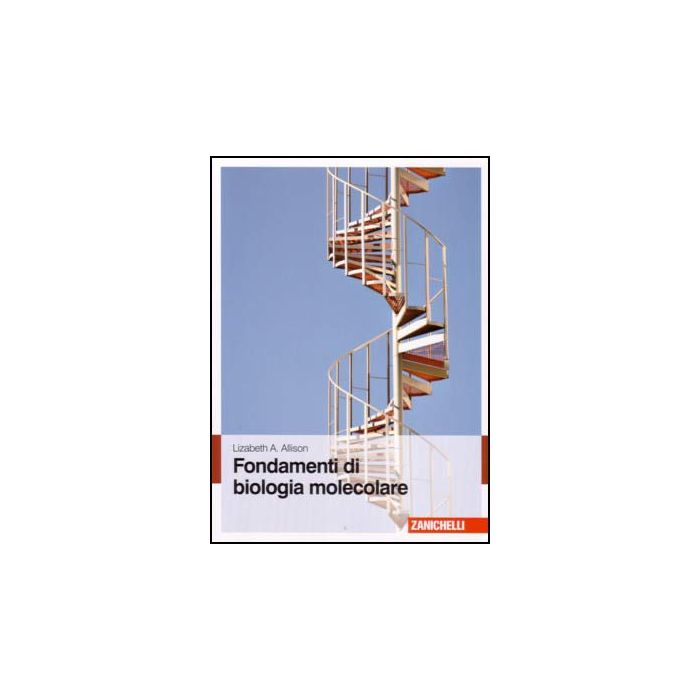
- ISBN/EAN
- 9788808166227
- Editore
- Zanichelli
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2008
- Pagine
- 690
Disponibile
75,40 €
Fondamenti di biologia molecolare raggiunge, in un numero contenuto di pagine, i seguenti obiettivi didattici:
evidenzia il processo della scoperta – le osservazioni, i problemi, i progetti sperimentali usati per controllare i modelli, i risultati e le conclusioni – e non si limita a presentare i “fatti”;
sviluppa un quadro esauriente dei molti modi in cui la biologia molecolare è applicata all’analisi dei sistemi complessi;
descrive i progressi nella ricerca e i processi tecnologici correlati alle applicazioni mediche e commerciali;
affronta i problemi etici della ricerca in questo campo.
Integrano e arricchiscono la trattazione:
- le schede Strumenti, che esplorano metodi sperimentali e tecniche chiave;
- le schede Focus, che offrono una trattazione più dettagliata degli argomenti, prendono in considerazione strategie sperimentali e suggeriscono aree di ulteriore esplorazione;
- le schede Malattia, che illustrano i principi chiave della biologia molecolare prendendo in esame malattie dovute a difetti genetici.
Maggiori Informazioni
| Autore | Allison Lizabeth A. |
|---|---|
| Editore | Zanichelli |
| Anno | 2008 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Capitolo 1 Gli inizi della biologia molecolare 1.1 Introduzione 1 1.2 Prospettiva storica 2 La comprensione dei meccanismi dell’eredità basata sulla differenza tra piselli lisci e rugosi: la genetica mendeliana 2 La comprensione della natura del materiale ereditario: il principio trasformante è il DNA 2 Un approccio creativo porta all’ipotesi un gene-un enzima 6 L’importanza del progresso tecnologico: l’esperimento di Hershey-Chase 6 Un modello per la struttura del DNA: la doppia elica 9 Riassunto del capitolo 10 Domande analitiche 10 Letture consigliate 11 Capitolo 2 La struttura del DNA 2.1 Introduzione 12 2.2 La struttura primaria: i componenti degli acidi nucleici 13 Gli zuccheri a cinque atomi di carbonio 13 Le basi azotate 13 Il gruppo funzionale fosfato 14 Nucleosidi e nucleotidi 14 2.3 Il significato di 5’ e di 3’ 15 2.4 La nomenclatura dei nucleotidi 16 2.5 La lunghezza del DNA e dell’RNA 16 2.6 La struttura secondaria del DNA 16 Fra le basi si formano legami idrogeno 17 L’impilamento delle basi stabilizza chimicamente la doppia elica del DNA 18 La struttura della doppia elica di Watson-Crick 18 Le diverse caratteristiche delle forme alternative della doppia elica 19 Il DNA può subire una separazione reversibile dei filamenti 22 2.7 Strutture secondarie insolite del DNA 25 Strutture scivolate 26 Strutture cruciformi 26 DNA a tripla elica 26 Malattia 2.1 L’atassia di Friedreich e il DNA a tripla elica 27 2.8 La struttura terziaria del DNA 28 Superavvolgimento del DNA 28 Le topoisomerasi “rilassano” il DNA superavvolto 29 Il significato del superavvolgimento in vivo 30 Malattia 2.2 Farmaci anticancro diretti contro le topoisomerasi 31 Riassunto del capitolo 32 Domande analitiche 33 Letture consigliate 33 Capitolo 3 L’organizzazione del genoma: dai nucleotidi alla cromatina 3.1 Introduzione 34 3.2 Il genoma eucariotico 34 La struttura della cromatina: prospettiva storica 36 Gli istoni 37 I nucleosomi 38 Una collana di perle: la fibra da 10 nm 39 La fibra da 30 nm 39 Domini ad ansa 39 I cromosomi metafasici 39 Strutture alternative della cromatina 40 3.3 Il genoma batterico 40 3.4 I plasmidi 41 3.5 I batteriofagi e i virus a DNA dei mammiferi 41 I batteriofagi 41 Virus a DNA dei mammiferi 42 3.6 I genomi degli organelli: i cloroplasti e i mitocondri 42 Il DNA dei cloroplasti (cpDNA) 43 Il DNA mitocondriale (mtDNA) 43 3.7 I genomi a RNA 43 Malattia 3.1 DNA mitocondriale e malattie 44 I virus eucariotici a RNA 44 Malattia 3.2 L’influenza aviaria 45 I retrovirus 46 I viroidi 46 Altri patogeni subvirali 46 Riassunto del capitolo 47 Domande analitiche 47 Letture consigliate 48 Capitolo 4 La versatilità dell’RNA 4.1 Introduzione 49 4.2 La struttura secondaria dell’RNA 49 I motivi di struttura secondaria dell’RNA 50 L’RNA a basi appaiate adotta una doppia elica di tipo A 50 Le eliche di RNA spesso contengono coppie di basi non canoniche 51 4.3 La struttura terziaria dell’RNA 53 La struttura del tRNA: informazioni importanti sui motivi strutturali dell’RNA 53 I motivi comuni di struttura terziaria nell’RNA 55 4.4 La cinetica del ripiegamento dell’RNA 59 4.5 L’RNA è coinvolto in una vasta gamma di processi cellulari 61 4.6 Prospettiva storica: la scoperta della catalisi da RNA 63 Focus 4.1 Il mondo a RNA 64 Il ribozima nell’introne di gruppo I di Tetrahymena 65 Il ribozima dell’RNasi P 65 4.7 I ribozimi catalizzano varie reazioni chimiche 67 Il meccanismo di azione dei ribozimi 67 I grandi ribozimi 69 I piccoli ribozimi 69 Riassunto del capitolo 71 Domande analitiche 71 Letture consigliate 72 Capitolo 5 Dai geni alle proteine 5.1 Introduzione 73 5.2 Il dogma centrale 74 5.3 Il codice genetico 74 La traduzione del codice genetico 75 Il ventunesimo e il ventiduesimo amminoacido codificati geneticamente 76 Il ruolo dei nucleotidi modificati nella decodificazione 76 Implicazioni delle preferenze per i codoni per i biologi molecolari 78 5.4 La struttura delle proteine 78 La struttura primaria 79 La struttura secondaria 80 La struttura terziaria 81 La struttura quaternaria 84 Le dimensioni e la complessità delle proteine 84 Le proteine contengono domini funzionali multipli 85 La predizione della struttura delle proteine 85 5.5 La funzione delle proteine 86 Gli enzimi sono catalizzatori biologici 86 La regolazione dell’attività delle proteine da parte di modificazioni post-traduzionali 87 La regolazione allosterica dell’attività delle proteine 89 Attivazione delle chinasi dipendenti da ciclina 89 Assemblaggi macromolecolari 91 5.6 Il ripiegamento corretto e non corretto delle proteine 91 I chaperoni molecolari 91 La degradazione delle proteine mediata da ubiquitina 91 Malattie da ripiegamento non corretto delle proteine 93 Malattia 5.1 I prioni 95 Riassunto del capitolo 97 Domande analitiche 98 Letture consigliate 99 Capitolo 6 La replicazione del DNA e il mantenimento dei telomeri 6.1 Introduzione 101 6.2 Prospettiva storica 101 Informazioni sul meccanismo di replicazione del DNA: l’esperimento di Meselson-Stahl 101 Informazioni sul meccanismo di replicazione del DNA: la visualizzazione del DNA batterico che si replica 102 6.3 La sintesi del DNA avviene da 5’ a 3’ 104 6.4 Le DNA polimerasi sono gli enzimi che catalizzano la sintesi del DNA 106 Focus 6.1 Le DNA polimerasi batteriche 106 6.5 La replicazione semidiscontinua del DNA 107 La sintesi del filamento leader è continua 107 La sintesi del filamento ritardato è discontinua 109 6.6 La replicazione del DNA nucleare nelle cellule eucariotiche 109 Fabbriche di replicazione 109 La rimozione degli istoni alle origini di replicazione 109 La formazione del complesso di prereplicazione alle origini di replicazione 109 Focus 6.2 La nomenclatura dei geni coinvolti nella replicazione del DNA 114 L’abilitazione alla replicazione: il DNA si replica soltanto una volta per ciclo cellulare 116 Svolgimento del duplex a livello delle forcelle di replicazione 119 L’innesco da parte di RNA della sintesi del DNA del filamento leader e di quello ritardato 120 Scambio delle polimerasi 120 L’allungamento dei filamenti leader e di quelli ritardati 120 Malattia 6.1 Il lupus eritematoso sistemico e il PCNA 121 La correzione delle bozze 122 La maturazione dei filamenti nascenti di DNA 122 La terminazione 124 La deposizione degli istoni 125 6.7 La replicazione del DNA degli organelli 125 Modelli della replicazione dell’mtDNA 125 La replicazione del cpDNA 126 Malattia 6.2 La RNasi MRP e l’ipoplasia della cartilagine e dei peli 126 6.8 La replicazione a cerchio rotante 127 6.9 Il mantenimento dei telomeri: il ruolo della telomerasi nella replicazione del DNA, nell’invecchiamento e nel cancro 127 I telomeri 129 La soluzione al problema della replicazione delle estremità 129 Il mantenimento dei telomeri da parte della telomerasi 130 Altri modi di mantenimento dei telomeri 132 La regolazione dell’attività della telomerasi 132 Telomerasi, invecchiamento e cancro 133 Malattia 6.3 La discheratosi congenita: perdita della funzione della telomerasi 137 Riassunto del capitolo 138 Domande analitiche 139 Letture consigliate 140 Capitolo 7 La riparazione e la ricombinazione del DNA 7.1 Introduzione 142 7.2 I tipi di mutazioni e le loro conseguenze fenotipiche 143 Le transizioni e le trasversioni possono portare a mutazioni silenti, missenso e nonsenso 143 Le inserzioni o le delezioni possono causare mutazioni frameshift 145 L’espansione delle ripetizioni trinucleotidiche porta a instabilità genetica 145 7.3 Le classi generali del danno al DNA 146 Cambiamenti di singole basi 146 Distorsione strutturale 146 Danno all’ossatura del DNA 147 La risposta cellulare al danno al DNA 148 7.4 Aggiramento della lesione 148 7.5 Inversione diretta del danno al DNA 150 7.6 La riparazione dei cambiamenti di singole basi e delle distorsioni strutturali mediante rimozione del danno al DNA 151 Riparazione per escissione delle basi 152 Riparazione delle basi male appaiate 154 Malattia 7.1 Il cancro colorettale ereditario non associato a poliposi: un difetto della riparazione delle basi male appaiate 156 Riparazione per escissione di nucleotidi 156 Malattia 7.2 Lo xeroderma pigmentoso e i disordini correlati: i difetti della riparazione per escissione di nucleotidi 158 7.7 La riparazione delle rotture a doppio filamento mediante rimozione del danno al DNA 161 La ricombinazione omologa 161 Malattia 7.3 Il cancro ereditario della mammella: mutazioni di BRCA1 e di BRCA2 162 L’unione non omologa delle estremità 164 Riassunto del capitolo 166 Domande analitiche 168 Letture consigliate 168 Capitolo 8 La tecnologia del DNA ricombinante e il clonaggio molecolare 8.1 Introduzione 171 8.2 Prospettiva storica 171 I siti coesivi del batteriofago lambda (λ) suggeriscono un metodo per unire segmenti di DNA 171 I sistemi di restrizione e di modificazione forniscono gli strumenti per unire frammenti di DNA 171 I primi esperimenti di clonaggio 174 8.3 Il taglio e la riunione di frammenti di DNA 174 Le classi principali di endonucleasi di restrizione 174 Focus 8.1 Paura delle molecole di DNA ricombinante 175 La nomenclatura delle endonucleasi di restrizione 176 Le sequenze di riconoscimento delle endonucleasi di restrizione di tipo II 176 Focus 8.2 EcoRI: piegatura e taglio del DNA 179 La DNA ligasi 180 8.4 Clonaggio molecolare 181 Il DNA del vettore 181 La scelta del vettore dipende dalle dimensioni e dalle applicazioni dell’inserto 182 Il DNA plasmidico come vettore 182 Il batteriofago lambda (λ) come vettore 187 Strumenti 8.1 La cromatografia liquida 187 I vettori basati su cromosomi artificiali 189 Le fonti del DNA da clonare 191 Strumenti 8.2 La sintesi del DNA complementare (cDNA) 192 Strumenti 8.3 La reazione a catena della polimerasi (PCR) 194 8.5 La costruzione di librerie di DNA 196 Librerie genomiche 196 Librerie di cDNA 196 8.6 Le sonde 196 Sonde eterologhe 197 Sonde omologhe 197 Strumenti 8.4 Metodi di marcatura radioattiva e non radioattiva 197 Strumenti 8.5 Marcatura degli acidi nucleici 199 8.7 Lo screening delle librerie 203 Trasferimento delle colonie su una membrana che lega il DNA 203 Ibridazione delle colonie 203 Individuazione delle colonie positive 205 8.8 Librerie di espressione 205 8.9 Mappatura di restrizione 205 Strumenti 8.6 Elettroforesi 206 8.10 Il polimorfismo di lunghezza dei frammenti di restrizione (RFLP) 208 I RFLP possono servire da marcatori di malattie genetiche 208 Strumenti 8.7 Southern blot 209 8.11 Sequenziamento del DNA 211 Malattia 8.1 Saggio PCR-RFLP per la malattia delle urine a sciroppo d’acero 212 Il sequenziamento manuale con il metodo dei “dideossi” di Sanger 212 Sequenziamento automatizzato del DNA 215 Riassunto del capitolo 216 Domande analitiche 218 Letture consigliate 220 Capitolo 9 Gli strumenti per l’analisi dell’espressione genica 9.1 Introduzione 222 9.2 Saggi di trasfezione transitoria e stabile 222 9.3 Geni reporter 223 Geni reporter usati comunemente 225 Analisi della regolazione dei geni 226 Purificazione ed etichette di rivelazione: le proteine di fusione 227 Strumenti 9.1 La produzione di proteine ricombinanti 229 Strumenti 9.2 Microscopia a fluorescenza, confocale e multifotonica 230 9.4 Mutagenesi in vitro 234 9.5 Analisi a livello della trascrizione dei geni: espressione e localizzazione dell’RNA 237 Northern blot 237 Ibridazione in situ 237 Saggio di protezione dalla RNasi (RPA) 239 Trascrizione inversa-PCR (RT-PCR) 239 9.6 Analisi a livello della traduzione: espressione e localizzazione delle proteine 239 Strumenti 9.3 Elettroforesi su gel delle proteine 240 Strumenti 9.4 Produzione di anticorpi 242 Western blot 242 Analisi in situ 245 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 245 9.7 La tecnologia antisenso 246 Oligonucleotidi antisenso 246 Interferenza da RNA (RNAi) 247 Malattia 9.1 Terapie con RNAi 251 9.8 Analisi delle interazioni DNA-proteina 251 Saggio di spostamento della mobilità elettroforetica (EMSA) 251 Footprinting con DNasi I 253 Saggio di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP) 253 9.9 Analisi delle interazioni proteina-proteina 254 Il saggio di pull-down (saggio di legame) 254 Il saggio del doppio ibrido di lievito 254 Il saggio di coimmunoprecipitazione 256 Trasferimento dell’energia di risonanza della fluorescenza (FRET) 256 9.10 Analisi strutturale delle proteine 256 Cristallografia ai raggi X 256 Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) 256 Microscopia crioelettronica 258 Microscopia a forza atomica (AFM) 258 9.11 Organismi modello 258 Lievito: Saccharomyces cerevisiae e Schizosaccharomyces pombe 259 Verme: Caenorhabditis elegans 259 Mosca: Drosophila melanogaster 259 Pesce: Danio rerio 259 Vegetale: Arabidopsis thaliana 260 Topo: Mus musculus 260 Rana: Xenopus laevis e Xenopus tropicalis 260 Riassunto del capitolo 260 Domande analitiche 263 Letture consigliate 264 Capitolo 10 La trascrizione nei procarioti 10.1 Introduzione 265 10.2 Trascrizione e traduzione sono accoppiate nei batteri 266 10.3 I meccanismi della trascrizione 267 La struttura dei promotori batterici 268 La struttura della RNA polimerasi batterica 269 Le fasi della trascrizione 270 Focus 10.1 Chi si muove? L’RNA polimerasi o il DNA? 276 La correzione delle bozze 278 La direzione della trascrizione intorno al cromosoma di E. coli 278 10.4 Prospettiva storica: il modello dell’operone di Jacob-Monod per la regolazione dei geni 279 Il modello dell’operone ha portato alla scoperta dell’mRNA 279 La caratterizzazione del repressore Lac 280 10.5 La regolazione dell’operone del lattosio (lac) 281 L’induzione dell’operone lac 282 La trascrizione basale dell’operone lac 283 La regolazione dell’operone lac da parte di Rho 283 Il promotore lac e il gene strutturale lacZ sono molto usati in biologia molecolare 284 10.6 Il meccanismo di azione dei regolatori trascrizionali 285 Il legame cooperativo delle proteine al DNA 285 Modificazioni allosteriche e legame al DNA 285 Formazione di anse da parte del DNA 286 10.7 Il controllo dell’espressione genica da parte dell’RNA 288 Ripiegamento differenziale dell’RNA: l’attenuazione trascrizionale dell’operone del triptofano 289 I ribointerruttori 290 I ribozimi microinterruttori 293 Riassunto del capitolo 293 Domande analitiche 294 Letture consigliate 295 Capitolo 11 La trascrizione negli eucarioti 11.1 Introduzione 298 11.2 Il quadro generale della regolazione trascrizionale 298 11.3 Gli elementi regolatori dei geni che codificano per proteine 300 Struttura e funzione degli elementi promotori 301 Struttura e funzione degli elementi regolatori a lungo raggio 304 Focus 11.1 Effetto di posizione ed elementi regolatori a lungo raggio 304 Malattia 11.1 La talassemia ispanica e i siti di ipersensibilità alla DNasi I 307 Focus 11.2 Esiste una matrice nucleare? 312 Focus 11.3 Territori cromosomici e fabbriche di trascrizione 314 11.4 Il macchinario generale (basale) della trascrizione 315 I componenti del macchinario generale della trascrizione 315 La struttura della RNA polimerasi II 316 I fattori generali di trascrizione e la formazione del complesso di preinizio 319 Il Mediatore: un ponte molecolare 320 11.5 I fattori di trascrizione 323 I fattori di trascrizione mediano l’attivazione o la repressione trascrizionale di geni specifici 324 I fattori di trascrizione sono proteine modulari 324 I motivi dei domini che legano il DNA 325 Focus 11.4 Omeobox e omeodomini 326 Malattia 11.2 La sindrome della cefalopolisindattilia di Greig e la segnalazione da parte di Sonic Hedgehog 330 Malattia 11.3 Istone acetiltrasferasi difettose nella sindrome di Rubinstein-Taybi 332 Il dominio di transattivazione 333 Il dominio di dimerizzazione 334 11.6 I coattivatori e i corepressori trascrizionali 334 I complessi di modificazione della cromatina 335 Focus 11.5 Esiste un codice istonico? 337 Le varianti dell’istone linker 339 I complessi di rimodellamento della cromatina 339 11.7 L’assemblaggio del complesso di trascrizione: il modello dell’enhanceosoma e il modello “colpisci e fuggi” 342 L’ordine del reclutamento di varie proteine che regolano la trascrizione 342 Il modello dell’enhanceosoma 344 Il modello “colpisci e fuggi” 345 Fusione dei modelli 345 11.8 Il meccanismo della trascrizione da parte della RNA polimerasi II 345 La clearance del promotore 345 L’allungamento: la polimerizzazione dell’RNA 347 Correzione delle bozze e arretramento 348 L’allungamento della trascrizione attraverso la barriera dei nucleosomi 348 Malattia 11.4 I difetti dell’Allungatore e la disautonomia familiare 351 11.9 Importazione ed esportazione nucleare delle proteine 353 Focus 11.6 Il complesso del poro nucleare 354 Le carioferine 355 Le sequenze di localizzazione nucleare (NLS) 355 Focus 11.7 La caratterizzazione della prima sequenza di localizzazione nucleare 358 Le sequenze di esportazione nucleare (NES) 359 La via di importazione nucleare 359 La via di esportazione nucleare 361 11.10 L’importazione nucleare regolata e le vie di trasduzione del segnale 361 Importazione nucleare regolata di NF-κB 361 Importazione nucleare regolata del recettore dei glucocorticoidi 363 Riassunto del capitolo 364 Domande analitiche 367 Letture consigliate 368 Capitolo 12 L’epigenetica e l’espressione genica monoallelica 12.1 Introduzione 373 12.2 Marcatori epigenetici 373 La metilazione delle citosine del DNA marca i geni per il silenziamento 374 Malattia 12.1 Epigenetica e cancro 375 Il mantenimento stabile delle modificazioni degli istoni 378 Malattia 12.2 Ritardo mentale da X fragile e metilazione aberrante del DNA 378 12.3 L’imprinting genomico 379 Malattia 12.3 Imprinting genomico e disordini dello sviluppo del sistema nervoso 381 L’instaurazione e il mantenimento dell’imprinting 384 I meccanismi di espressione monoallelica 385 L’imprinting genomico è essenziale per lo sviluppo normale 387 Le origini dell’imprinting genomico 388 12.4 L’inattivazione del cromosoma X 388 L’inattivazione casuale del cromosoma X nei mammiferi 389 I meccanismi molecolari che mantengono stabilmente l’inattivazione del cromosoma X 390 Tutti i geni legati all’X hanno un’espressione monoallelica? 390 12.5 Conseguenze fenotipiche degli elementi trasponibili 391 Prospettiva storica: la scoperta di Barbara McClintock degli elementi genetici mobili nel mais 392 Strumenti 12.1 Etichettatura con i trasposoni 393 I trasposoni di DNA hanno una vasta gamma di ospiti 394 Malattia 12.4 Geni che saltano e malattie umane 396 I trasposoni di DNA si spostano con un meccanismo “taglia e cuci” 397 I retrotrasposoni si spostano con un meccanismo “copia e incolla” 399 Alcuni retrotrasposoni con LTR sono attivi nel genoma dei mammiferi 399 I retrotrasposoni non LTR comprendono LINE e SINE 400 12.6 Il controllo epigenetico degli elementi trasponibili 401 La metilazione degli elementi trasponibili 401 La formazione di eterocromatina mediata da RNAi e da metilazione del DNA diretta da RNA 403 12.7 Esclusione allelica 404 Il cambiamento del tipo di accoppiamento del lievito e il silenziamento 405 Scambio di antigeni nei tripanosomi 409 Malattia 12.5 La tripanosomiasi: la “malattia del sonno” umana 410 La ricombinazione V(D)J e la risposta immunitaria adattiva 416 Focus 12.1 Il sistema V(D)J si è evoluto da un trasposone? 417 Riassunto del capitolo 423 Domande analitiche 425 Letture consigliate 426 Capitolo 13 I processi di modificazione dell’RNA e la regolazione post-trascrizionale dei geni 13.1 Introduzione 430 13.2 Lo splicing dell’RNA: prospettiva storica e inquadramento generale 430 13.3 Gli introni capaci di autosplicing di gruppo I e di gruppo II 432 Gli introni di gruppo I richiedono un cofattore esterno G per lo splicing 432 Focus 13.1 Piccoli RNA nucleolari codificati da introni e geni “rovesciati” 432 Gli introni di gruppo II richiedono una A sporgente interna per lo splicing 433 Gli introni mobili di gruppo I e di gruppo II 434 13.4 Gli introni degli archei e dell’RNA transfer nucleare 435 Gli introni degli archei sono sottoposti a splicing da un’endoribonucleasi 437 Alcuni geni nucleari dei tRNA contengono un introne 437 13.5 Modificazioni cotrascrizionali del pre-mRNA nucleare 438 Aggiunta del cappuccio di 7-metilguanosina 5′ 439 Terminazione e poliadenilazione 440 Splicing 442 Malattia 13.1 Distrofia muscolare oculofaringea: espansione di una ripetizione trinucleotidica in un gene di una proteina che lega poli(A) 443 Malattia 13.2 Atrofia muscolare spinale: difetti della biogenesi delle snRNP 445 13.6 Lo splicing alternativo 451 Malattia 13.3 Le mutazioni del gene Prp8 provocano la retinite pigmentosa 451 Gli effetti dello splicing alternativo sull’espressione genica 454 La regolazione dello splicing alternativo 454 Focus 13.2 Il gene DSCAM: splicing alternativo estremo 454 Focus 13.3 Apoptosi 457 13.7 Trans-splicing 458 Trans-splicing di gruppo II discontinuo 459 Trans-splicing del leader attaccato 459 Trans-splicing del tRNA 459 13.8 Editing dell’RNA 461 Editing dell’RNA nei tripanosomi 461 Editing dell’RNA nei mammiferi 465 Malattia 13.4 Sclerosi laterale amiotrofica: un difetto dell’editing dell’RNA 466 13.9 Modificazione delle basi guidata da piccoli RNA nucleolari 469 13.10 Regolazione genica post-trascrizionale da parte di microRNA 470 Prospettiva storica: la scoperta dei miRNA in Caenorhabditis elegans 471 Modificazione dei miRNA 472 I miRNA indirizzano l’mRNA alla degradazione e all’inibizione traduzionale 474 13.11 Il turnover dell’RNA nel nucleo e nel citoplasma 476 Gli esosomi nucleari e il controllo di qualità 476 Il controllo di qualità e la formazione di RNP competenti per l’esportazione nucleare 476 Il turnover dell’RNA citoplasmatico 477 Riassunto del capitolo 480 Domande analitiche 482 Letture consigliate 483 Capitolo 14 Il meccanismo della traduzione 14.1 Introduzione 487 14.2 Struttura e assemblaggio dei ribosomi 488 La struttura dei ribosomi 488 Focus 14.1 Che cos’è “S”? 489 Il nucleolo 490 La biogenesi dei ribosomi 492 14.3 Le amminoacil-tRNA sintetasi 492 Il caricamento dell’amminoacil-tRNA 492 L’attività di correzione delle bozze delle amminoacil-tRNA sintetasi 493 14.4 L’inizio della traduzione 496 Formazione e caricamento del complesso ternario sulla subunità ribosomale 40S 496 Caricamento dell’mRNA sulla subunità ribosomale 40S 496 Scansione e riconoscimento dell’AUG 498 Strumenti 14.1 Saggi di toeprinting della traduzione 499 Unione delle subunità ribosomali 40S e 60S 501 14.5 Allungamento 501 Malattia 14.1 Il fattore di inizio eucariotico 2B e la scomparsa della materia bianca 501 Decodificazione 503 Formazione del legame peptidico e traslocazione 503 L’attività peptidiltrasferasica 503 Gli eventi nel tunnel ribosomale 509 14.6 Terminazione 509 14.7 Controllo traduzionale e post-traduzionale 510 La fosforilazione di eIF2α blocca la formazione del complesso ternario 511 La fosforilazione di eIF2α è mediata da quattro proteina chinasi distinte 512 Riassunto del capitolo 515 Domande analitiche 517 Letture consigliate 517 Capitolo 15 Organismi geneticamente modificati: il loro uso nella ricerca di base e applicata 15.1 Introduzione 519 15.2 I topi transgenici 520 Come si produce un topo transgenico 521 Focus 15.1 Il brevetto dell’oncotopo 521 Topi transgenici inducibili 524 15.3 Modelli di topi con un gene alterato 524 Focus 15.2 Un topo per ogni necessità 526 Topi knockout 526 Topi knockin 528 Topi knockdown 530 Topi knockout e knockin condizionali 531 15.4 Altre applicazioni della tecnologia degli animali transgenici 531 Focus 15.3 Arte transgenica: la coniglietta GFP 533 Primati transgenici 533 Bestiame transgenico 534 Gene pharming 534 15.5 Clonazione mediante trasferimento nucleare 534 Equivalenza genetica dei nuclei delle cellule somatiche: esperimenti di clonazione delle rane 536 Clonazione di mammiferi mediante trasferimento nucleare 536 “La scoperta dell’anno”: la clonazione di Dolly 536 Metodo di clonazione mediante trasferimento nucleare 539 La fonte di mtDNA nei cloni 541 Perché la clonazione mediante trasferimento nucleare è inefficiente? 541 Focus 15.4 Animali da compagnia manipolati geneticamente 543 Applicazioni della clonazione mediante trasferimento nucleare 545 15.6 Piante transgeniche 547 Focus 15.5 Raccolti geneticamente modificati: state mangiando pomodori ingegnerizzati geneticamente? 549 Trasferimento di geni mediato da T-DNA 550 Elettroporazione e microbalistica 550 Riassunto del capitolo 550 Domande analitiche 552 Letture consigliate 553 Capitolo 16 L’analisi del genoma: tipizzazione del DNA, genomica e oltre 16.1 Introduzione 555 16.2 La tipizzazione del DNA 556 Focus 16.1 I profili del DNA della marijuana 557 Focus 16.2 La tipizzazione del DNA non umano 558 I polimorfismi del DNA: le basi della tipizzazione del DNA 558 L’analisi dei minisatelliti 560 Analisi basate sulla reazione a catena della polimerasi 563 L’analisi delle brevi ripetizioni in tandem 563 L’analisi del DNA mitocondriale 566 L’analisi del cromosoma Y 567 L’analisi del DNA polimorfico amplificato casualmente (RAPD) 567 16.3 Genomica e oltre 567 Che cos’è la bioinformatica? 568 La genomica 571 La proteomica 571 L’età delle “omiche” 571 16.4 Il Progetto Genoma Umano 571 L’approccio dell’assemblaggio del genoma clone per clone 572 L’approccio a shotgun dell’intero genoma 573 Versioni grezze e sequenze rifinite 573 16.5 Altri genomi sequenziati 573 Focus 16.3 L’analisi comparativa dei genomi: informazioni dal pesce palla e dai polli 575 Cosa sono i geni e quanti ce ne sono nel genoma umano? 577 16.6 Analisi ad alta resa della funzione dei geni 578 Microarray di DNA 578 Array di proteine 578 Spettrometria di massa 580 Focus 16.4 Il proteoma nucleolare 582 16.7 I polimorfismi di singoli nucleotidi 583 Malattia 16.1 La mappatura di SNP associati a malattia: la malattia di Alzheimer 583 Riassunto del capitolo 585 Domande analitiche 587 Letture consigliate 588 Capitolo 17 Biologia molecolare medica 17.1 Introduzione 590 17.2 La biologia molecolare del cancro 591 Attivazione di oncogèni 593 Focus 17.1 Il modo in cui metastatizzano le cellule cancerose: il ruolo di Src 596 Inattivazione di geni soppressori dei tumori 598 Malattia 17.1 L’ipotesi dei “due colpi” di Knudson e il retinoblastoma 599 Malattia 17.2 La terapia genica del cancro: un “proiettile magico”? 603 Focus 17.2 La scoperta della p53 604 Espressione inappropriata di microRNA nel cancro 604 Riarrangiamenti cromosomici e cancro 606 Virus e cancro 607 Malattia 17.3 Il virus del papilloma umano (HPV) e il cancro della cervice uterina 610 Cancerogenesi chimica 613 17.3 Terapia genica 616 I vettori per la terapia genica delle cellule somatiche 616 Focus 17.3 Trasferimento genico mediato da retrovirus: come produrre un “vettore sicuro” 619 Focus 17.4 La prima morte causata dalla terapia genica 621 Ingegneria genetica di miglioramento 621 Terapia genica delle sindromi da immunodeficienza ereditaria 622 Terapia genica della fibrosi cistica 624 Terapia genica dell’HIV-1 625 Focus 17.5 Il ciclo vitale dell’HIV-1 626 17.4 Geni e comportamento umano 628 Comportamento aggressivo, impulsivo e violento 629 Loci di suscettibilità alla schizofrenia 631 Riassunto del capitolo 633 Domande analitiche 635 Letture consigliate 635 Glossario 638 Indice analitico 673 |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
