Fisiologia Clinica dell'apparato Cardiovascolare
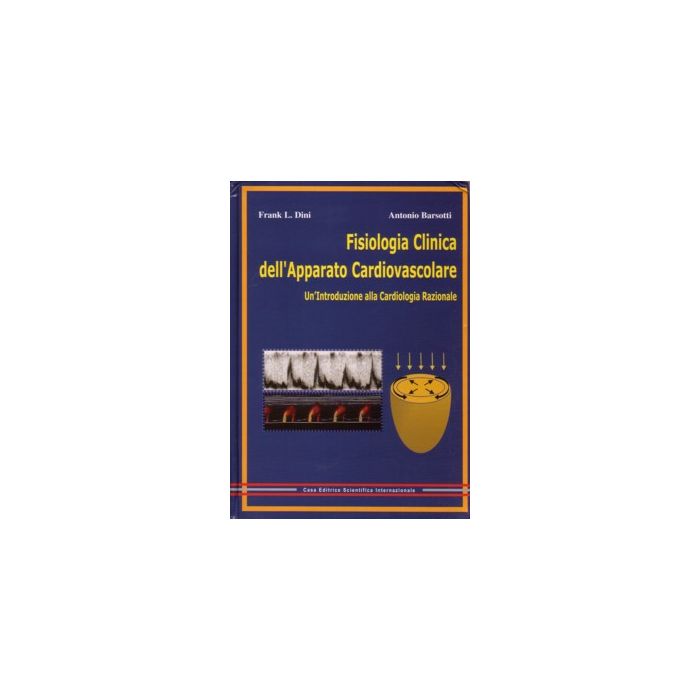
- ISBN/EAN
- 9788886062992
- Editore
- Cesi
- Formato
- Cartonato
- Anno
- 2007
- Pagine
- 1.051
Disponibile
136,00 €
160,00 €
PRESENTAZIONE
L'idea di questo libro, come pure del corso Physician 's Cardiovascular Mechanics and Fluid Dynamics è nata dalla convinzione che, non essendovi risposte semplicistiche a questioni complesse, la trattazione del tema della Fisiologia Cllnica dell'Apparato Cardiovascolare richieda la ricerca di solide basi razionali. Ciò non può non contemplare il coinvolgimento delle Scienze di base (Fisica, Chimica e Matematica) e delle moderne discipline e tecnologie (Biologia molecolare, Genetica, Energetica, Bioingegneria), specialmente in un'epoca in cui all'empirismo della Medicina classica si è andato sostituendo un approccio realisticamente quantitativo ai fenomeni.
Fin dai tempi di Harvey and Hales (XVII secolo), gli studi sperimentali avevano reso evidente come il flusso del sangue avvenga ad opera della propulsione assicurata dalla pompa cardiaca. Poco dopo, furono Malpighi e Borrelli che riconobbero l'importanza della latrofisica e della latromeccanica nello studio della circolazione del sangue. Successivamente, Bernoulli, Hagen e Poiseuille, attraverso la formulazione delle leggi che portano i loro nomi, posero le basi dell'emodinamica, mentre, più tardi, Frank (1895), Starling (1916) e Guyton (1955) descrissero i determinanti della funzione ventricolare: in anni più recenti, con la scoperta dei fattori natriuretici, è poi emersa l'importanza della funzione endocrina del cuore.
Sono ormai parecchi decenni che alla valutazione cllnica dei pazienti si è affiancata la misurazione di parametri fisici strumentali: le pressioni, i/lussi, le resistenze, i volumi, le velocità e i gradienti. Ciò avviene attraverso misurazioni dirette delle variabili o per la loro derivazione grazie a specifiche formule (in un rigoroso controllo dimensionale). Molti di questi parametri sono indicativi dei fenomeni energetici alla base della dinamica cardiaca, circolatoria e del sistema vascolare.
In Fisiologia, come nella Fisica, l'intuizione del profondo significato dell 'Energetica si deve agli importanti contributi degli scienziati tedeschi del XIX secolo, il biochimico Liebig, il medico Mayer e il fisico e fisiologo Helmholtz. Dal loro apporto è venuta la definizione dei principi di conservazione energetica e delle leggi della Termodinamica, che hanno aperto la strada alle scoperte di Einstein del '900 sui rapporti tra Energia e materia. Tuttavia, l'Energetica, insieme alla Genetica, costituisce anche l'essenza della Vita. Gli organismi viventi sono costituiti da molecole organiche che hanno la straordinaria capacità di riprodursi per infinite generazioni, mantenendo costanti le loro strutture nelle quali è iscritto un progetto autonomo e in cui gli aspetti energetici giocano un ruolo cruciale. L'impostazione energetica della funzione del cuore, e i suoi presupposti fisici e biologici, è divenuta ormai Un 'esigenza imprescindibile nell'affrontare la Fisiologia e la Fisiopatologia dell'Apparato Cardiovascolare, giacché forma, struttura e funzione del cuore e della circolazione sono ampiamente vincolate entro definiti limiti energetici.
Il cuore è una straordinaria macchina termodinamica che attraverso la trasformazione dell'energia elettro-magnetica dei combustibili derivati dal carbonio in energia meccanica e quindi in calore permette al sangue di circolare, così da diffondere alle cellule i nutrienti per le ossidoriduzioni della Vita. Normalmente, il funzionamento del cuore tende a svolgersi nelle migliori condizioni di efficienza energetica, ma fatalmente ogni singolo battito lo rende sempre meno efficiente (aumento di entropia) e lo avvicina all'esito finale. Pur con notevoli margini di adattabilità (la riserva), i vincoli energetici espongono il sistema a perturbazioni (le malattie) e a processi di naturale esaurimento (I 'invechiamento). Queste considerazioni erano già state, in parte, espresse nel volume di Herbert Levine "Clinical Cardiovascular Physiology" (1976) ed è in omaggio a questo Autore che è stato scelto il titolo del libro.
Oggi, nell 'era della Medicina basata sulle evidenze, sembra possibile guidare il ragionamento clinico sulla base di un approccio razionale che coniughi le considerazioni energetiche con gli apporti che provengono dalle moderne tecniche strumentali (ecocardiografìa, cardiologia nucleare, risonanza magnetica), dai contributi delle Scienze di Laboratorio (Biochimica e Biologia Molecolare) e della modellistica computazionale. Alla luce delle considerazioni esposte, abbiamo, dunque, voluto affrontare il tema della Fisiologia Clinica Cardiovascolare avvalendosi anche del contributo di esperti fisici ed ingegneri, comunque limitando una troppo rigida impostazione fisico-matematica. Nella speranza che l'arduo compito che ci siamo posti nel tentativo di coniugare il rigore scientifico e le esigenze di comprensione del clinico non sia risultato del tutto velleitario, auguriamo buona lettura.
Maggiori Informazioni
| Autore | Dini Frank L.; Barsotti Antonio |
|---|---|
| Editore | Cesi |
| Anno | 2007 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | CAPITOLO I: Organizzazione strutturale del miocardio 1.1. Generalità 1.2. Organizzazione macroscopica 1.3. Organizzazione microscopica 1.4. Il sistema delle membrane di conduzione 1.5. I mitocondri: centrale energetica della cellula 1.6. Basi cellulari della traduzione dell'energia 1.7. Il citoscheletro CAPITOLO II: Energia, Materia e Sistemi Biologici 2.1. Il concetto fisico di energia 2.2. Bioenergetica e termodinamica 2.3. Le basi biomeccaniche dell'energetica 2.4. Le leggi di conservazione 2.5. La termodinamica dei sistemi biologici 2.6. Forme microscopiche di energia, rendimento e bilanci energetici. 2.7. Il cuore come sistema termodinamico 2.8. Leggi di Newton e fluidodinamica 2.9. Leggi di conservazione e fluidodinamica CAPITOLO III: II Cuore come Pompa 3.1. Le basi dell'emodinamica 3.2. La pressione 3.3. La pressione del sangue 3.4. Il flusso e la portata 3.5. La funzione di pompa cardiaca e la propulsione del sangue 3.6. Il ciclo della pompa cardiaca (il diagramma di Wiggers) 3.7. La modellistica cardiovascolare 3.8. I dispositivi di assistenza ventricolare 3.9. Il cuore totalmente artificiale CAPITOLO IV: Onde di Pressione, Portata Cardiaca e Resistenze 4.1. Onde di pressione 4.2. La gettata sistolica, la portata cardiaca e la frazione di eiezione 4.2. Misura della portata cardiaca 4.4. Indici emodinamici derivati 4.5. Emodinamica durante esercizio CAPITOLO V: Le Basi Biochimiche dell'Energetica del Cuore 5.1. I composti fosfati altamente energetici 5.2. Fonti energetiche e metabolismo cardiaco 5.3. Le vie metaboliche esoergoniche e il catabolismo dei glucidi 5.4. Le vie metaboliche esoergoniche e il catabolismo dei lipidi 5.5. Il ciclo degli acidi tricarbossilici 5.6. La respirazione cellulare 5.7. Consumo di ossigeno e metabolismo ossidativo mitocondriale CAPITOLO VI: Dall'Accoppiamento Elettro-meccanico alle Fasi del Ciclo Cardiaco: Prima Parte 6.1. Introduzione 6.2. Potenziale di membrana e potenziale d azione 6.3. I canali ionici del sarcolemma 6.4. La pompa sodio-potassio 6.5. Efflusso di calcio CAPITOLO VII: Dall'Accoppiamento Elettro-meccanico alle Fasi del Ciclo Cardiaco: Seconda Parte 7.1. Il calcio e l'apparato contrattile 7.2. Il reticolo sarcoplasmatico 7.3. Le basi molecolari dell'attività meccanica del cuore; la contrazione 7.4. Controllo intrinseco della contrazione 7.5. Le basi molecolari dell'attività meccanica del cuore: il rilasciamento CAPITOLO VIII: I Meccanismi della Contrazione Cardiaca 8 1. Le caratteristiche meccaniche del tessuto miocardico 8.2. I rapporti stress-deformazione e la relazione diastolica pressione-volume 8.3. Le forme elementari di contrazione e il postulato di Hill 8.4. La relazione lunghezza-tensione attiva 8.5. Le curve di equilibrio di Frank e la relazione forza-accorciamento 86 La relazione forza-velocità; le basi molecolari 8.7. La relazione forza-velocità: implicazioni funzionali CAPITOLO IX: Le Leggi del Cuore 9.1. Introduzione 9.2. La legge del tutto o nulla del cuore 9.3. La legge di Frank-Starling 9.4. Implicazioni della legge di Frank-Starling 9.5. Teorie per valutare le tensioni del miocardio 9.6. La legge di Laplace 9.7. La curva di funzione di pompa: i principi 9.8. La curva di funzione di pompa: implicazioni cliniche CAPITOLO X: I Determinanti della Funzione Ventricolare nella Sistole 10.1. La funzione sistolica 10.2. Il precarico 10.3. Il postcarico 10.4. La contrattilità 10.5. La frequenza cardiaca CAPITOLO XI: La Dinamica del Cuore e i Diagrammi di Lavoro 11.1. Il lavoro del cuore 11.2. La potenza del cuore 11.3. I diagrammi pressione-volume 114 Effetti del precarico e del postcarico sui diagrammi pressione-volume . 11.5. La relazione telesistolica pressione-volume e l'elastanza ventricolare CAPITOLO XII: La Termodinamica del Cuore 12.1. I trasferimenti di energia 12.2. Dall'energia chimica all'energia meccanica 12.3. Produzione di calore nel muscolo scheletrico 12.4. L'energetica del miocardio 12.5. Lavoro del cuore e consumo di ossigeno 12.6. L'efficienza cardiaca 12.7. Le implicazioni del secondo principio della Termodinamica CAPITOLO XIII: Geometria e Funzione Ventricolare 13.1. Introduzione 13.2. Anatomia delle pareti ventricolari 13.3. Le basi della dinamica cardiaca 13.4. Lo stress parietale e la dinamica ventricolare 13.5. Forme geometriche del ventricolo sinistro 13.6. Definizione della geometria statica del ventricolo sinistro 13.7. Rapporti tra geometria e funzione ventricolare: la geometria dinamica 13.8. Rapporti tra volumi e funzione nel ventricolo normale 13.9. Variazioni della geometria e dei volumi come risposta alla disfunzione ventricolare 13.10. Conclusioni CAPITOLO XIV: Quantificazione dei Volumi Ventricolari e della Frazione di Eiezione 14.1. Considerazioni preliminari 14.2. I metodi angiografìci 14.3. I metodi ecocardiografici 14.4. Misura della frazione di eiezione 14.5. Significato prognostico dei volumi ventricolari e della frazione di eiezione 14.6. L'ecocontrastografìa nella stima dei volumi e della frazione di eiezione 14.7. Le nuove prospettive dell'imaging: Eco tridimensionale, risonanza magnetica e tecniche radiologiche CAPITOLO XV: Oltre la Frazione di Eiezione: Gli Indici di Contrattilità 15.1. Alla ricerca di un indice puro di contrattilità 15.2. La critica della frazione di eiezione 15.3. Indici isovolumetrici 15.4. Indici della fase di eiezione 15.5. La relazione pressione e volume telesistolici 15.6. L'accorciamento centro-parietale 15.7. Movimento longitudinale dell'anello valvolare mitralico 15.8. I parametri di deformazione miocardica 15.9. La relazione forza-frequenza e l'ecocardiografia 15.10. L'indice di funzione miocardica CAPITOLO XVI: I Determinanti della Funzione Ventricolare nella Diastole 16.1. La funzione diastolica 16.2. Il significato del rilasciamento 16.3. Il rilasciamento e i suoi determinanti 16.4. La rigidità ventricolare e la relazione diastolica pressione-volume 16.5. Il riempimento ventricolare 16.6. I determinanti del riempimento ventricolare CAPITOLO XVII: Ecocardiografia-Doppler e Funzione Diastolica del Ventricolo Sinistro 17.1. Il Doppler e lo studio della funzione diastolica 17.2. Le basi dello studio Doppler della diastole 17.3. Il flusso transmitralico e il tempo di rilasciamento isovolumetrico 17.4. I profili Doppler di funzione diastolica: caratteristiche e valenza clinica 17.5. Variabilità biologica, limitazioni e fonti di errore del Doppler transmitralico 17.6. Nuove tecnologie Doppler CAPITOLO XVIII: La Funzione Atriale Sinistra e il Flusso nelle Vene Polmonari 18.1. Cenni anatomici 18.2. La funzione atriale sinistra 18.3. Onde di pressione e dinamica del flusso venoso polmonare 18.4. Valore clinico delle dimensioni e della funzione atriale sinistra 18.5. Valore clinico dello studio del flusso venoso polmonare 18.6. Variabilità biologica, limitazioni e fonti di errore CAPITOLO XIX: Valutazione Emodinamica Non Invasiva; Prima Parte 19.1. Applicazioni dell'eco-Doppler allo studio dell'emodinamica 19.2. I principi della valutazione emodinamica non invasiva 19.3. Doppler mitralico e venoso polmonare e stima delle pressioni di riempimento ventricolare sinistro 19.4. Utilità dell'analisi combinata del flusso mitralico e venoso polmonare 19.5. Contributo del Doppler tissutale e del Color M-mode 19.6. E possibile una valutazione emodinamica completamente non invasiva? 19.7. Considerazioni conclusive CAPITOLO XX: Valutazione Emodinamica Non Invasiva: Seconda Parte 20.1. Valutazione delle pressioni in arteria polmonare 20.2. Stima eco-Doppler diretta delle pressioni polmonari 20.3. Stima ecocardiografica indiretta delle pressioni polmonari 20.4. Stima delle resistenze vascolari polmonari CAPITOLO XXI: Analisi della Funzione Ventricolare Sinistra Regionale: Prima Parte 21.1. Funzione regionale: introduzione 21.2. Le asinergie di contrazione in un numero: il Wall Motion Score Index 21.3. Le basi della valutazione dinamica della funzione regionale nella ricerca dell'ischemia 21.4. La cascata ischemica e la compromissione della funzione regionale 21.5. Valutazione della funzione regionale in condizioni dinamiche: gli stress ischemizzanti 21.6. Analisi della funzione regionale negli stress ischemizzanti 21.7. Valutazione della funzione regionale nell'infarto miocardico acuto 21.8. Valore dell'eco stress nella stratificazione prognostica in pazienti con o senza infarto pregresso CAPITOLO XXII: Analisi della Funzione Ventricolare Sinistra Regionale: Seconda Parte 22.1. Il ruolo delle nuove tecnologie Doppler 22.2. Doppler tissutale: modalità di presentazione 22.3. Doppler tissutale e funzione diastolica regionale 22.4. Studio della deformazione e della velocita di deformazione miocardica 22.5. Significato dei parametri di deformazione miocardica 22.6. Doppler tissutale ed eco stress 22.7. Conclusioni CAPITOLO XXIII: II Ventricolo Destro: Dalla Fisiologia agli Indici di Funzione 23.1. Il ventricolo destro: la camera trascurata 23.2. Il ventricolo destro: anatomia e fisiologia 23.3. Studio della funzione ventricolare destra 23.4. La disfunzione ventricolare destra nelle cardiopatie 23.5. Conclusioni CAPITOLO XXIV: Interazioni Ventricolari 24.1. Interazione interventricolare 24.2. Interazioni cuore-polmoni 24.3. Effetti del pericardio 24.4. Influenza della vascolarizzazione coronarica 24.5. Rilevanza clinica dell'interdipendenza ventricolare e dell'effetto di contenzione pericardico CAPITOLO XXV: Dalla Fluidodinamica alla Emodinamica: Flusso, Pressioni e Resistenze 25.1. La natura dei fluidi 25.2. Caratteristiche del moto di un fluido 25.3. La viscosità 25.4. Relazione tra pressione e flusso: l'equazione di Hagen-Poìseuille 25.5. Applicabilità e limiti dell'equazione di Hagen-Poiseuille 25.6. Le resistenze al flusso 25.7. Moto vorticoso 25.8. Caratteristiche del jet CAPITOLO XXVI: Energetica della Circolazione: Dalle Misure di Velocità alle Misure di Flusso 26.1. La velocità del sangue 26.2. La velocità del sangue e le equazioni del Doppler 26.3. Le velocità di flusso normali 26.4. Equazione di continuità e legge della portata 26.5. Le basi della misura eco-doppler della portata cardiaca 26.6. Metodi di misura della portata cardiaca CAPITOLO XXVII: Energetica della Circolazione: Dalle Misure di Velocità ai Gradienti di Pressione 27.1. Dinamica ed energetica del flusso sanguigno 27.2. Legge di Hagen-Poiseuille ed energetica del flusso 27.3. Calcolo del gradiente di pressione attraverso un restringimento: l'equazione di Bernoulli 27.4. L'equazione di Bernoulli-Poiseuille 27.5. Equazione di Bernoulli semplificata 27.6. Il gradiente pressorio transvalvolare aortico 27.7. Misura del gradiente pressorio aortico: confronto tra Doppler e cateterismo cardiaco 27.8. Il gradiente pressorio transvalvolare mitralico 27.9. Valori assoluti della pressione in una camera cardiaca CAPITOLO XXVIII: Energetica della Circolazione: Misura delle Aree Valvola 28.1. Misura delle aree valvolari: razionale 28.2. Calcolo dell'area di un orifizio valvolare: la formula di Gorlin e Gorlin 28.3. Equazione di continuità ed ecocardiografia Doppler: misurazione dell'area valvolare 28.4. Tempo di dimezzamento del gradiente pressorio 28.5. Orifìzio rigurgitante effettivo CAPITOLO XXIX: Vasi Sanguigni e Circolazione del Sangue 29.1. Struttura e funzione dei vasi sanguigni 29.2. Rapporti tra tensione parietale e pressione transmurale 29.3. Tensione elastica e distensibilità arteriosa 29.4. Effetti dell'elasticità dei vasi 29.5. L'accoppiamento ventricolo-arterioso 29.6. Riflessioni del polso di pressione e dell'onda pulsatoria 29.7. Le resistenze nella circolazione 29.8. Diagnostica strumentale in angiologia CAPITOLO XXX: II Sistema Venoso e l'Atrio Destro 30.1. Sistema venoso: pressioni e flusso 30.2. Sistema venoso: volume e compliance 30.3. I determinanti del pressione venosa centrale e del ritorno venoso 30.4. Le curve di ritorno venoso 30.5. La relazione ritorno venoso-portata cardiaca 30.6. Atrio destro: cenni anatomici 30.7. La pressione atriale destra in condizione fisiologiche e patologiche 30.8. Metodi strumentali di valutazione della pressione atriale destra CAPITOLO XXXI: II Controllo della Circolazione: Le Vie Nervose Afferenti 31.1. Basi della regolazione estrinseca della circolazione 31.2. Controllo nervoso del sistema cardiovascolare 31.3. I sensori cardio-polmonari 31.4. I chemocettori 31.5. I barocettori arteriosi 31.6. I centri nervosi cardioregolatori CAPITOLO XXXII; II Controllo della Circolazione: II Sistema Endocrino 32.1. Controllo endocrino del sistema cardiovascolare 32.2. Il sistema renina-angiotensina renaie-sistemico 32.3. I sistemi renina-angiotensina tissutali 32.4. I recettori dell'angiotensina II 32.5. L'aldosterone 32.6. Le catecolamine 32.7. Le endoteline 32.8. Adiuretina-vasopressina 32.9. I peptidi natriuretici cardiaci 32.10. Estrogeni, androgeni, ormoni glucocorticoidi, ormone della crescita ed insulina 32.11. Ormoni tiroidei e cuore CAPITOLO XXXIII: II Controllo della Circolazione: II Sistema Nervoso Vegetativo 33.1. Sistema nervoso vegetativo: vie efferenti e mediatori chimici 33.2. Il sistema di transduzione recettoriale: i recettori 33.3. Il sistema di transduzione recettoriale: le proteine G, i secondi messaggeri e le proteinchinasi 33.4. Il sistema di transduzione recettoriale: recettori colinergici e adrenergici 33.5. Effetti del simpatico e del parasimpatico sul cuore 33.6. La bilancia simpato-vagale e la variabilità della frequenza cardiaca 33.7. Effetti del simpatico e del parasimpatico sui vasi 33.8. La bilancia simpato-vagale e la variabilità della pressione arteriosa CAPITOLO XXXIV: II Controllo della Circolazione: il Muscolo Liscio Vascolare 34.1. Muscolo liscio vascolare: caratteristiche morfologiche 34.2. La muscolatura liscia vascolare: proprietà fìsiologiche 34.3. Tono vasomotore e controllo del circolo 34.4. Meccanismi di controllo locale del circolo 34.5. Autoregolazione, iperemia attiva e reattiva 34.6. Controllo estrinseco delle resistenze vascolari: fattori nervosi 34.7. Controllo estrinseco delle resistenze vascolari: sostanze vasoattive 34.8. Interazioni tra simpatico, parasimpatico e angiotensina II CAPITOLO XXXV: II Controllo della Circolazione: l'Endotelio 35.1. Generalità 35.2. Il nitrossido e regolazione del tono vasale 35.3. I fattori iperpolarizzanti responsabili della vasodilatazione endotelio-dipendente 35.4. L'endotelina e la vasocostrizione endotelio-dipendente 35.5. I prostanoidi vasoattivi 35.6. Endotelio e regolazione dell'emostasi 35.7. Altre funzioni dell'endotelio 35.8. Metodi di valutazione della funzione endoteliale |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
