Fisica per le scienze della vita
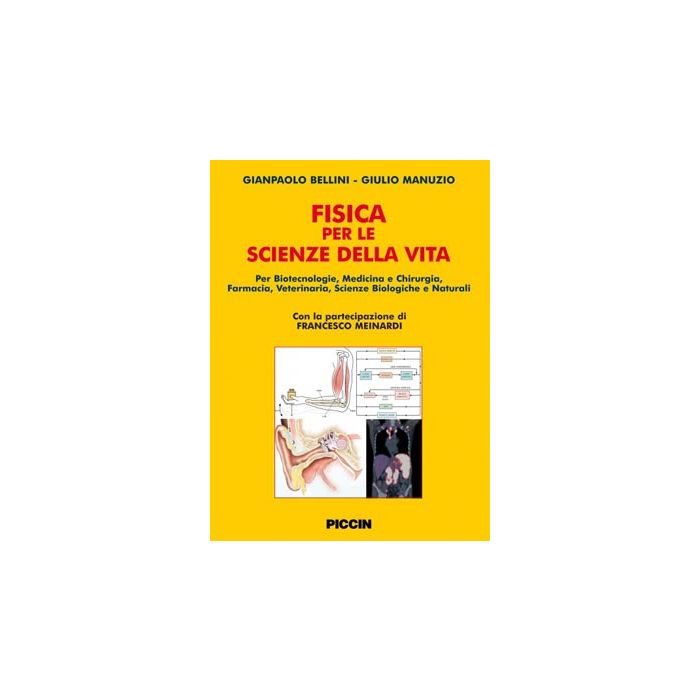
- ISBN/EAN
- 9788829920617
- Editore
- Piccin Editore
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2010
- Pagine
- 856
Disponibile
64,00 €
FISICA PER LE SCIENZE DELLA VITA.
Per i Corsi di Laurea in Biotecnologie, Medicina e Chirurgia, Farmacia, Veterinaria, Scienze Biologiche e Naturali
Prefazione In passato troppo spesso l’insegnamento della fisica agli studenti di corsi di laurea in Scienze della Vita ricalcava in tutto o in parte analoghi insegnamenti rivolti a studenti di Fisica o di Ingegneria. Solo per citare un esempio, si insisteva ad introdurre il concetto di entropia, basilare in biologia, ricorrendo alla trattazione e agli enunciati utilizzati per comprendere come sia possibile costruire delle macchine termiche; così facendo si rinunciava a trovare la relazione tra l’entropia e la dinamica dei fenomeni diffusivi e dei fenomeni chimici, un collegamento assolutamente centrale per la comprensione dei fenomeni vitali. La situazione è cambiata in anni recenti, ma si è assistito al fiorire di insegnamenti, spesso costretti a limitare l’insegnamento della fisica entro corsi con un ristretto numero di crediti e di ore e che si appoggiano a manuali di solito piuttosto essenziali. Questo testo di Fisica per le Scienze della Vita è rivolto agli studenti di Biotecnologie, Medicina e Chirurgia, Farmacia, Veterinaria, Scienze Biologiche e Naturali; vuole essere un testo vero e proprio, costruito pensando alle necessità culturali di questa tipologia di studenti e organizzato in vari livelli che consentano, oltre ad un apprendimento di primo livello, una varietà di approfondimenti. Il primo livello, in corpo 11,5, riguarda la fisica che viene di solito svolta, in tutto o in parte, nei corsi di Fisica tenuti agli studenti delle Scienze della Vita. Vi vengono svolti gli argomenti di Meccanica, di Meccanica dei Fluidi, di Termodinamica, di Onde (Ottica e Acustica), di Elettromagnetismo e i Cenni di Fisica Moderna. Essi sono pesati in modo diverso a seconda delle necessità specifiche degli studenti di materie biologiche, mediche, biotecnologiche, ecc.. Il docente potrà scegliere quali di queste parti utilizzare nel suo insegnamento, in funzione della impostazione adottata e delle particolari esigenze del corso di Laurea. Per venire incontro agli studenti che non hanno dei corsi obbligatori di Matematica, e comunque per comodità dello studente, è stato inserito un capitolo riguardante “Elementi di Calcolo” ove, fra l’altro, vi sono delle tabelle che danno le soluzioni delle derivate e integrali più usati, nonché utili relazioni trigonometriche. La valutazione della indeterminazione insita in ogni misura (detta errore di misura) è fondamentale nelle Scienze Sperimentali e riguarda quindi anche le Scienze della Vita, nelle quali spesse volte viene trascurata. Premessa alla trattazione degli errori è una conoscenza di base della Statistica, che in alcuni corsi di Laurea è inserita in un corso obbligatorio, ma in altri è assente. Abbiamo quindi cercato di colmare queste lacune inserendo un capitolo: “Cenni di Statistica e di Teoria degli Errori” Un secondo livello di argomenti presenti nel testo e evidenziati mettendoli in corpo 10, consiste in approfondimenti di parti trattate nel primo livello, non strettamente indispensabili per gli studenti di Scienze della Vita, oppure di argomenti utili alla comprensione delle Applicazioni della Fisica alla Biologia, Medicina, Biotecnologie ed alle altre Scienze della Vita, che vengono trattate in un terzo livello. Questo terzo livello consiste nelle Applicazioni della Fisica alle Scienze della Vita. Queste Applicazioni riguardano tutte le parti della Fisica e sono usufruibili dagli studenti in qualunque anno di corso e in relazione a corsi di Anatomia, Fisiologia, Biochimica, ecc.. Lo studente può trovare anche in anni successivi a quelli nei quali vengono tenuti i corsi di Fisica la spiegazione di Meccanismi e di Fenomeni, che studia in altre discipline, trattati in modo coerente e consequenziale con la parte di Fisica fatta nei primi anni. Vengono esposte anche le basi fisiche della strumentazione più comunemente utilizzata nelle Scienze della Vita. Soprattutto con il secondo e il terzo livello si tenta un’ integrazione fra la Fisica e quelle parti delle Scienze della Vita che hanno alla loro base i fenomeni spiegati dalla Fisica. Segnaliamo che in alcuni casi il docente può anche decidere di introdurre qualche argomento di Fisica iniziando dalle Applicazioni per far intuire allo studente la necessità della conoscenza delle leggi fisiche. Il contenuto del testo del primo e secondo livello è corredato da Quesiti, Problemi, Esercizi, completamente risolti oppure risolti parzialmente, con una traccia di soluzione. Speriamo con questo testo di aver colmato una lacuna della pubblicistica scientifica italiana, a livello didattico. Saremmo in ogni caso lieti di sapere che abbiamo contribuito a migliorare la presentazione di argomenti di fisica agli studenti che si accingono a dedicare la loro vita ad un settore importante e fondamentale, e destinato a grande sviluppo futuro, quale quello costituito dalle cosiddette Scienze della Vita. Gianpaolo Bellini Giulio Manuzio
Per i Corsi di Laurea in Biotecnologie, Medicina e Chirurgia, Farmacia, Veterinaria, Scienze Biologiche e Naturali
Prefazione In passato troppo spesso l’insegnamento della fisica agli studenti di corsi di laurea in Scienze della Vita ricalcava in tutto o in parte analoghi insegnamenti rivolti a studenti di Fisica o di Ingegneria. Solo per citare un esempio, si insisteva ad introdurre il concetto di entropia, basilare in biologia, ricorrendo alla trattazione e agli enunciati utilizzati per comprendere come sia possibile costruire delle macchine termiche; così facendo si rinunciava a trovare la relazione tra l’entropia e la dinamica dei fenomeni diffusivi e dei fenomeni chimici, un collegamento assolutamente centrale per la comprensione dei fenomeni vitali. La situazione è cambiata in anni recenti, ma si è assistito al fiorire di insegnamenti, spesso costretti a limitare l’insegnamento della fisica entro corsi con un ristretto numero di crediti e di ore e che si appoggiano a manuali di solito piuttosto essenziali. Questo testo di Fisica per le Scienze della Vita è rivolto agli studenti di Biotecnologie, Medicina e Chirurgia, Farmacia, Veterinaria, Scienze Biologiche e Naturali; vuole essere un testo vero e proprio, costruito pensando alle necessità culturali di questa tipologia di studenti e organizzato in vari livelli che consentano, oltre ad un apprendimento di primo livello, una varietà di approfondimenti. Il primo livello, in corpo 11,5, riguarda la fisica che viene di solito svolta, in tutto o in parte, nei corsi di Fisica tenuti agli studenti delle Scienze della Vita. Vi vengono svolti gli argomenti di Meccanica, di Meccanica dei Fluidi, di Termodinamica, di Onde (Ottica e Acustica), di Elettromagnetismo e i Cenni di Fisica Moderna. Essi sono pesati in modo diverso a seconda delle necessità specifiche degli studenti di materie biologiche, mediche, biotecnologiche, ecc.. Il docente potrà scegliere quali di queste parti utilizzare nel suo insegnamento, in funzione della impostazione adottata e delle particolari esigenze del corso di Laurea. Per venire incontro agli studenti che non hanno dei corsi obbligatori di Matematica, e comunque per comodità dello studente, è stato inserito un capitolo riguardante “Elementi di Calcolo” ove, fra l’altro, vi sono delle tabelle che danno le soluzioni delle derivate e integrali più usati, nonché utili relazioni trigonometriche. La valutazione della indeterminazione insita in ogni misura (detta errore di misura) è fondamentale nelle Scienze Sperimentali e riguarda quindi anche le Scienze della Vita, nelle quali spesse volte viene trascurata. Premessa alla trattazione degli errori è una conoscenza di base della Statistica, che in alcuni corsi di Laurea è inserita in un corso obbligatorio, ma in altri è assente. Abbiamo quindi cercato di colmare queste lacune inserendo un capitolo: “Cenni di Statistica e di Teoria degli Errori” Un secondo livello di argomenti presenti nel testo e evidenziati mettendoli in corpo 10, consiste in approfondimenti di parti trattate nel primo livello, non strettamente indispensabili per gli studenti di Scienze della Vita, oppure di argomenti utili alla comprensione delle Applicazioni della Fisica alla Biologia, Medicina, Biotecnologie ed alle altre Scienze della Vita, che vengono trattate in un terzo livello. Questo terzo livello consiste nelle Applicazioni della Fisica alle Scienze della Vita. Queste Applicazioni riguardano tutte le parti della Fisica e sono usufruibili dagli studenti in qualunque anno di corso e in relazione a corsi di Anatomia, Fisiologia, Biochimica, ecc.. Lo studente può trovare anche in anni successivi a quelli nei quali vengono tenuti i corsi di Fisica la spiegazione di Meccanismi e di Fenomeni, che studia in altre discipline, trattati in modo coerente e consequenziale con la parte di Fisica fatta nei primi anni. Vengono esposte anche le basi fisiche della strumentazione più comunemente utilizzata nelle Scienze della Vita. Soprattutto con il secondo e il terzo livello si tenta un’ integrazione fra la Fisica e quelle parti delle Scienze della Vita che hanno alla loro base i fenomeni spiegati dalla Fisica. Segnaliamo che in alcuni casi il docente può anche decidere di introdurre qualche argomento di Fisica iniziando dalle Applicazioni per far intuire allo studente la necessità della conoscenza delle leggi fisiche. Il contenuto del testo del primo e secondo livello è corredato da Quesiti, Problemi, Esercizi, completamente risolti oppure risolti parzialmente, con una traccia di soluzione. Speriamo con questo testo di aver colmato una lacuna della pubblicistica scientifica italiana, a livello didattico. Saremmo in ogni caso lieti di sapere che abbiamo contribuito a migliorare la presentazione di argomenti di fisica agli studenti che si accingono a dedicare la loro vita ad un settore importante e fondamentale, e destinato a grande sviluppo futuro, quale quello costituito dalle cosiddette Scienze della Vita. Gianpaolo Bellini Giulio Manuzio
Maggiori Informazioni
| Autore | Bellini G - Manuzio G. |
|---|---|
| Editore | Piccin Editore |
| Anno | 2010 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | 1 I1 La Scienza e le grandezze fisiche . . . . . . . . 1 I2 Il metodo scientifico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I3 L’osservazione operazionale delle grandezze fisiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 I4 Una classificazione delle Scienze . . . . . . . . 8 I5 La Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I6 Il metodo sperimentale . . . . . . . . . . . . . . . . 11 I7 Cosa significa eseguire una misura . . . . . . 13 I8 I sistemi di unità di misura . . . . . . . . . . . . . 14 I9 Il linguaggio della fisica. . . . . . . . . . . . . . . . 15 I10 La Fisica per le Scienze della vita . . . . . . . . 16 C Elementi di calcolo . . . . . . . . . . . . 17 C1 Funzioni e diagrammi. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 C1.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 C1.2 Funzioni di una sola variabile . . . . . . . . 19 C1.3 Diagramma di una funzione e sua rappresentazione grafica . . . . . . . . 19 C1.4 Rappresentazione grafica di alcune funzioni comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 C2 Logaritmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 C2.1 Proprietà dei logaritmi . . . . . . . . . . . . . . 24 C2.2 La scala logaritmica . . . . . . . . . . . . . . . . 25 C2.3 La funzione logaritmo . . . . . . . . . . . . . . 25 C3 Elementi di trigonometria . . . . . . . . . . . . . . 26 C3.1 Le variabili angolari . . . . . . . . . . . . . . . . 26 C3.2 Le funzioni circolari . . . . . . . . . . . . . . . . 27 C3.3 Alcune proprietà delle funzioni trigonometriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 C3.4 Rappresentazione grafica delle funzioni circolari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 C3.5 L’angolo solido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 C4 I vettori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 C4.1 Algebra dei vettori . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 C4.2 Componenti di un vettore . . . . . . . . . . . 35 C5 Alcuni simboli matematici utilizzati in fisica 37 C6 Limite di una funzione . . . . . . . . . . . . . . . . 38 C7 Derivata di una funzione. . . . . . . . . . . . . . . 40 C7.1 Regole di calcolo delle derivate . . . . . . . 42 C7.2 Derivata di un vettore . . . . . . . . . . . . . . 44 C7.3 Derivate successive e studio delle funzioni 45 C8 Funzione di più variabili . . . . . . . . . . . . . . . 47 C9 La derivata parziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 C10 Cenni agli sviluppi in serie . . . . . . . . . . . . . 49 C11 L’integrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 C11.1 L’integrale definito . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 C12 Cenni alle equazioni differenziali . . . . . . . . 54 TE Cenni di statistica e teoria degli errori . . . . . . . . . . . . 57 TE1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 TE2 Frequenza assoluta e relativa. . . . . . . . . . . . 58 TE3 Elementi caratteristici di una distribuzione di frequenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 TE4 Distribuzioni continue. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 TE5 Nozioni di probabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 TE6 Probabilità a posteriori e frequenza relativa. Teorema di Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 TE7 Alcune distribuzioni di frequenza . . . . . . . . 67 TE8 Distribuzione delle medie e errore standard della media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 TE9 Misura di una grandezza ed errore di osservazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 TE10 Sensibilità di uno strumento ed errore conseguente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 TE11 Indeterminazione di misure indirette . . . . . 74 TE12 Legge di distribuzione degli errori casuali . 75 TE13 Legge di propagazione degli errori . . . . . . . 78 TE14 Combinazione di campioni ottenuti con misure diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 TE15 Correlazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 TE16 L’uso dell’analisi statistica . . . . . . . . . . . . . . 83 TE17 La progettazione dell’esperimento . . . . . . . 83 M Meccanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 M0 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 M1 Forza e energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 M1.1 Generalità sull’energia . . . . . . . . . . . . . . 88 M1.2 Le forze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 M1.3 Forze e moto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 M1.3.1 Forze attive e forze passive . . . . . . . . . 94 M1.3.2 Velocità e accelerazione . . . . . . . . . . . 94 M1.3.3 Moto circolare uniforme. . . . . . . . . . . 100 M1.3.4 II Principio della Dinamica . . . . . . . . 103 M1.4 Grandezze fisiche e dimensioni . . . . . . . 103 M1.5 Il lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 M1.5.1 Forze posizionali e conservative . . . . . 114 M1.6 Le forze gravitazionali . . . . . . . . . . . . . . 116 M1.6.1 La forza peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 M1.7 La terza legge della dinamica. . . . . . . . . 120 M1.8 Forze Coulombiane . . . . . . . . . . . . . . . . 121 M1.9 Le forze di Van der Waals . . . . . . . . . . . 122 M1.10 Le forze elastiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 M1.10.1 Il moto armonico. . . . . . . . . . . . . . . . 125 M1.10.2 Proprietà elastiche dei sistemi continui 127 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 M1.11 Reazioni vincolari e attrito . . . . . . . . . . . 131 M1.11.1 Attrito radente e volvente . . . . . . . . . 132 M1.11.2 Attrito viscoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 M1.11.3 Attrito statico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 M1.12 Forza muscolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 M1.13 Cenno alle forze apparenti . . . . . . . . . . . 137 M1.13.1 Forza centrifuga . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 M1.14 L’energia meccanica. . . . . . . . . . . . . . . . 139 M2 La statica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 M2.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 M2.2 Somma delle forze . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 M2.3 Momento delle forze . . . . . . . . . . . . . . . 147 M2.4 Equazioni cardinali della statica. . . . . . . 151 M2.5 Le leve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 M2.6 Baricentro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 M2.7 Equilibri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 M2.8 Le leggi di scala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 M3 Dinamica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 M3.1 Il sistema di riferimento . . . . . . . . . . . . . 182 M3.1.1 Le forze apparenti. . . . . . . . . . . . . . . . 183 M3.2 Secondo e terzo principio della dinamica 184 M3.3 Lavoro, energia potenziale e energia cinetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 M3.4 Teorema dell’impulso . . . . . . . . . . . . . . . 187 M3.5 Ruolo dell’energia potenziale . . . . . . . . . 190 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 M3.6 Potenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 M3.7 Cenni di dinamica dei sistemi estesi. . . . 199 M3.7.1 Conservazione della quantità di moto 199 M3.7.2 Moto dei sistemi estesi . . . . . . . . . . . . 204 M3.7.3 Conservazione dell’energia in un sistema esteso. . . . . . . . . . . . . . . 206 M3.7.4 Cenni di dinamica del corpo rigido. . . 207 Esercizi e problemi di Meccanica . . . . . . . . 210 Soluzioni ai problemi sulla Meccanica . . . . 214 F Meccanica dei fluidi . . . . . . . . . . . 225 F0 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 F0.1 I fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 F1 Statica dei fluidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 F1.1 Isotropia delle pressioni . . . . . . . . . . . . . 227 F1.2 Variazione della pressione con l’altezza . 228 F1.2.1 Pressione idrostatica . . . . . . . . . . . . . . 229 F1.2.2 Pressione atmosferica . . . . . . . . . . . . . 232 F1.3 Unità di misura della pressione . . . . . . . 233 F1.4 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 F1.5 Misure di pressione: manometri. . . . . . . 237 F1.5.1 Lo sfigmomanometro . . . . . . . . . . . . . 239 F1.6 La spinta di Archimede . . . . . . . . . . . . . 239 F1.6.1 Misure di densità . . . . . . . . . . . . . . . . 241 F2 Fenomeni molecolari. . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 F2.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 F2.2 Tensione superficiale . . . . . . . . . . . . . . . 245 F2.3 Legge di Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 F2.4 Formazione di lamine sottili . . . . . . . . . . 249 F2.5 Capillarità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 F2.6 Misura della tensione superficiale in un liquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 F2.6.1 Metodo delle ascensioni capillari . . . . 253 F2.6.2 Metodo delle gocce. . . . . . . . . . . . . . . 253 F3 Dinamica dei fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 F3.1 Portata e equazione di continuità. . . . . . 254 F3.2 Liquidi non viscosi e teorema di Bernoulli 255 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 F3.3 Liquidi viscosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 F3.4 Moto di un fluido in regime di Poiseuille 261 F3.5 Regime macrovorticoso o idraulico . . . . 265 F3.6 Liquidi non newtoniani . . . . . . . . . . . . . 266 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 F3.7 Legge di Stokes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 F3.8 Misure di viscosità . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Esercizi e problemi sulla Meccanica dei Fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Soluzioni ai problemi sulla Meccanica dei Fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 T Termodinamica . . . . . . . . . . . . . . . 295 T0 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Introduzione ai capitoli di termodinamica e al modo di utilizzarli. . . . . . . . . . . . . . . . . 298 T1 Temperatura e calore . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 T1.1 Definizione di sistema e di variabile termodinamica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 T1.2 Volume e pressione. . . . . . . . . . . . . . . . . 300 T1.3 Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 T1.3.1 Una prima definizione di temperatura 301 T1.3.2 Equazioni di stato . . . . . . . . . . . . . . . . 303 T1.3.3 Contatto termico . . . . . . . . . . . . . . . . 304 T1.3.4 Il concetto di contatto termico completo e la definizione di punti di riferimento a temperatura costante . . . . . . . . . . . . 306 T1.3.5 Pareti diatermiche. . . . . . . . . . . . . . . . 307 T1.3.6 Gas e vapori. La temperatura critica . 308 T1.3.7 L’umidità relativa di un ambiente . . . 309 T1.3.8 Un passo avanti nella definizione di temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 T1.3.9 Studio di un sistema meccanico . . . . . 313 T1.3.10 La teoria cinetica dei gas . . . . . . . . . . 314 T1.3.11 La temperatura dal punto di vista microscopico. Nuova definizione della temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 T1.3.12 La legge di Dalton . . . . . . . . . . . . . . . 318 T1.4 Il calore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 T1.4.1 Il concetto intuitivo di calore . . . . . . . 319 T1.4.2 Le prime misure di calore. Definizione di capacità termica, di calore specifico e di caloria. Il calorimetro di Bunsen. . . 319 T1.4.3 Scambi di calore tra sostanze che non cambiano stato di aggregazione . . . . . 323 T1.4.4 Il calorimetro delle mescolanze . . . . . 324 T1.4.5 Scambi di calore in presenza di sostanze che cambiano stato di aggregazione: i calori latenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 T1.4.6 Evaporazione ed ebollizione. . . . . . . . 327 T1.4.7 Creazione e sparizione di calore . . . . 328 T1.4.8 L’equivalente meccanico della caloria 329 T2 L’energia interna e il primo principio. . . . . 330 T2.1 Il concetto di energia interna . . . . . . . . . 330 T2.2 La misura dell’energia interna . . . . . . . . 332 T2.2.1 L’energia interna dei gas monoatomici 332 T2.2.2 Come far variare l’energia interna di un corpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 T2.2.3 Il ruolo delle forze di attrito . . . . . . . . 334 T2.2.4 I lavori di compressione e di espansione 336 T2.2.5 Forze elastiche ed anelastiche . . . . . . . 340 T2.2.6 L’effetto Joule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 T2.3 Il primo principio della termodinamica. 341 T2.3.1 Il concetto di calore . . . . . . . . . . . . . . 341 T2.3.2 Il primo principio della termodinamica 342 T2.4 Come si misurano le variazioni di energia interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 T2.5 Variazioni di energia interna e parametri macroscopici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 T2.5.1 Commenti alle formule per il calcolo delle variazioni di energia interna . . . 344 T2.6 Variazioni di energia interna e parametri microscopici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 T2.6.1 Il significato microscopico dell’energia interna dei gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 T2.6.2 Il significato microscopico dei calori latenti di passaggio di stato. . . . . . . . . 351 T2.6.3 L’energia interna dei solidi e dei liquidi 353 T2.6.4 Il calore specifico dei solidi e dei liquidi 356 T2.6.5 Trasformazioni di energia interna nelle reazioni chimiche . . . . . . . . . . . . 357 T2.7 La conservazione dell’energia . . . . . . . . 358 T2.8 Il passaggio di calore tra corpi . . . . . . . . 360 T2.8.1 Conduzione di calore . . . . . . . . . . . . . 360 T2.8.2 La convezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 T2.8.3 L’irraggiamento . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 T2.8.4 La perdita di calore per evaporazione 363 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 T3 La termodinamica delle soluzioni. . . . . . . . 366 T3.1 La freccia del tempo. . . . . . . . . . . . . . . . 366 T3.2 Il fenomeno della diffusione e il potenziale chimico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 T3.2.1 L’agitazione termica e i suoi effetti diffusivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 T3.2.2 La diffusione libera nelle soluzioni: la prima legge di Fick . . . . . . . . . . . . . 369 T3.2.3 Molecole e formiche . . . . . . . . . . . . . . 371 T3.2.4 Il concetto macroscopico di forza diffusiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 T3.2.5 Il fenomeno dell’osmosi . . . . . . . . . . . 372 T3.2.6 Pressione osmotica e forze meccaniche 377 T3.2.7 Il potenziale chimico di un soluto . . . 378 T3.3 Studio di equilibri termodinamici . . . . . 380 T3.3.1 Condizioni generali di equilibrio . . . . 380 T3.3.2 Equilibrio di concentrazione . . . . . . . 382 T3.3.3 Equilibri di soluzioni di gas: legge di Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 T3.3.4 La legge d’azione di massa . . . . . . . . . 386 T3.3.5 Equilibri sotto l’azione di forze gravitazionali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 T3.3.6 Equazione di Nernst. . . . . . . . . . . . . . 391 T4 Il secondo principio della termodinamica 393 T4.1 Introduzione: i principi di Clausius e di Kelvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 T4.2 Un concetto limite: le trasformazioni reversibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 T4.3 La non completa equivalenza di calore e lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 T4.3.1 La macchina di Carnot e il suo rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 T4.3.2 Le macchine reali e il loro rendimento 398 T4.4 Una proprietà delle trasformazioni cicliche reversibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 T4.5 La funzione di stato entropia . . . . . . . . . 400 T4.6 Una formula importante . . . . . . . . . . . . 402 T4.7 La funzione di Gibbs . . . . . . . . . . . . . . . 404 T4.8 La funzione di Gibbs e l’equilibrio dei sistemi a temperatura e pressione costante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 T4.9 La funzione entropia da un punto di vista microscopico . . . . . . . . . . . . . . . 406 T4.10 Entropia e probabilità . . . . . . . . . . . . . . 409 T4.11 Entropia e secondo principio della termodinamica. . . . . . . . . . . . . . . . 410 T4.12 La funzione di Gibbs e lo studio delle reazioni chimiche a temperatura e pressione costante . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 T4.13 Entropia e teoria dell’informazione . . . . 413 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 T4.13.1 Processi termodinamici di non equilibrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 T5 I fenomeni di trasporto attraverso le membrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 T5.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Esercizi di Termodinamica . . . . . . . . . . . . . 439 Soluzioni agli esercizi di Termodinamica . . . 447 E Elettromagnetismo . . . . . . . . . . . . 451 E1 Fenomeni elettrici; campi elettrici e magnetici; le equazioni di Maxwell; il concetto di fotone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 E1.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 E1.2 Le forze elementari. . . . . . . . . . . . . . . . . 455 E1.2.1 Un enorme problema . . . . . . . . . . . . . 455 E1.3 La nozione di carica elettrica . . . . . . . . . 456 E1.3.1 La nozione di densità di carica elettrica 457 E1.4 La forza di Lorentz e il concetto di campo 458 E1.4.1 La forza di Lorentz. . . . . . . . . . . . . . . 458 E1.4.2 Il concetto di campo. . . . . . . . . . . . . . 459 E1.5 Sorgenti tipiche di campo elettrico . . . . 461 E1.5.1 Cariche puntiformi . . . . . . . . . . . . . . . 461 E1.5.2 Condensatori piani e cilindrici . . . . . . 464 E1.5.3 La densità di energia associata alla presenza di un campo elettrico. . . . . . 466 E1.5.4 Il campo elettrico attorno ai conduttori 468 E1.5.5 Il dipolo elettrico. . . . . . . . . . . . . . . . . 469 E1.5.6 L’energia di un dipolo elettrico immerso in un campo elettrico. . . . . . 471 E1.6 Le sorgenti tipiche del campo magnetico 472 E1.6.1 Le cariche in moto: corrente elettrica 473 E1.6.2 Le cariche in moto: densità di corrente 474 E1.6.3 Il campo magnetico prodotto da fili rettilinei percorsi da corrente . . . . . . . 475 E1.6.4 I solenoidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 E1.6.5 Spire percorse da corrente . . . . . . . . . 477 E1.6.6 Diamagnetismo e paramagnetismo . . 480 E1.6.7 I magneti permanenti. . . . . . . . . . . . . 481 E1.6.8 Non esistono cariche magnetiche isolate 482 E1.7 Complemento: moti tipici di cariche sotto l’azione di campi elettrici e campi magnetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 E1.7.1 Moto di cariche elettriche in presenza di campi elettrici uniformi . . . . . . . . . 483 E1.7.2 Moto di cariche elettriche in presenza di forze centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 E1.7.3 Moto di cariche elettriche in presenza di campi magnetici uniformi . . . . . . . 484 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 E1.8 Le equazioni di Maxwell . . . . . . . . . . . . 486 E1.8.1 La descrizione delle sorgenti e dei pozzi: il flusso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 E1.8.2 Il flusso del campo elettrico . . . . . . . . 488 E1.8.3 Il flusso del campo magnetico . . . . . . 489 E1.8.4 La descrizione dei vortici: la circuitazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 E1.8.5 La circuitazione dei campi elettrici. . . . 495 E1.8.6 La circuitazione dei campi magnetici 497 E1.8.7 Significato fisico delle leggi di Maxwell 499 E1.9 Le onde elettromagnetiche. . . . . . . . . . . 499 E1.9.1 Le sorgenti dei campi elettrici e magnetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 E1.9.2 Le onde elettromagnetiche piane monocromatiche . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 E1.9.3 Onde piane monocromatiche e teorema di Fourier . . . . . . . . . . . . . . 502 E1.9.4 Un cenno al meccanismo che origina la propagazione delle onde elettromagnetiche . . . . . . . . . . . . . . . . 502 E1.9.5 Lo spettro delle onde elettromagnetiche 503 E1.10 La granularità della radiazione elettromagnetica: il concetto di fotone. . . 505 E1.10.1 L’effetto fotoelettrico. . . . . . . . . . . . . . 505 E1.10.2 Il concetto di fotone . . . . . . . . . . . . . . 506 E2 I circuiti elettrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 E2.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 E2.2 La nozione di circuito elettrico semplice 508 E2.3 La misura delle correnti che fluiscono in un circuito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 E2.3.1 Il verso convenzionale di circolazione della corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 E2.3.2 Forze tra fili percorsi da correnti e campi magnetici. . . . . . . . . . . . . . . . 510 E2.3.3 Strumenti di misura delle correnti elettriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 E2.3.4 Una questione metrologica. La definizione di Ampere . . . . . . . . . . 513 E2.4 La misura delle energie potenziali delle cariche elettriche . . . . . . . . . . . . . . 514 E2.4.1 Il concetto di differenza di potenziale 514 E2.4.2 Elementi di utilizzazione molto particolari: le resistenze . . . . . . . . . . . 516 E2.4.3 Elementi di utilizzazione in serie e in parallelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 E2.4.4 I voltmetri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 E2.5 La misura della energia potenziale delle cariche elettriche: il concetto di forza elettromotrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 E2.6 Circuiti in corrente continua . . . . . . . . . 521 E2.7 I circuiti in corrente alternata . . . . . . . . 526 E2.7.1 Il teorema di Fourier e la decomposizione in perturbazioni sinusoidali . . . . . . . . 526 E2.7.2 Circuiti in corrente alternata formati di sole resistenze . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 E2.7.3 I condensatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 E2.7.4 Carica di un condensatore . . . . . . . . . 532 E2.7.5 L’energia immagazzinata in un condensatore . . . . . . . . . . . . . . . 536 E2.7.6 Il comportamento dei condensatori in corrente alternata . . . . . . . . . . . . . . 536 E2.7.7 Le induttanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 E.2.7.8 L’energia immagazzinata nelle induttanze. . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 E.2.7.9 L’energia posseduta dal campo magnetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 E.2.7.10 I circuiti LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 E2.8 Elementi di circuito a costanti concentrate ed elementi a costanti distribuite . . . . . . 542 E2.9 I cavi coassiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Esercizi di Elettricità . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Soluzioni agli esercizi di Elettricità . . . . . . . 557 O Onde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 O1 Generalità sulle onde . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 O1.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 O1.2 Onde trasversali e onde longitudinali. . . . 562 O1.2.1 Onde sinusoidali . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 O1.2.2 Fase e sua velocità. . . . . . . . . . . . . . . . 565 O1.3 Sovrapposizione di onde e teorema di Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 O1.4 Energia dell’onda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 O1.5 Sovrapposizione di onde e onde stazionarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 O1.6 Sovrapposizione di onde ad angolo retto 573 O2 Acustica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 O2.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 O2.2 La nozione di onde sonore sferiche e piane 575 O2.3 Le grandezze che caratterizzano le onde piane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 O2.3.1 La velocità del suono . . . . . . . . . . . . . 576 O2.3.2 La pressione sonora . . . . . . . . . . . . . . 577 O2.3.3 L’impedenza acustica . . . . . . . . . . . . . 578 O2.3.4 La fisica del suono . . . . . . . . . . . . . . . 580 O2.3.5 L’intensità sonora . . . . . . . . . . . . . . . . 583 O2.4 Onde molto speciali: le onde sinusoidali 584 O2.4.1 Il concetto di spettro di frequenza . . . 584 O2.4.2 Il principio di sovrapposizione . . . . . . 586 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 O2.5 Passaggio di onde sonore da un mezzo ad un altro: riflessione e rifrazione di onde piane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 O2.6 Elementi acustici e loro caratterizzazione 592 O2.6.1 Elementi acustici concentrati . . . . . . . 592 O2.6.2 Elementi acustici distribuiti: interferenza e risonanze . . . . . . . . . . . 596 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 O2.7 L’effetto Doppler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 O2.8 L’attenuazione del suono . . . . . . . . . . . . 605 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 O3 Ottica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 O3.0 Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 O3.0.1 Ottica geometrica e ottica fisica . . . . . 609 O3 Ottica geometrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 O3.1 Riflessione e rifrazione . . . . . . . . . . . . . . 610 O3.1.1 Il cammino ottico . . . . . . . . . . . . . . . . 612 O3.2 Superfici piane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 O3.2.1 Angolo limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 O3.2.2 Immagine virtuale. . . . . . . . . . . . . . . . 613 O3.2.3 Rifrazione in un prisma . . . . . . . . . . . 616 O3.3 Rifrazione attraverso superfici sferiche 618 O3.3.1 Il concetto di fuoco ottico. . . . . . . . . . 618 O3.3.2 Immagini reali e virtuali . . . . . . . . . . . 619 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 O3.4 Lenti sottili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 O3.4.1 Le immagini nelle lenti sottili . . . . . . . 627 O3.4.2 Proprietà delle lenti sottili. . . . . . . . . . 628 O3.4.3 Lenti composte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 O3.5 Difetti delle lenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 O3.5.1 Aberrazione sferica . . . . . . . . . . . . . . . 634 O3.5.2 Coma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 O3.5.3 Astigmatismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 O3.5.4 Curvatura di campo . . . . . . . . . . . . . . 636 O3.5.5 Aberrazione cromatica . . . . . . . . . . . . 636 O4 Ottica fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 O4.1 Le onde elettromagnetiche. . . . . . . . . . . 637 O4.2 Interferenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 O4.2.1 Interferenza da riflessione multipla e anelli di Newton. . . . . . . . . . . . . . . . 645 O4.3 La diffrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 O4.3.1 Il potere risolutivo. . . . . . . . . . . . . . . . 652 O4.3.2 Potere risolutivo cromatico . . . . . . . . . 653 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 O4.4 Polarizzazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 O4.4.1 Polarizzazione rettilinea . . . . . . . . . . . 658 O4.4.2 Polarizzazione ellittica e circolare. . . . 662 O4.4.3 Polarizzazione rotatoria . . . . . . . . . . . 664 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 O4.5 La dispersione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 O4.5.1 La dispersione normale . . . . . . . . . . . 666 O4.5.2 La dispersione anomala . . . . . . . . . . . 668 O4.6 Assorbimento e diffusione della luce . . . 668 O5 Ottica: Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 Esercizi e problemi sulle Onde . . . . . . . . . . 736 Soluzioni ai problemi sulle Onde . . . . . . . . 741 F Fisica atomica e delle radiazioni 747 FAR1 Fisica atomica e delle radiazioni . . . . . . . . . 747 FAR1.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 FAR1.2 Gli spettri di emissione e di assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche . . . . . 748 FAR1.3 Gli spettri a righe e le loro implicazioni 753 FAR1.3.1 Le righe dell’atomo di idrogeno . . . 754 FAR1.4 Il modello di Bohr . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 FAR1.5 I livelli energetici dell’idrogeno . . . . . . . 757 FAR1.6 Che cosa resta oggi del modello di Bohr 758 FAR1.6.1 Il principio di Pauli, la struttura atomica e la tavola di Mendeleev . . . 760 FAR1.6.2 Una eredità del modello di Bohr: l’ordine di grandezza delle energie degli elettroni negli atomi e delle dimensioni delle loro nuvole. . 762 FAR1.6.3 Strutture molecolari e rappresentazioni semplificate della distribuzione degli elettroni attorno agli atomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 FAR1.7 Il dualismo onda-corpuscolo . . . . . . . . . 768 FAR1.7.1 Osservare vuol dire perturbare . . . . 770 FAR1.7.2 I principi di indeterminazione . . . . 771 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 FAR1.8 Le interazioni dei fotoni con la materia: eccitazione ed ionizzazione . . . . . . . . . . 774 FAR1.8.1 Gas monoatomici . . . . . . . . . . . . . . 774 FAR1.8.2 Gas molecolari. . . . . . . . . . . . . . . . . 775 FAR1.8.3 Solidi e liquidi . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 FAR1.9 Altre interazioni dei fotoni con la materia 777 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 FAR2 Fisica delle radiazioni di alta energia. Cenni di fisica nucleare e di radioprotezionistica. . . 779 FAR2.1 Il concetto di sezione d’urto . . . . . . . . . . 779 FAR2.2 Il concetto di lunghezza di attenuazione e di lunghezza di dimezzamento . . . . . . 780 FAR2.3 Le interazioni con la materia dei fotoni di alta energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 FAR2.3.1 Approfondimento: le interazioni dei fotoni con la materia: l’effetto Compton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 FAR2.3.2 Approfondimento: le interazioni dei fotoni con la materia: l’effetto fotoelettrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 FAR2.3.3 Approfondimento: le interazioni dei fotoni con la materia: la produzione di coppie e la produzione di neutroni 786 FAR2.4 Le interazioni degli elettroni con la materia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 FAR2.4.1 Il fenomeno della ionizzazione . . . . 787 FAR2.4.2 Il fenomeno della bremstrahlung. . . 790 FAR2.5 Strumentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 FAR2.5.1 I tubi a raggi X . . . . . . . . . . . . . . . . 791 FAR2.5.2 I fotomoltiplicatori. . . . . . . . . . . . . . 792 FAR2.5.3 Rivelazione di raggi _ con un contatore a scintillazione a NaI(Tl) . . . . . . . . . 793 FAR2.5.4 La produzione di fasci di elettroni e di fasci di _ con gli acceleratori lineari 796 FAR2.6 Cenni di fisica nucleare . . . . . . . . . . . . . 797 FAR2.6.1 La struttura dei nuclei, la valle di stabilità nucleare e i decadimenti _ e _ 797 FAR2.6.2 Nuclei radioattivi artificiali . . . . . . . 800 FAR2.6.3 Il becquerel e la vita media dei nuclei radioattivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 FAR2.6.4 Radiazioni e organismi biologici. . . 803 FAR2.6.5 Qualche nozione di radioprotezione 804 FAR2.6.6 Cenno alle unità di misura pertinenti e alle norme di protezionistica contro le radiazioni ionizzanti . . . . . . . . . . 805 Applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 Esercizi di Fisica Quantistica . . . . . . . . . . . 820 Soluzioni agli esercizi di Fisica Quantistica 822 A Appendici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 A Prefissi del Sistema Internazionale di Misura (S.I.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 B Unità geometriche, meccaniche e termiche nei sistemi S.I. e C.G.S.. . . . . . . . . . . . . . . . 826 C Unità di misura elettromagnetiche e ottiche 829 D Alcune costanti fisiche. . . . . . . . . . . . . . . . . 831 E Tavola di Mendeleev . . . . |
Questo libro è anche in:
