Elementi di fisiologia vegetale [Taiz ; Zeiger - Piccin Editore]
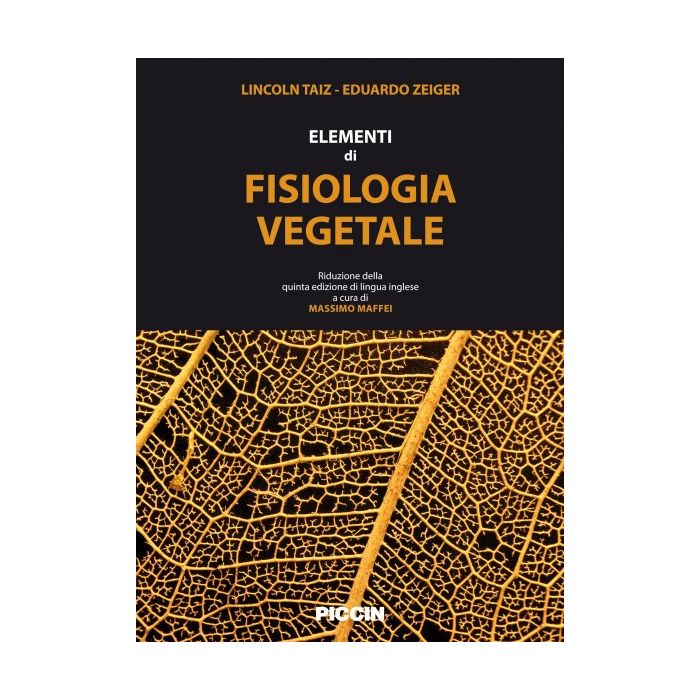
- ISBN/EAN
- 9788829923229
- Editore
- Piccin Editore
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2013
- Pagine
- 440
Disponibile
Cari colleghi e studenti della fisiologia vegetale, la continua richiesta da parte di studenti e colleghi di un testo più consono ai programmi del triennio di numerosi corsi di laurea in cui la fisiologia vegetale è materia caratterizzante o affine, ha spinto l’Editore Piccin a promuovere una versione ridotta della traduzione della quinta edizione del libro di testo
Plant Physiology (quarta edizione italiana).
Il compito non era facile poiché richiedeva la necessità di condensare in un numero contenuto di pagine la maggior parte degli argomenti necessari allo studente per acquisire gli elementi di base della Fisiologia Vegetale.
Pertanto, avendo accettato l’incarico, mi sono preso la responsabilità di escludere dalla versione integrale gli argomenti già trattati in corsi propedeutici alla Fisiologia Vegetale (quali ad esempio, le cellule vegetali, le pareti cellulari, l’accrescimento e lo sviluppo e il controllo della fioritura, trattati nei corsi di botanica; l’organizzazione del genoma
e l’espressione genica, oggetto di corsi di biologia molecolare, e la respirazione e il metabolismo lipidico
trattati nei corsi di biochimica), oppure oggetto di corsi di livello superiore (come l’ecofisiologia della fotosintesi, la trasduzione del segnale e lo stress abiotico).
Maggiori Informazioni
| Autore | Taiz Lincoln; Zeiger Eduardo |
|---|---|
| Editore | Piccin Editore |
| Anno | 2013 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | L’acqua nella vita della pianta 1 La struttura e le proprietà dell’acqua 2 L’acqua è una molecola polare che forma legami idrogeno 2 La polarità dell’acqua la rende un solvente eccellente 3 L’acqua ha distintive proprietà termiche relativamente alle sue dimensioni 3 Le molecole d’acqua sono molto coesive 4 L’acqua possiede una grande forza di tensione 4 Diffusione e osmosi 6 La diffusione è il movimento netto di molecole tramite agitazione termica casuale 6 La diffusione è più efficace a breve distanza 7 L’osmosi descrive il movimento netto dell’acqua attraverso una barriera permeabile 8 Il potenziale idrico 8 Il potenziale chimico dell’acqua è l’espressione dello stato di energia libera dell’acqua 8 Tre fattori principali contribuiscono al potenziale idrico della cellula 9 Il potenziale idrico può essere misurato 10 L’acqua e l CAPITOLO 1 e cellule vegetali 1 Potenziale idrico delle cellule vegetali 10 L’acqua entra nella cellula secondo un gradiente di potenziale idrico 10 L’acqua esce anche dalla cellula in risposta ad un gradiente di potenziale idrico 12 Il potenziale idrico e le sue componenti variano con le condizioni di crescita e la posizione all’interno della pianta 13 Proprietà della parete cellulare e della membrana 13 Piccoli cambiamenti nel volume cellulare causano grandi variazioni nella pressione di turgore 13 La velocità con cui le cellule guadagnano o perdono acqua è influenzata dalla conduttività idraulica della membrana cellulare 14 Le acquaporine facilitano lo spostamento dell’acqua attraverso le membrane cellulari 15 Lo stato idrico della pianta 16 I processi fisiologici sono influenzati dallo stato idrico della pianta 16 L’accumulo di soluti aiuta a mantenere il turgore e il volume delle cellule 17 Bibliografia 17 CAPITOLO 2 Bilancio idrico delle piante 19 L’acqua nel suolo 19 La pressione idrostatica negativa dell’acqua abbassa il potenziale idrico del suolo 20 L’acqua si muove attraverso il suolo mediante flusso di massa 21 Assorbimento dell’acqua dalle radici 22 L’acqua si sposta nella radice tramite l’apoplasto, il simplasto e la via transmembrana 23 L’accumulo di soluti nello xilema può generare una “pressione radicale” 24 prime pagine.indd 9 07/05/13 17:49 X INDICE GENERALE Trasporto dell’acqua attraverso lo xilema 24 Lo xilema è formato da due tipi di elementi tracheali 25 L’acqua si muove attraverso lo xilema per flusso dovuto a pressione 27 Il movimento dell’acqua attraverso lo xilema richiede un minore gradiente di pressione rispetto a quello attraverso le cellule vive 28 Quale differenza di pressione è richiesta per sollevare l’acqua in punta ad un albero alto 100 metri? 28 La teoria coesione-tensione spiega come avviene il trasporto dell’acqua nello xilema 28 Negli alberi il trasporto xilematico dell’acqua affronta sfide di tipo fisico 30 Le piante riducono le conseguenze della cavitazione xilematica 31 Movimento dell’acqua dalla foglia all’atmosfera 32 Le foglie hanno una grande resistenza idraulica 33 La forza motrice per la traspirazione è la differenza nella concentrazione del vapor acqueo 33 La perdita d’acqua è anche regolata dalle vie di resistenza 34 Il controllo degli stomi accoppia la traspirazione alla fotosintesi fogliare 35 Le pareti cellulari delle cellule di guardia sono specializzate 35 Un aumento della pressione di turgore nelle cellule di guardia causa l’apertura degli stomi 37 Il rapporto di traspirazione è la misura della relazione fra la perdita d’acqua e il guadagno in carbonio 38 Panoramica generale: il continuum suolo-pianta-atmosfera 39 Bibliografia 39 La nutrizione minerale 43 CAPITOLO 3 Nutrienti essenziali, carenze e disturbi nelle piante 44 Negli studi sulla nutrizione si utilizzano tecniche particolari 46 Le soluzioni nutritive possono sostenere la rapida crescita delle piante 48 Le carenze minerali danneggiano il metabolismo e il funzionamento delle piante 50 L’analisi dei tessuti vegetali rivela le carenze minerali 50 Il trattamento delle carenze nutrizionali 51 La resa delle coltivazioni può essere aumentata con l’aggiunta di fertilizzanti 52 Alcuni elementi minerali possono essere assorbiti dalle foglie 53 Suolo, radici e microbi 53 Le particelle del suolo cariche negativamente influiscono sull’assorbimento dei nutrienti minerali 54 Il pH del suolo ha effetto sulla disponibilità degli elementi nutritivi, sui microbi del terreno e sulla crescita delle radici 55 Una quantità eccessiva di minerali nel suolo limita la crescita delle piante 55 Le piante sviluppano un esteso sistema radicale 56 I sistemi radicali sono diversi nella forma, ma si basano su strutture comuni 56 Zone diverse della radice assorbono differenti ioni minerali 58 La disponibilità di nutrienti influisce sull’accrescimento delle radici 60 I funghi micorrizici facilitano l’assorbimento dei nutrienti nelle radici 60 I nutrienti si spostano dai funghi micorrizici alle cellule radicali 62 Bibliografia 62 prime pagine.indd 10 07/05/13 17:49 INDICE GENERALE XI Trasporto passivo e trasporto attivo 66 Trasporto di soluti attraverso barriere membranose 68 Differenti velocità di diffusione di cationi e anioni producono potenziali di diffusione 68 Qual è la relazione fra il potenziale di membrana e la distribuzione di ioni? 69 L’equazione di Nernst distingue il trasporto passivo da quello attivo 70 Il principale responsabile del potenziale di membrana è il trasporto dei protoni 71 Processi di trasporto di membrana 72 I canali aumentano la diffusione attraverso le membrane 74 I carriers legano e trasportano sostanze specifiche 75 Il trasporto attivo primario richiede energia 75 Il trasporto attivo secondario utilizza l’energia immagazzinata 77 Analisi cinetiche possono spiegare i meccanismi di trasporto 78 Proteine di trasporto di membrana 79 Sono stati identificati i geni di numerosi trasportatori 80 Esistono trasportatori per diversi composti contenenti azoto 82 Esistono vari trasportatori di cationi 83 Sono stati identificati alcuni trasportatori di anioni 85 I trasportatori di metalli spostano micronutrienti essenziali 85 Le acquaporine hanno molte funzioni 86 Le H+-ATPasi della membrana plasmatica funzionali sono delle ATPasi di tipo P altamente regolate 86 La H+-ATPasi del tonoplasto guida l’accumulo di soluti nel vacuolo 88 Anche le H+-pirofosfatasi pompano protoni nel tonoplasto 89 Trasporto di ioni nelle radici 90 Il movimento di soluti avviene tramite l’apoplasto e il simplasto 90 Gli ioni attraversano sia il simplasto che l’apoplasto 91 Le cellule parenchimatiche dello xilema partecipano al caricamento dello xilema 92 Bibliografia 93 Trasporto dei soluti 65 CAPITOLO 4 Fotosintesi: le reazioni alla luce 97 CAPITOLO 5 La fotosintesi nelle piante superiori 98 Concetti generali 98 La luce possiede caratteristiche sia di particella che di onda 98 Quando le molecole assorbono o emettono luce, cambiano il loro stato elettronico 99 I pigmenti fotosintetici assorbono la luce che dà energia alla fotosintesi 101 Esperimenti fondamentali per comprendere la fotosintesi 102 Gli spettri d’azione mettono in relazione l’assorbimento della luce con l’attività fotosintetica 103 La fotosintesi avviene in complessi contenenti antenne che raccolgono la luce e in centri di reazione fotochimici 103 La reazione chimica della fotosintesi è condotta dalla luce 105 La luce permette la riduzione del NADP e la formazione di ATP 106 Gli organismi che evolvono ossigeno possiedono due fotosistemi che lavorano in serie 106 Organizzazione dell’apparato fotosintetico 107 Il cloroplasto è la sede della fotosintesi 107 prime pagine.indd 11 07/05/13 17:49 XII INDICE GENERALE I tilacoidi contengono proteine integrali di membrana 108 I fotosistemi I e II sono distintamente separati all’interno della membrana tilacoidale 109 I batteri fotosintetici anossigenici hanno un solo centro di reazione 110 Organizzazione dei sistemi antenna per l’assorbimento della luce 110 I sistemi antenna contengono clorofilla e sono associati alla membrana 110 Il sistema antenna convoglia l’energia verso i centri di reazione 112 Numerosi complessi antenna pigmento-proteina possiedono un motivo strutturale comune 113 Meccanismi di trasporto di elettroni 114 Gli elettroni ceduti dalla clorofilla si spostano tramite carriers organizzati in uno “Schema a Z” 114 L’accumulo di energia avviene quando una molecola eccitata di clorofilla riduce una molecola che accetta elettroni 116 Le clorofille dei centri di reazione dei due fotosistemi assorbono a lunghezze d’onda differenti 117 Il centro di reazione del fotosistema II è un complesso pigmento-proteina formato da molte subunità 117 L’acqua è ossidata ad ossigeno dal fotosistema II 117 La feofitina e due chinoni accettano elettroni dal fotosistema II 119 Anche il flusso di elettroni attraverso il complesso citocromo b6 f trasporta protoni 120 Il plastochinone e la plastocianina trasportano elettroni fra i fotosistemi II e I 122 Il centro di reazione del fotosistema I riduce il NADP+ 122 Il flusso ciclico di elettroni genera ATP ma non NADPH 122 Alcuni erbicidi bloccano il flusso fotosintetico degli elettroni 123 Trasporto di protoni e sintesi di ATP nel cloroplasto 123 Bibliografia 127 Fotosintesi: le reazioni del carbonio 131 CAPITOLO 6 Il ciclo di Calvin-Benson 132 Il ciclo di Calvin-Benson è composto da tre fasi: carbossilazione, riduzione e rigenerazione 133 La carbossilazione del ribulosio 1,5-bisfosfato fissa la CO2 per la sintesi dei trioso fosfati 133 Il ribulosio 1,5-bisfosfato viene rigenerato per garantire l’assimilazione continua di CO2 134 Un periodo di induzione precede lo stato stazionario di assimilazione fotosintetica della CO2 137 Regolazione del ciclo di Calvin-Benson 137 L’attività della rubisco aumenta alla luce 138 La luce regola il ciclo di Calvin-Benson attraverso il sistema ferredossina-tioredossina 139 I movimenti di ioni dipendenti dalla luce modulano gli enzimi del ciclo di Calvin-Benson 140 La luce controlla l’assemblaggio degli enzimi cloroplastici in complessi sopramolecolari 141 Il ciclo C2 per l’ossidazione fotosintetica del carbonio 141 La carbossilazione e l’ossigenazione del ribulosio 1,5-bisfosfato sono reazioni in competizione 143 La fotorespirazione dipende dal sistema di trasporto degli elettroni fotosintetici 146 La fotorespirazione protegge l’apparato fotosintetico in condizioni di stress 147 La fotorespirazione può essere ingegnerizzata per aumentare la produzione di biomassa 148 Meccanismi di concentrazione del carbonio inorganico 150 Meccanismi di concentrazione del carbonio inorganico: il ciclo C4 del carbonio 150 Malato e aspartato sono prodotti di carbossilazione del ciclo C4 150 Due diversi tipi di cellule partecipano al ciclo C4 151 prime pagine.indd 12 07/05/13 17:49 INDICE GENERALE XIII Il ciclo C4 concentra la CO2 nei cloroplasti delle cellule della guaina del fascio 154 Il ciclo C4 concentra anche la CO2 in cellule singole 155 La luce regola l’attività di enzimi chiave C4 155 In climi caldi e asciutti, il ciclo C4 riduce la fotorespirazione e la perdita di acqua 155 Meccanismi di concentrazione del carbonio inorganico: metabolismo acido delle crassulacee (CAM) 156 CAM è un meccanismo versatile sensibile agli stimoli ambientali 157 Bibliografia 158 Traslocazione nel floema 163 CAPITOLO 7 Vie di traslocazione 164 Lo zucchero è traslocato dagli elementi del cribro del floema 165 Gli elementi maturi del cribro sono cellule vive specializzate per la traslocazione 165 La caratteristica peculiare degli elementi del cribro è la presenza di grandi pori nelle pareti cellulari 166 Gli elementi del cribro danneggiati sono sigillati 167 Le cellule compagne aiutano gli elementi del cribro altamente specializzati 168 Modelli di traslocazione: dalle sorgenti ai pozzi 170 Sostanze traslocate nel floema 171 Il succo floematico può essere prelevato e analizzato 171 Gli zuccheri sono traslocati in forma non riducente 172 Nel floema sono traslocati anche altri soluti 172 Velocità di spostamento 173 Il modello del flusso da pressione, un meccanismo passivo per il trasporto del floema 174 Un gradiente di pressione generato osmoticamente permette la traslocazione nel modello del flusso da pressione 174 Le previsioni sul modello del flusso da pressione sono state confermate 175 I pori della placca cribrosa sono dei canali aperti 176 In un singolo elemento del cribro non esiste trasporto bidirezionale 177 L’energia richiesta per il trasporto attraverso la via floematica è piccola 178 I gradienti di pressione sono sufficienti per permettere il flusso di massa del succo floematico 178 La traslocazione nelle gimnosperme implica un altro meccanismo? 179 Caricamento del floema 179 Il caricamento del floema avviene attraverso l’apoplasto o il simplasto 180 Molti dati avvalorano l’esistenza in alcune specie di un caricamento apoplastico 180 Il caricamento del floema nella via apoplastica richiede energia metabolica 181 Il caricamento del floema nella via apoplastica coinvolge un simportatore saccarosio-H+ 181 Scaricamento del floema e transizione da pozzo a sorgente 182 Lo scaricamento del floema ed il trasporto a breve distanza possono essere simplastici o apoplastici 182 Il trasporto nei tessuti pozzo richiede energia metabolica 184 La transizione di una foglia da pozzo a sorgente è un processo graduale 184 Distribuzione dei fotosintati: allocazione e ripartizione 186 L’allocazione comprende l’accumulo, l’utilizzo e il trasporto 187 Gli zuccheri di trasporto sono ripartiti fra vari pozzi 187 Le foglie sorgente regolano l’allocazione 188 I tessuti pozzo competono per la disponibilità dei fotosintati traslocati 188 prime pagine.indd 13 07/05/13 17:49 XIV INDICE GENERALE La forza di pozzo dipende dalla dimensione e dall’attività del pozzo 189 La sorgente si regola su lunghi tempi in funzione dei cambiamenti nel rapporto sorgente/pozzo 189 Bibliografia 190 Assimilazione dei nutrienti minerali 193 CAPITOLO 8 Azoto nell’ambiente 194 L’azoto passa attraverso diverse forme in un ciclo biogeochimico 194 Ammonio e nitrati non assimilati possono essere pericolosi 195 Assimilazione del nitrato 196 Numerosi fattori regolano la nitrato reduttasi 197 La nitrito reduttasi converte il nitrito in ammonio 198 Sia le radici che i germogli assimilano nitrato 198 Assimilazione dell’ammonio 199 La conversione dell’ammonio in amminoacidi richiede due enzimi 199 L’ammonio può essere assimilato tramite una via alternativa 201 Le reazioni di transamminazione trasferiscono azoto 201 L’asparagina e la glutammina uniscono i metabolismi del carbonio e dell’azoto 201 La biosintesi degli amminoacidi 201 Fissazione biologica dell’azoto 202 Batteri liberi e simbionti fissano l’azoto 202 La fissazione dell’azoto richiede condizioni anaerobiche 203 La fissazione simbiontica dell’azoto avviene in strutture specializzate 204 Lo stabilirsi della simbiosi richiede uno scambio di segnali 205 I fattori Nod prodotti dai batteri agiscono da segnale per la simbiosi 206 La formazione del nodulo coinvolge i fitoormoni 207 Il complesso enzimatico della nitrogenasi fissa N2 207 Le molecole azotate trasportate sono le ammidi e le ureidi 210 Assimilazione dello zolfo 210 Il solfato è la forma di zolfo assorbita dalle piante 210 L’assimilazione del solfato richiede la sua riduzione a cisteina 211 L’assimilazione del solfato avviene principalmente nelle foglie 212 La metionina è sintetizzata dalla cisteina 212 Assimilazione del fosfato 212 Assimilazione dei cationi 213 I cationi formano con i composti carboniosi legami non covalenti 213 Le radici modificano la rizosfera per acquisire ferro 213 Il ferro forma complessi con il carbonio e il fosfato 215 Assimilazione dell’ossigeno 216 Energetica dell’assimilazione dei nutrienti 217 Bibliografia 217 Metaboliti secondari e difese delle piante 221 CAPITOLO 9 Metaboliti secondari 222 I metaboliti secondari difendono la pianta dagli attacchi degli erbivori e dei patogeni 222 I metaboliti secondari sono suddivisi in tre gruppi principali 222 Terpeni 222 prime pagine.indd 14 07/05/13 17:49 INDICE GENERALE XV I terpeni si formano dalla fusione di unità isopreniche a cinque atomi di carbonio 222 Esistono due vie metaboliche per la biosintesi di terpeni 223 L’isopentenil difosfato ed il suo isomero si uniscono a formare terpeni più grandi 225 Alcuni terpeni hanno ruoli nella crescita e nello sviluppo 225 In molte piante i terpeni sono difese contro gli erbivori 225 Composti fenolici 227 La fenilalanina è un intermedio nella biosintesi della maggior parte dei fenoli vegetali 227 Alcuni fenoli semplici sono attivati dalla luce nell’ultravioletto 229 I fenoli semplici che vengono dispersi nel suolo possono limitare la crescita di altre piante 230 La lignina è una complessa macromolecola fenolica 230 Esistono quattro gruppi principali di flavonoidi 231 Le antocianine sono flavonoidi colorati che attraggono gli animali 231 I flavonoidi possono proteggere dal danno dovuto alle radiazioni UV 232 Gli isoflavonoidi hanno una vasta attività farmacologica 233 I tannini sono composti deterrenti contro gli erbivori 233 Composti contenenti azoto 235 Gli alcaloidi esercitano un drastico effetto fisiologico sugli animali 235 I glicosidi cianogeni liberano il velenoso acido cianidrico 238 I glucosinolati rilasciano tossine volatili 239 Gli amminoacidi non proteici sono tossici per gli erbivori 240 Bibliografia 241 Proprietà fotochimiche e biochimiche del fitocromo 244 Le due forme di fitocromo Pr e Pfr sono interconvertibili 246 La forma fisiologicamente attiva del fitocromo è il Pfr 247 Caratteristiche delle risposte indotte dal fitocromo 247 Le risposte del fitocromo variano nel tempo di latenza e nel tempo di fuga 247 Gli effetti del fitocromo sulle piante possono essere distinti dalla quantità di luce richiesta 248 Le risposte a fluenza bassissima non sono fotoreversibili 248 Le risposte alla bassa fluenza sono fotoreversibili 248 Le risposte ad alta irradiazione sono proporzionali alla irradiazione e alla durata 249 Struttura e funzione delle proteine del fitocromo 250 Ritmi circadiani 251 Funzioni ecologiche 252 Il fitocromo permette alla pianta di adattarsi ai cambiamenti nella qualità della luce 252 La diminuzione del rapporto R/FR causa l’allungamento delle piante da sole 252 Per germinare i semi piccoli spesso hanno bisogno di un alto rapporto R/FR 255 La riduzione della risposta di evitazione dell’ombra può aumentare la resa delle coltivazioni 255 Le risposte del fitocromo mostrano variazioni ectopiche 255 L’azione del fitocromo può essere modulata 256 Risposte alla luce blu: morfogenesi e movimento degli stomi 256 Fotofisiologia delle risposte alla luce blu 258 La luce blu stimola la crescita asimmetrica ed il ripiegamento 258 Risposte alla luce rossa e alla luce blu: fitocromo e citocromo 243 CAPITOLO 10 prime pagine.indd 15 07/05/13 17:49 XVI INDICE GENERALE La luce blu inibisce rapidamente l’allungamento del fusto 259 La luce blu stimola l’apertura degli stomi 260 La luce blu attiva una pompa protonica nella membrana plasmatica delle cellule di guardia 262 Le risposte alla luce blu hanno cinetiche e tempi di latenza caratteristici 263 La luce blu regola le relazioni osmotiche delle cellule di guardia 264 Nelle cellule di guardia il saccarosio è un soluto osmoticamente attivo 266 Regolazione delle risposte stimolate dalla luce blu 267 I fotorecettori della luce blu 268 I criptocromi regolano lo sviluppo vegetale 268 Le fototropine mediano il fototropismo dipendente dalla luce blu e i movimenti dei cloroplasti 269 La zeaxantina media la fotorecezione della luce blu nelle cellule di guardia 271 La luce verde inverte l’apertura stimolata dalla luce blu 273 Bibliografia 276 Auxina: il primo ormone vegetale della crescita ad essere stato scoperto 281 CAPITOLO 11 Nascita del concetto di auxina 282 L’auxina principale: l’acido indol-3-acetico 282 L’IAA è sintetizzato in meristemi e in giovani tessuti in divisione 285 Esistono molte vie per la biosintesi dell’IAA 286 I semi e gli organi di riserva contengono auxina legata covalentemente 286 L’IAA è degradato da vie multiple 286 Trasporto dell’auxina 287 Il trasporto polare richiede energia e non dipende dalla gravità 289 Il potenziale chemiosmotico causa il trasporto polare 289 Azioni dell’auxina: allungamento cellulare 291 Le auxine promuovono la crescita di fusti e coleottili, ma inibiscono quella delle radici 291 I tessuti esterni dei fusti delle dicotiledoni sono i bersagli dell’azione dell’auxina 292 Il minimo tempo di latenza per l’allungamento indotto dall’auxina è di 10 minuti 292 L’auxina aumenta rapidamente l’estensibilità della parete cellulare 293 L’estrusione di protoni indotta dall’auxina aumenta l’estensione della cellula 294 L’estrusione di protoni indotta dall’auxina comporta l’attivazione e la mobilitazione delle proteine 295 Azioni dell’auxina: tropismi delle piante 295 Il fototropismo è mediato dalla redistribuzione laterale dell’auxina 295 Il gravitropismo implica la redistribuzione laterale dell’auxina 297 Densi plastidi fungono da sensori di gravità 298 La percezione della gravità può coinvolgere il pH e gli ioni calcio (Ca2+) come secondi messaggeri 300 Nella cuffia l’auxina è ridistribuita lateralmente 301 Effetti dell’auxina sullo sviluppo 304 L’auxina regola la dominanza apicale 304 Il trasporto di auxina regola lo sviluppo della gemma fiorale e la fillotassi 305 L’auxina promuove la formazione di radici laterali e avventizie 306 L’auxina induce il differenziamento vascolare 307 L’auxina ritarda l’avvento dell’abscissione fogliare 308 L’auxina promuove lo sviluppo dei frutti 308 Le auxine sintetiche hanno svariate applicazioni commerciali 308 Bibliografia 309 prime pagine.indd 16 07/05/13 17:49 INDICE GENERALE XVII La scoperta delle gibberelline e la struttura chimica 312 Le gibberelline sono state scoperte studiando una malattia del riso 312 L’acido gibberellico è stato purificato per la prima volta da filtrati di colture di Gibberella 312 Tutte le gibberelline sono basate sullo scheletro ent-gibberellanico 313 Effetti delle gibberelline sull’accrescimento e sullo sviluppo 314 Le gibberelline promuovono la germinazione dei semi 314 Le gibberelline possono stimolare l’accrescimento della radice e del fusto 314 Le gibberelline regolano la transizione dalla fase giovanile a quella adulta 315 Le gibberelline hanno un effetto sulla formazione dei fiori e sulla determinazione del sesso 315 Le gibberelline promuovono lo sviluppo del polline e l’accrescimento del tubetto pollinico 315 Le gibberelline promuovono la fruttificazione e la partenocarpia 315 Le gibberelline promuovono lo sviluppo precoce del seme 316 Usi commerciali delle gibberelline e degli inibitori della loro biosintesi 316 Risposte alle gibberelline: lo strato di aleurone dei cereali 317 La GA è sintetizzata nell’embrione 317 Le cellule dell’aleurone possono avere due tipi di recettore della GA 318 Le gibberelline aumentano la trascrizione dell’mRNA dell’a-amilasi 319 GAMYB è un regolatore positivo della trascrizione dell’a-amilasi 319 Le proteine di dominio DELLA sono rapidamente degradate 320 Risposte alle gibberelline: accrescimento del fusto 320 Le gibberelline stimolano l’allungamento e la divisione cellulare 320 Le GA regolano la trascrizione delle chinasi del ciclo cellulare 322 Ridurre la sensibilità alla GA può impedire le perdite dei raccolti 323 Bibliografia 324 Gibberelline: regolatori dell’altezza delle piante e della germinazione dei semi 311 CAPITOLO 12 Citochinine: regolatori della divisione cellulare 327 CAPITOLO 13 Divisione cellulare e sviluppo della pianta 328 Le cellule vegetali differenziate possono ricominciare a dividersi 328 I fattori diffusibili possono controllare la divisione cellulare 328 Si possono coltivare tessuti e organi vegetali 328 Scoperta, identificazione e proprietà delle citochinine 329 La chinetina è stata scoperta come un prodotto di degradazione del DNA 329 La zeatina è stata la prima citochinina naturale ad essere scoperta 330 Alcuni composti sintetici possono imitare o agire da antagonisti dell’azione della citochinina 330 Le citochinine sono presenti nelle forme libere e legate 331 Alcuni batteri patogeni, funghi, insetti e nematodi secernono citochinine libere 331 Biosintesi, metabolismo e trasporto delle citochinine 332 Le cellule del tumore del colletto hanno acquisito un gene per la sintesi delle citochinine 332 I ruoli biologici delle citochinine 335 prime pagine.indd 17 07/05/13 17:49 XVIII INDICE GENERALE Le citochinine promuovono la crescita del fusto aumentando la proliferazione cellulare nel meristema apicale del germoglio 335 Le citochinine interagiscono con altri ormoni e con diversi fattori di trascrizione chiave 335 Le citochinine inibiscono la crescita della radice promuovendo l’uscita di cellule dal meristema apicale della radice 337 Le citochinine regolano componenti specifiche del ciclo cellulare 338 Il rapporto auxina:citochinina regola la morfogenesi in tessuti in coltura 339 Le citochinine modificano la dominanza apicale e promuovono la crescita delle gemme laterali 340 Le citochinine ritardano la senescenza fogliare 341 Le citochinine promuovono il movimento dei nutrienti 342 Le citochinine influenzano il segnale luminoso tramite il fitocromo 343 Le citochinine regolano lo sviluppo vascolare 344 Manipolazione delle citochinine per alterare importanti caratteri agronomici 344 Le citochinine sono coinvolte nella formazione di noduli azoto-fissatori nei legumi 346 Bibliografia 346 Effetti fisiologici e di sviluppo dell’etilene 350 L’etilene promuove la maturazione di alcuni frutti 350 I frutti che rispondono all’etilene mostrano un climaterico 350 I recettori dei mutanti di pomodoro never-ripe sono incapaci di legarsi all’etilene 351 L’epinastia fogliare si verifica quando l’ACC è trasportata dalle radici all’apice del germoglio 352 L’etilene induce l’espansione cellulare laterale 352 Ci sono due fasi distinte per l’inibizione della crescita causata dall’etilene 354 La produzione di etilene mantiene la posizione a gancio nelle pianticelle cresciute al buio 355 In alcune specie l’etilene interrompe la dormienza dei semi e delle gemme 355 L’etilene promuove la crescita per distensione delle specie acquatiche sommerse 355 L’etilene induce la formazione di radici e peli radicali 355 L’etilene regola la fioritura e la determinazione del sesso in alcune specie 356 L’etilene accresce il tasso di senescenza fogliare 356 L’etilene media alcune risposte di difesa 357 L’etilene agisce sullo strato di abscissione 357 L’etilene possiede importanti applicazioni commerciali 359 Bibliografia 360 Etilene: l’ormone gassoso 349 CAPITOLO 14 Acido abscissico: l’ormone della maturazione del seme e di risposta allo stress 363 CAPITOLO 15 Presenza, natura chimica e misurazione dell’ABA 364 La struttura chimica dell’ABA ne determina l’attività fisiologica 364 L’ABA viene saggiato con metodi biologici, fisici e chimici 364 L’ABA è traslocato nei tessuti vascolari 364 prime pagine.indd 18 07/05/13 17:49 Effetti fisiologici e di sviluppo dell’ABA 365 L’ABA regola la maturazione dei semi 366 L’ABA inibisce la germinazione precoce e la viviparia 367 L’ABA promuove l’accumulo delle sostanze di riserva del seme e la tolleranza alla disidratazione 367 La dormienza del seme può essere regolata dall’ABA e da fattori ambientali 368 La dormienza del seme è regolata dal rapporto ABA/GA 368 L’ABA inibisce la produzione di enzimi indotta da GA 369 L’ABA promuove la crescita della radice e inibisce quella del germoglio a bassi potenziali idrici 370 L’ABA promuove la senescenza fogliare indipendentemente dall’etilene 371 L’ABA si accumula nelle gemme dormienti 371 L’ABA chiude gli stomi in risposta allo stress idrico 372 L’ABA regola i canali ionici e l’ATPasi della membrana plasmatica delle cellule di guardia 373 Bibliografia 375 Struttura, presenza e analisi genetiche dei brassinosteroidi 378 Brassinosteroidi: effetti sull’accrescimento e sullo sviluppo 380 I BR promuovono nel fusto sia l’espansione che la divisione cellulare 380 I BR promuovono e inibiscono la crescita della radice 382 I BR promuovono il differenziamento dello xilema durante lo sviluppo vascolare 383 I BR sono necessari per l’accrescimento del tubetto pollinico 383 I BR promuovono la germinazione dei semi 384 Prospettive sull’impiego dei brassinosteroidi in agricoltura 384 Bibliografia 385 Brassinosteroidi: regolatori dell’espansione e dello sviluppo cellulare 377 CAPITOLO 16 Appendice 1 – Vie biosintetiche degli ormoni 387 Indice analitico 402 prime |
| Disponibilità | Ultima Copia |
| Stato editoriale | Disponibilità limitata |
