Manuale di pratica della relazione nell'Assistenza Infermieristica. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente)
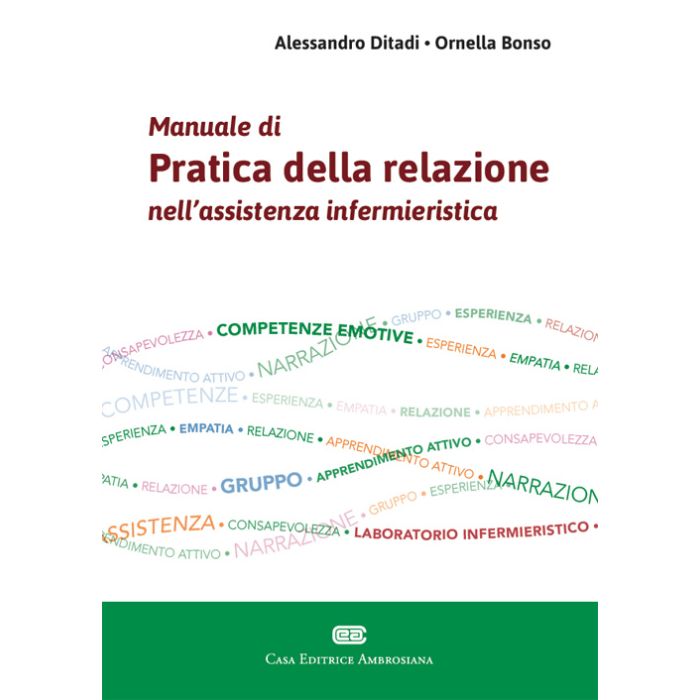
- ISBN/EAN
- 9788808184498
- Editore
- Ambrosiana / CEA
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2017
- Pagine
- 512
Disponibile
41,50 €
Questo manuale presenta un progetto volto a sviluppare abilità relazionali negli studenti che frequentano il Corso di Laurea in Infermieristica, avvalendosi della metodologia degli incontri di gruppo inseriti nell’ambito del Laboratorio Professionale.
La prima parte del manuale affronta la cornice del progetto: come si è strutturata dalle origini la relazione infermieristica, come si declina oggi l’assistenza infermieristica nell’epoca della tecnica, quali sono i caratteri originali della relazione che l’infermiere attua nei luoghi di assistenza.
La seconda parte si occupa di disegnare il pensiero e le fondamenta concettuali che reggono il progetto. Inizia dalle caratteristiche del tirocinio e continua con l’approfondimento dei prerequisiti necessari per instaurare una relazione. Infine, sono trattati alcuni elementi rilevanti quali: il gruppo, l’approccio riflessivo, la consapevolezza delle emozioni, il giudizio, il silenzio.
La terza parte, applicativa, è invece una “cassetta degli attrezzi” che presenta gli strumenti e i metodi di svolgimento degli incontri di gruppo. In questa parte, ogni capitolo, ciascuno dedicato a un anno di corso, si chiude con casi che evidenziano le problematiche emerse nella gestione del gruppo, con commenti e suggerimenti inerenti la conduzione.
L’ultimo capitolo illustra i risultati ottenuti utilizzando la metodologia descritta nel testo.
Un testo pratico, caratterizzato dalla presenza di quaranta casi reali, con oltre un centinaio di testimonianze di studenti e oltre 150 indicazioni di possibili percorsi relazionali per i tutor-conduttori e per gli studenti.
Specifici diagrammi di flusso sintetizzano il percorso utile ad apprendere abilità relazionali significative.
PREFAZIONE
Questo manuale nasce da un progetto volto a sviluppare abilità relazionali negli studenti frequentanti il Corso di laurea in infermieristica.
Il tirocinio nei luoghi di assistenza provoca negli studenti importanti impatti che si ripercuotono in problematiche di gestione dell’emotività, di stress, di calo dell’empatia, di orientamento verso se stessi con la conseguente riduzione di abilità relazionali.
Abbiamo preso coscienza che l’accompagnamento tutoriale è importante, ma non è sufficiente per rispondere adeguatamente all’incontro dello studente con la fragilità umana.
Come preparare il giovane studente in salute a rispondere ai bisogni della persona malata?
Contemporaneamente alla preparazione sul sapere e sulla tecnica, come favorire la consapevolezza di sé, l’accettazione dei propri limiti e quindi l’equilibrio emotivo necessario per assistere con competenza relazionale e umana?
Numerose esperienze tratte dalla letteratura suggeriscono come lo strumento degli incontri di gruppo possa favorire la conoscenza e la consapevolezza di sé e quindi lo sviluppo di abilità relazionali.
Carl Rogers sosteneva che un gruppo che si riunisce in maniera continuativa con un conduttore può creare un clima psicologico di sicurezza, in cui si realizza la libertà di espressione e la riduzione dell’atteggiamento difensivo. Si afferma così un senso di fiducia, di cordialità e di simpatia per gli altri membri del gruppo, che porta l’individuo a conoscere se stesso e ogni altro più a fondo di quanto non riesca a fare negli usuali rapporti sociali o di lavoro, rivelando ciò che è dietro la facciata.
In questo progetto di incontri di gruppo abbiamo individuato un filo conduttore che attraversa i tre anni del percorso; una metodologia per rendere operativa questa straordinaria risorsa costituita dal gruppo.
Nel primo anno, il filo conduttore riguarda i prerequisiti necessari per instaurare una relazione con la persona; gli incontri del secondo anno si focalizzano nell’affrontare situazioni relazionali complesse; nel terzo e ultimo anno gli studenti sono chiamati a individuare, proporre e gestire temi di pratica relazionale.
Riteniamo che l’esperienza di gruppo, contemporanea allo svolgersi del tirocinio, offra agli studenti alcune possibilità elencate di seguito.
• Palestra di ascolto non giudicante
La maggior parte del tempo dei singoli partecipanti è utilizzata nell’ascolto dei vissuti dei compagni in tirocinio. La modalità si sofferma sull’esperienza e su ciò che suscita, limitando l’espressione del giudizio.
• Accogliere la debolezza irreparabile
Gli infermieri, come tutti quelli che lavorano in ambito sanitario, vengono preparati per trovare la soluzione di problemi. Frustazione e impotenza vengono spesso causate da situazioni di malattia grave, da comportamenti del personale ospedaliero e da criticità organizzative.
Le narrazioni in gruppo facilitano l’accoglienza della fragilità dell’assistito e di quella di chi assiste.
• Ritrovare un’identità infermieristica oltre il sapere e la tecnica Il filo conduttore degli argomenti presentati, la narrazione e lo scambio di esperienze che avvengono in gruppo coagulano delle identità. Identità che assumono un senso se sono legate alla centralità dell’assistito e alla sua globalità come persona: cioè un’assistenza oltre l’organo, oltre la patologia, oltre la tecnica. Questo permette di tenere strettamente connesso l’infermiere all’infermo.
Il manuale è suddiviso in tre parti.
• Prima parte: l’infermiere e la relazione
Questa prima parte affronta la cornice del progetto e cioè come si è strutturata dalle origini la relazione infermieristica. Segue uno sguardo su come si declina oggi l’assistenza infermieristica nell’epoca della tecnica. Si è poi cercato di delineare i caratteri originali della relazione che l’infermiere attua nei luoghi di assistenza.
• Seconda parte: il percorso di apprendimento
Questa sezione si occupa di disegnare il pensiero e le fondamenta concettuali che reggono la parte pratica. Si inizia dal tirocinio, e si continua nell’approfondimento del pensiero di Carl Rogers e dei prerequisiti necessari per instaurare una relazione. Infine, si approfondiscono alcuni elementi importanti quali: il gruppo, l’approccio riflessivo, la consapevolezza delle emozioni, il giudizio, il silenzio.
• Terza parte: ambito operativo
Questa parte è costituita da strumenti e metodi di svolgimento degli incontri, che abbiamo chiamato la “cassetta degli attrezzi”. Anche in questa parte non mancano indicazioni per gli studenti e i conduttori. I capitoli 8 e 9 si chiudono con 5 casi che evidenziano le problematiche emerse nella gestione del gruppo, con commenti e suggerimenti inerenti la conduzione desunti dall’esperienza. L’ultimo capitolo illustra i risultati.
L’impronta pratica del testo è caratterizzata dalla presenza di quaranta casi reali, oltre un centinaio di testimonianze di studenti, oltre 150 indicazioni di possibili percorsi relazionali per i tutor-conduttori e per gli studenti. Il capitolo 6 è arricchito da alcuni diagrammi di flusso che cercano di sintetizzare operativamente i comportamenti relazionali più importanti.
La metodologia del laboratorio professionale di sviluppo di abilità relazionali sperimentata in questi dieci anni, di cui il testo è testimonianza fedele, ha evidenziato risultati che hanno avuto un impatto importante negli studenti e, vogliamo sperare, sull’assistenza.
• L’empatia cresce sensibilmente negli studenti che hanno frequentato i gruppi, mentre cala in coloro che non vi hanno partecipato.
• In chi ha frequentato il laboratorio professionale di tipo relazionale cresce la capacità di percepire, comprendere, identificare ed esprimere le emozioni, mentre al contrario tale capacità diminuisce in chi non l’ha frequentato.
• L’orientamento verso l’assistito cresce in misura maggiore in chi ha frequentato il gruppo.
• Lo stress tende a diminuire e così anche il rischio di burnout.
Possiamo affermare che tale approccio può consentire a sviluppare le abilità relazionali, migliorando l’equilibrio emotivo di chi cura e contrastando la disumanizzazione dell’assistenza attraverso un’attenzione maggiore alla persona malata. Auspichiamo una diffusione di tale metodologia sia nella formazione dei futuri infermieri sia, perché no, anche in quella degli attuali infermieri.
Appare sempre più necessario prendersi cura di chi cura.
Alessandro Ditadi
Ornella Bonso
Maggiori Informazioni
| Autore | Ditaldi Alessandro; Bonso Ornella |
|---|---|
| Editore | Ambrosiana / CEA |
| Anno | 2017 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Ringraziamenti XXV Introduzione XXVII Prefazione di Ivo Lizzola XXXI La cura: chinarsi sulla vita XXXI Parte prima La relazione nell’assistenza 1 Capitolo 1 Gli aspetti fondanti del praticare la relazione nell’assistenza infermieristica 3 A cura di Ornella Bonso 1.1 Storia dell’assistenza: i nodi 3 1.1.1 Il cristianesimo 4 1.1.2 Il personale religioso e l’ingresso dei laici 5 1.1.3 L’Età moderna 6 1.1.4 La prima formazione in Italia e il ruolo delle donne 8 1.2 La relazione con l’assistito 10 1.2.1 La relazione medico-persona assistita 10 1.2.2 L’autonomia e l’autodeterminazione dell’assistito 12 1.2.3 La relazione infermieristica 14 Capitolo 2 La relazione infermieristica oggi 17 A cura di Alessandro Ditadi 2.1 La pratica della relazione nei luoghi di assistenza: le insidie della tecnica e le fatiche della relazione 17 2.2 La formazione relazionale degli infermieri 30 2.3 I sette peccati capitali nella preparazione e nell’apprendimento di competenze relazionali dell’infermiere 31 2.4 Il caso e i percorsi relazionali possibili 36 Capitolo 3 Le caratteristiche originali della relazione infermieristica 41 A cura di Alessandro Ditadi 3.1 Esiste la relazione infermieristica? 41 3.1.1 Presupposti per la ricerca del ruolo relazionale dell’infermiere 46 3.2 Caratteristiche originali della relazione infermieristica: tra assenze frustranti e presenze ingombranti 48 3.2.1 Senza luogo (il setting) 48 3.2.2 Senza tempo 50 3.2.3 Senza autorità 53 3.2.4 Con la prestazione 56 3.2.5 Con il corpo 59 3.3 I casi e i percorsi relazionali possibili 64 Parte seconda Il percorso di apprendimento 71 Capitolo 4 Il tirocinio: luogo dell’incontro con la sofferenza 73 A cura di Ornella Bonso e Alessandro Ditadi 4.1 Il tirocinio clinico nei corsi di laurea 73 4.2 L’ambiente di apprendimento clinico 76 4.3 L’ambiente di apprendimento clinico: tra opportunità e sofferenze 79 4.4 La necessità e la fatica del viaggio dentro se stessi 82 4.5 Sviluppare la resilienza 86 4.6 Il caso e i percorsi relazionali possibili 90 4.7 Diagramma di flusso per affrontare il tirocinio 96 Capitolo 5 Il modello di Carl Rogers e l’assistenza infermieristica 99 A cura di Elena Filippo e Alessandro Ditadi 5.1 Carl Rogers: la vita 99 5.2 Le idee 101 5.3 Le opere 102 5.3.1 La terapia centrata sul cliente 102 5.3.2 On Becoming a Person 104 5.3.3 Libertà nell’apprendimento 106 5.3.4 Un modo di essere 108 5.3.5 Psicoterapia di consultazione 110 5.4 La terapia centrata sul cliente: concetti principali 111 5.4.1 Tre condizioni per instaurare una relazione 114 5.5 L’applicazione del modello nell’assistenza infermieristica 116 5.5.1 L’infermiere umanistico 118 Capitolo 6 Aspetti fondanti del praticare la relazione nell’assistenza infermieristica 123 6.1 Esporsi abitando l’autenticità 123 A cura di Elena Filippo e Alessandro Ditadi 6.1.1 L’autenticità 123 6.1.2 Esposizione e autenticità nell’assistenza 125 6.1.3 Il caso e i percorsi relazionali possibili 130 6.1.4 Diagramma di flusso per praticare l’autenticità 135 6.2 Accettazione positiva – ascolto 137 A cura di Alessandro Ditadi e Katyuscia Tinti 6.2.1 L’accettazione positiva 137 6.2.2 L’ascolto 139 6.2.3 Il caso e i percorsi relazionali possibili 145 6.2.4 Diagramma di flusso per praticare l’accettazione positiva e l’ascolto 151 6.3 Empatia: la spia dell’allarme relazionale 153 A cura di Alessandra Cigna e Alessandro Ditadi 6.3.1 Considerazioni generali 153 6.3.2 Le dimensioni dell’empatia 154 6.3.3 Empatia e assistenza 156 6.3.4 Coltivare l’empatia: un doppio beneficio per chi riceve l’assistenza e per chi la pratica 163 6.3.5 Il caso e i percorsi relazionali possibili 165 6.3.6 Diagramma di flusso per praticare l’empatia 168 6.4 La consapevolezza delle emozioni e il comportamento assertivo 172 A cura di Alessandro Ditadi 6.4.1 Considerazioni generali 172 6.4.2 La strada “stretta” della consapevolezza emotiva 177 6.4.3 L’assertività come percorso 181 6.4.4 Il caso e i percorsi relazionali possibili 183 6.4.5 Diagramma di flusso per divenire consapevoli delle emozioni e praticare l’assertività 187 6.5 Il giudizio: minaccia alla relazione 189 A cura di Matteo Lorenzato e Alessandro Ditadi 6.5.1 Considerazioni generali 189 6.5.2 Presenza pervasiva del giudizio 190 6.5.3 Prendere coscienza del nostro giudizio e pregiudizio 194 6.5.4 Lo sguardo del giudizio: motivazioni e conseguenze 197 6.5.5 Come favorire la sospensione del giudizio 199 6.5.6 Il caso e i percorsi relazionali possibili 200 6.5.7 Diagramma di flusso per evitare il giudizio 203 6.6 Il silenzio 206 A cura di Alessandro Ditadi e Valentina Sartori 6.6.1 Considerazioni generali 206 6.6.2 Aspetti del silenzio 207 6.6.3 Il silenzio in ambito sanitario 211 6.6.4 Il silenzio buono 214 6.6.5 I casi e i percorsi relazionali possibili: come essere di fronte al silenzio superando la prigionia della nostra percezione 215 6.6.6 Diagramma di flusso per stare nelle situazioni difficili di silenzio 219 6.7 L’approccio riflessivo 221 A cura di Ornella Bonso e Alessandro Ditadi 6.7.1 Considerazioni generali 221 6.7.2 L’apprendimento esperienziale 222 6.7.3 La riflessione nel corso dell’azione 224 6.7.4 L’apprendimento riflessivo nella pratica clinica 229 6.7.5 Educazione all’approccio riflessivo 231 6.7.6 Il caso e i percorsi relazionali possibili 238 6.7.7 Diagramma di flusso per attuare l’approccio riflessivo 245 6.8 Il gruppo 247 A cura di Alessandro Ditadi e Katyuscia Tinti 6.8.1 Origine e significato dei gruppi 247 6.8.2 I processi e gli obiettivi del gruppo 249 6.8.3 L’esperienza di gruppo per sviluppare le abilità relazionali nei corsi universitari per infermieri 251 6.8.4 Che cosa si sperimenta nei gruppi? I casi e i percorsi relazionali possibili per lo studente (o il professionista) e il docente-tutor 253 6.8.5 Diagramma di flusso per essere nel gruppo 261 Parte terza Il laboratorio professionale nei corsi di laurea in infermieristica: lo sviluppo di abilità relazionali 263 Capitolo 7 La genesi del progetto 265 A cura di Alessandro Ditadi e Giampietro Ricci 7.1 L’esperienza “Narrare il tirocinio” 265 7.1.1 La realtà che ha fatto nascere il progetto 266 7.1.2 Il nome, gli obiettivi, la scelta degli studenti 270 7.1.3 Articolazione, tempi e conduzione di “Narrare il tirocinio” 271 7.2 La valutazione di “Narrare il tirocinio” 273 7.2.1 L’empatia 273 7.2.2 La competenza emotiva 274 7.2.3 Sintesi conclusiva sui risultati “Narrare il tirocinio” 276 Capitolo 8 La cassetta degli attrezzi per il laboratorio professionale “Praticare la relazione” del 1° anno 277 A cura di Alessandro Ditadi, Ornella Bonso, Lorella Feltrin, Paola Piccolo 8.1 Obiettivi del primo anno del laboratorio professionale “Sviluppo di abilità relazionali” 277 8.1.1 Primo anno, i presupposti della relazione: introduzione e obiettivi specifici 278 8.1.2 Premesse: il luogo, i conduttori e i co-conduttori, i contenuti 280 8.2 Primo incontro: presentarsi. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 283 8.3 Secondo incontro: l’autenticità. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 286 8.4 Terzo incontro: l’autenticità. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 292 8.5 Quarto incontro: l’accettazione positiva. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 297 8.6 Quinto incontro: l’ascolto. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 303 8.7 Sesto incontro: riflessioni sull’ascolto. Contenuti e istruzioni per il conduttore 308 8.8 Settimo incontro: comprensione empatica. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 310 8.9 Ottavo incontro: l’assertività. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 316 8.10 Nono e ultimo incontro: un bilancio. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 323 8.11 Problematiche emerse nella gestione del gruppo: i casi 326 8.11.1 Caso n. 1: Angelo libertà espressiva o contenimento? 326 8.11.2 Caso n. 2: Benedetta e l’ostacolo del “sapere” 327 8.11.3 Caso n. 3: Agostino e il disorientamento del conduttore 329 8.11.4 Caso n. 4: Andrea e le sue chiusure, quali strategie? 331 8.11.5 Caso n. 5: il gruppo che non voleva divenire gruppo, il primo anno: gli attacchi 333 Capitolo 9 La cassetta degli attrezzi per il laboratorio professionale “Praticare la relazione” del 2° anno 339 A cura di Alessandro Ditadi, Ornella Bonso, Lorella Feltrin, Paola Piccolo 9.1 Obiettivi del secondo anno del laboratorio professionale “Sviluppo di abilità relazionali” 339 9.1.1 Secondo anno, affrontare la complessità: introduzione e obiettivi specifici 340 9.1.2 Premesse: il luogo, i conduttori e i co-conduttori, i contenuti 343 9.2 Primo incontro: presentarsi. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 345 9.3 Secondo incontro: parliamo della morte e del morire. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 348 9.4 Terzo incontro: scriviamo della morte e del morire. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 355 9.5 Quarto incontro: parliamo ancora una volta della morte e del morire. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 361 9.6 Quinto incontro: il dolore e la sofferenza prima parte. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 368 9.7 Sesto incontro: il dolore e la sofferenza seconda parte. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 375 9.8 Settimo incontro: la ripresa. Contenuti e istruzioni per il conduttore 381 9.9 Ottavo incontro: la solitudine. Contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 382 9.10 Nono e ultimo incontro: contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 389 9.11 Problematiche emerse nella gestione del gruppo: i casi 394 9.11.1 Caso n. 1: Maria e le ondate emotive: tra amplificazioni e malesseri reali 394 9.11.2 Caso n. 2: parlare in gruppo della morte e del morire, una sfida emotiva 396 9.11.3 Caso n. 3: il gruppo e il dilemma del negativo nella realtà 398 9.11.4 Caso n. 4: il conduttore e la sopportazione del tempo 400 9.11.5 Caso n. 5: il gruppo che non voleva divenire gruppo, il secondo anno: la stabilizzazione svalutativa 402 Capitolo 1 0 La cassetta degli attrezzi per il laboratorio professionale “Praticare la relazione” del 3° anno 407 A cura di Alessandro Ditadi, Ornella Bonso, Paola Piccolo 10.1 Obiettivi del terzo anno del laboratorio professionale “Sviluppo di abilità relazionali” 407 10.1.1 Terzo anno, sperimentare l’autonomia: obiettivi specifici 408 10.1.2 Premesse: il luogo, i conduttori e i co-conduttori 410 10.1.3 I contenuti e la conduzione: la grande discontinuità 411 10.2 Primo incontro: istruzioni per il conduttore 413 10.3 Gli altri incontri: contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 414 10.4 L’ultimo incontro: contenuti e istruzioni per il conduttore, indicazioni per lo studente 418 10.5 Contenuti portati in gruppo dagli studenti 421 10.6 Approfondimento di alcuni contenuti e riflessi sul gruppo 424 10.6.1 Contenuto n. 1: vedere se stessi con gli occhi degli altri 424 10.6.2 Contenuto n. 2: fidarsi per affidarsi 425 10.6.3 Contenuto n. 3: il pregiudizio 427 10.6.4 Contenuto n. 4: eutanasia e cure palliative, così muore un italiano 429 10.6.5 Contenuto n. 5: fine o inizio? 431 10.7 Il gruppo che non voleva divenire gruppo, il terzo anno e i risultati 432 10.8 Per i conduttori e per gli studenti 434 Capitolo 1 1 I risultati 439 A cura di Alessandro Ditadi, Alessandra Cigna, Francesca Carraro, Alessia Fattoretto, Angela Longhi, Alessia Mulas, Chiara Piran, Valentina Sartori, Katyuscia Tinti, Ornella Bonso, Giampietro Ricci 11.1 Gli ambiti monitorati 439 11.2 I livelli di empatia 440 11.2.1 Monitoraggio dei livelli di empatia negli studenti che hanno partecipato agli incontri di gruppo “Praticare la relazione”. Confronto con l’empatia della popolazione non sanitaria e quella del personale infermieristico 441 11.2.2 Confronto dei livelli di empatia tra gli studenti che hanno partecipato agli incontri di gruppo “Praticare la relazione” e quelli di altre due sedi dell’Università di Padova che hanno seguito modelli diversi di laboratorio relazionale 444 11.2.3 Rilevazione dei livelli di empatia nel personale di assistenza collegato alla rilevazione di abusi assistenziali 446 11.3 La competenza emotiva 447 11.3.1 Monitoraggio delle difficoltà emotive negli studenti che hanno partecipato agli incontri di gruppo “Praticare la relazione” nella sede di Mirano 449 11.3.2 Confronto tra gli studenti con difficoltà emotive che hanno partecipato agli incontri di gruppo “Praticare la relazione” e quelli di altre due sedi dell’Università di Padova che hanno seguito modelli diversi di laboratorio relazionale 450 11.3.3 Confronto tra le difficoltà emotive e di comportamento di infermieri, di studenti non partecipanti e partecipanti al gruppo relazionale 452 11.4 L’orientamento all’assistito 455 11.5 Stress e burnout negli studenti 459 11.5.1 Confronto tra i livelli di stress e la presenza di rischio di burnout negli studenti di due Corsi di Laurea in Infermieristica 460 11.6 Sintesi sui risultati 462 11.7 Conclusioni 465 Bibliografia 467 Indice analitico 469 |
Questo libro è anche in:
