Il periodo espulsivo e dintorni [Danti - Piccin Editore]
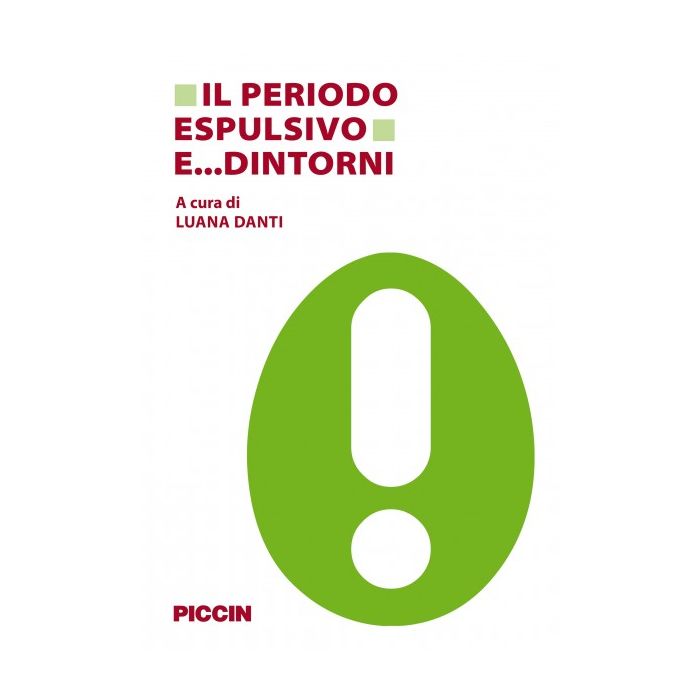
- ISBN/EAN
- 9788829928194
- Editore
- Piccin Editore
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2017
- Pagine
- 305
Disponibile
60,00 €
Gli operatori che lavorano in Sala Parto, dalla loro formazione e dall’esperienza, appren- dono che il momento più delicato di tutto l’evento “nascita” è quasi sempre la parte finale, il cosiddetto “periodo espulsivo”. Si chiama così da sempre, ma il significato semantico reale è assai più variegato e circostanziato: non si tratta semplicemente di “espellere” il feto, bensì di affrontare per un tempo variabile molti eventi complessi, sia legati alla non facile meccanica del parto, sia correlati agli straordinari eventi relazionali ed emozionali che la nascita comporta.
Molti sono gli attori in questo scenario.
L’attore principale è il feto che deve nascere. Il passaggio attraverso il canale del parto si accompagna ad una sostanziale attivazione dell’asse simpatico-adrenergico, situazione defi- nita da alcuni Autori “stress del travaglio”, necessaria per il benessere del nascituro. Ma il feto è anche impegnato da ore ad adattarsi all’attività contrattile del periodo dilatante: non dimentichiamoci che ogni contrazione rappresenta un evento relativamente impegnativo per il feto, perché presuppone una riduzione dell’ossigenazione, tanto maggiore quanto più dura la contrazione stessa, e che necessita di un tempo adeguato (almeno 2-3 minuti) perché si ritorni alla situazione di PaO2 precedente. Un feto sano, a termine, con una placenta nor- mofunzionante, ha tutte le competenze biologiche per affrontare molto bene la relativa e temporanea ipossia legata agli eventi contrattili. Peraltro, senza un tempo di recupero sufficientemente lungo, a causa della tachisistolia, sia spontanea (6%), sia iatrogena (perché legata all’utilizzo spesso non corretto dell’ossitocina), il feto può andare incontro a una situa- zione di ipossia relativa sub acuta e alla potenzialmente pericolosa evoluzione emogasanalitica conseguente. Al termine del periodo dilatante il feto deve ancora affrontare la fase finale del travaglio, caratterizzata da contrazioni più forti e più lunghe, e spesso per tempi relativamente prolungati (alcune ore). Pertanto ha ancora più necessità del supporto e dell’energia della ma- dre e di operatori non interventisti a sproposito, ma rispettosi della fisiologia.
La madre: il periodo dilatante, anche quando ha una durata normale, presuppone per la gravida ore di tolleranza del dolore intermittente legato al travaglio: anche nelle situazioni
PREFAZIONE
Gli operatori che lavorano in Sala Parto, dalla loro formazione e dall’esperienza, appren- dono che il momento più delicato di tutto l’evento “nascita” è quasi sempre la parte finale, il cosiddetto “periodo espulsivo”. Si chiama così da sempre, ma il significato semantico reale è assai più variegato e circostanziato: non si tratta semplicemente di “espellere” il feto, bensì di affrontare per un tempo variabile molti eventi complessi, sia legati alla non facile meccanica del parto, sia correlati agli straordinari eventi relazionali ed emozionali che la nascita comporta.
Molti sono gli attori in questo scenario.
L’attore principale è il feto che deve nascere. Il passaggio attraverso il canale del parto si accompagna ad una sostanziale attivazione dell’asse simpatico-adrenergico, situazione defi- nita da alcuni Autori “stress del travaglio”, necessaria per il benessere del nascituro. Ma il feto è anche impegnato da ore ad adattarsi all’attività contrattile del periodo dilatante: non dimentichiamoci che ogni contrazione rappresenta un evento relativamente impegnativo per il feto, perché presuppone una riduzione dell’ossigenazione, tanto maggiore quanto più dura la contrazione stessa, e che necessita di un tempo adeguato (almeno 2-3 minuti) perché si ritorni alla situazione di PaO2 precedente. Un feto sano, a termine, con una placenta nor- mofunzionante, ha tutte le competenze biologiche per affrontare molto bene la relativa e temporanea ipossia legata agli eventi contrattili. Peraltro, senza un tempo di recupero sufficientemente lungo, a causa della tachisistolia, sia spontanea (6%), sia iatrogena (perché legata all’utilizzo spesso non corretto dell’ossitocina), il feto può andare incontro a una situa- zione di ipossia relativa sub acuta e alla potenzialmente pericolosa evoluzione emogasanalitica conseguente. Al termine del periodo dilatante il feto deve ancora affrontare la fase finale del travaglio, caratterizzata da contrazioni più forti e più lunghe, e spesso per tempi relativamente prolungati (alcune ore). Pertanto ha ancora più necessità del supporto e dell’energia della ma- dre e di operatori non interventisti a sproposito, ma rispettosi della fisiologia.
La madre: il periodo dilatante, anche quando ha una durata normale, presuppone per la gravida ore di tolleranza del dolore intermittente legato al travaglio: anche nelle situazioni più favorevoli è necessario un impegno non da poco, perfino per le madri più motivate. Non è solo l’impegno per tollerare il dolore: si tratta anche di gestire dal punto di vista emo- zionale un evento molto complesso. Il parto è una “relazione” che necessita di un continuo e importante supporto da parte dell’ostetrica che sostiene la donna in questa straordinaria e gioiosa esperienza. È necessario un ambiente in cui la futura mamma si senta libera di espri- mere le proprie sensazioni e paure, per vivere al meglio questo viaggio insieme al proprio partner o alla persona che la accompagna in uno scambio continuo di emozioni, paura ma anche gioia, soddisfazione e crescita personale.
Non sempre questa prima fase del travaglio risulta facile. L’ansia, un ambiente non rispettoso della fisiologia, un supporto inadeguato, interventi medici inopportuni, medica- lizzazione eccessiva, modificano i tempi del travaglio, ma soprattutto il modo di viverlo da parte della donna. È quindi fondamentale sostenere e motivare nel modo migliore possibile la madre che arriva al periodo espulsivo, perché possa affrontare al meglio sia dal punto di vista fisico che emotivo l’ultima “tappa”, che la porterà a tenere finalmente fra le braccia il suo bimbo.
L’ostetrica e il medico sono gli altri attori dello scenario: seguire per ore una donna in travaglio può essere per l’ostetrica molto impegnativo, soprattutto dal punto di vista rela- zionale ed emozionale. Pazienza e calma dovrebbero essere una regola per tutti gli operatori della sala parto. Ma la fisiologia può evolvere in patologia, una situazione di normalità può divenire un’emergenza. E proprio di fronte alle criticità spesso gli operatori incontrano le difficoltà maggiori, sia dal punto di vista decisionale che comunicativo. Quando la donna arriva a dilatazione completa la conclusione dell’evento nascita sembra vicina e talvolta nelle nostre sale parto gli operatori tendono ad accelerare i tempi. Non si rispetta la corretta evoluzione fisiologica degli eventi e frequentemente si interviene in maniera inopportuna con farmaci e/o manovre non necessari e potenzialmente dannosi, aumentando i rischi sia per la madre che per il bambino.
Questo è lo scenario del periodo espulsivo e questi sono gli attori, tutti più o meno impegnati e coinvolti fisicamente e psicologicamente. Ecco perché il secondo stadio del travaglio è il periodo in cui è ancora più necessario mettere a fuoco i comportamenti più appropriati, rispettare i tempi corretti per la donna e per il feto, evitando le scelte sbagliate.
Non si può prescindere dalla conoscenza e dal rispetto corretto dei tempi, dal garantire libertà di espressione e di movimento alla donna e dall’utilizzo delle giuste posture materne per facilitare l’impegno e l’adeguata discesa del feto nel canale del parto. Invece spesso la madre in periodo espulsivo è tenuta supina. La posizione litotomica riduce fino al 40-45% la pressione di perfusione a livello dello spazio intervilloso e di conseguenza toglie ossigeno al feto proprio quando ne ha più bisogno. Pur nel rispetto dei tempi e delle posture ade- guate, non si può prescindere anche dal supporto continuo alla gravida e dalla necessità di creare una buona empatia. Una corretta dinamica relazionale è indispensabile per aiutare la donna a ben tollerare non solo il dolore, ma anche tutte le paure consce e inconsce che la gravida in travaglio posta spesso con sé.
Cercheremo di passare in rassegna in maniera cronologica le tante regole che bisogna rispettare, indicando i comportamenti utili e stigmatizzando quelli da evitare. È drammati- camente importante, quando si fa una scelta operativa, sapere perché lo si fa, quali sono le motivazioni culturali e le conseguenze attese. Non è la fretta che deve guidare le decisioni cliniche e i comportamenti relazionali, ma la corretta comprensione della fisiologia e del- la patologia, quest’ultima purtroppo più frequente in periodo espulsivo che non in periodo dilatante. Un esempio per tutti: la bradicardia fetale grave è attesa in periodo espulsivo con una frequenza 10 volte maggiore che in periodo dilatante (4-5 casi ogni 100 parti, anche nelle situazioni di assoluta fisiologia precedente). Poiché la bradicardia grave deve essere affrontata sempre rispettando la regola dei 3 minuti, è indispensabile che gli operatori rico- noscano con tempestività le anomalie più severe e che abbiano un’organizzazione adeguata a far nascere il feto il più rapidamente possibile dall’inizio della bradicardia stessa: più passa il tempo più aumentano in modo esponenziale tutti i rischi fetali. È quindi mandatoria la tempestività nel riconoscere la grave patologia cardiotocografica, ma tempestive ed adegua- te devono essere anche le scelte cliniche di intervento.
Oltre alla corretta gestione delle gravi anomalie cardiotocografiche, molte altre sono le difficoltà che si possono incontrare: la decisione per esempio di ricorrere ad un parto operativo deve presupporre che l’operatore sappia scegliere il momento più opportuno e sappia gestire correttamente la procedura. Ecco perché sono così importanti tutti i corsi che insegnano la gestione dell’emergenza e le simulazioni fatte con i manichini: il Clinico deve conoscere bene la teoria e nel nostro libro si cercherà di riproporre nel modo più aggiornato possibile le indicazioni della Letteratura. Peraltro nella corretta gestione dell’emergenza, che comunque rimane per fortuna rara, non basta la teoria ma è necessario migliorare le proprie skills attraverso esercitazioni pratiche con simulatori e questo è il motivo per cui il Gruppo GEO ormai da parecchi anni organizza corsi in cui le simulazioni relative alle differenti emergenze coinvolgono a turno tutti i partecipanti. L’organizzazione di sessioni teorico- pratiche si è dimostrata efficace per una più corretta e tempestiva gestione delle emergenze cardiotocografiche, per la scelta del parto operativo, per la gestione della distocia di spalla o dell’emorragia post partum.
Nel nostro libro vogliamo però affrontare anche altri argomenti, tra cui la modalità di clampaggio del funicolo. La Letteratura recente infatti ha dimostrato come la scelta del clampaggio tardivo abbia per il neonato dei vantaggi significativi, senza peraltro impedire il corretto controllo dell’equilibrio acido-base alla nascita. A questo proposito nel capitolo relativo si sottolineerà l’importanza di avere alla nascita il controllo emogasanalitico almeno dall’arteria ombelicale ma, nei casi critici, anche dalla vena, poiché i dati relativi a questi esami sono estremamente importanti ai fini dell’epicrisi e dal punto di vista medico legale. Purtroppo non tutti gli eventi avversi si possono evitare, ma un pH arterioso altamente pa- tologico, se controbilanciato da un pH venoso ancora nella norma, sta ad indicare in modo inoppugnabile che i tempi della nascita sono stati corretti, che non si è perso tempo e che non ci sono responsabilità da parte degli Operatori.
I tempi del travaglio sono cambiati anche per la diffusione sempre più ampia della par- toanalgesia e di questo si stanno rendendo conto tutte le principali Società Scientifiche. È bene fare il punto su quali siano gli effetti dell’analgesia sui tempi del travaglio, sulla dina- mica uterina, sulla posizione del feto. Conoscere questi effetti significa sapere come vadano gestiti, in un rapporto di collaborazione continua tra anestesista, ostetrica e ginecologo, governato da conoscenze e obiettivi comuni, seppure con competenze diverse. Il lavoro d’équipe rappresenta un presupposto straordinariamente importante, soprattutto per evita- re scelte cliniche inopportune.
Infine nell’ultimo capitolo si affrontano le problematiche legate alla prevenzione dei possibili danni perineali (OASIS: Obstetrical Anal Sphincter Injuries). Periodi espulsivi troppo prolungati, con i conseguenti interventi ostetrici che spesso ne derivano, o altret- tanto traumatici perché troppo rapidi, devono presupporre la conoscenza e messa in pratica di metodiche adeguate a ridurre i potenziali danni perineali, sia anatomici che funzionali. L’esperienza unita alla conoscenza della letteratura più recente servirà ad identificare se ci sono possibili metodiche preventive.
Alla fine di questo excursus crediamo che le ragioni per scrivere un libro sul periodo espulsivo e su quanto è necessario fare anche subito dopo la nascita siano veramente molte. Nei vari capitoli cercheremo di dare tutte le motivazioni alle scelte cliniche più corrette, citeremo le indicazioni date dalla letteratura relativa più recente e uniremo esperienza e cultura per identificare i possibili errori e mettere in guardia i Lettori dai rischi correlati.
L’augurio che ci facciamo è che questo libro possa essere utile a tutti gli operatori coin- volti nel meraviglioso viaggio che è la nascita di un bambino, per comprendere quando e se sia necessario intervenire e quando invece solo osservare. Lo scopo dichiarato è di migliorare la propria operatività in sala parto e, soprattutto, di essere di aiuto per le madri che si affi- dano alla nostra competenza.
Quando entriamo in sala parto, il nostro comune obiettivo è quello di assistere le donne nel loro percorso, per far nascere nel modo migliore possibile i loro bambini e per ridurre al minimo i rischi. Nascere e far nascere è un evento straordinario ed è l’esperienza forse più importante nella vita di una donna. A noi Operatori il compito di rendere questi eventi indimenticabili tutte le volte che si può e di contribuire nel modo migliore possibile alla gioia che ogni nascita comporta.
Luana Danti
e tutti i Colleghi Autori di questo testo
Maggiori Informazioni
| Autore | Danti Luana |
|---|---|
| Editore | Piccin Editore |
| Anno | 2017 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | 1 - I tempi del periodo espulsivo 1 Marzia Isabella Maini Considerazioni iniziali, 2 Come sono cambiati i tempi del secondo stadio del travaglio in letteratura, 3 Tempi di assistenza, 6 Durata del secondo stadio del travaglio e outcome materno-neonatale, 10 Interventi in periodo espulsivo ed outcome materno-neonatale, 11 L’assistenza nel secondo stadio del travaglio: tempi e modalità delle spinte, 12 La cascata emozionale e ormonale del travaglio e del parto, 16 Ri essioni e conclusioni, 19 2 - Uso ragionato e appropriato delle posture in periodo espulsivo 25 Anita Regalia, Roberta Spandrio Introduzione, 26 Cenni anatomo-funzionali del bacino e in uenza delle posture sugli spazi del canale, 27 Gli svantaggi della posizione litotomica al parto e principi per un’assistenza posturale appropriata, 40 Posture e dolore/analgesia peridurale, 45 Posture e trasformazione del pavimento pelvico, 47 Casi clinici che esempli cano l’uso delle posture per favorire il meccanismo del parto nei 3 stretti, 49 3 - La cardiotocogra a in periodo espulsivo 55 Luana Danti Considerazioni iniziali, 56 Problemi e possibili errori del periodo espulsivo, 56 Le grandi di erenze fra il primo e il secondo stadio del travaglio, 58 Come controllare il benessere del feto in periodo espulsivo quando la gravidanza è siologica e non ci sono segni di ipossia, 60 L’interpretazione della cardiotocogra a in periodo espulsivo, 61 La classi cazione di Piquard, 62 Cosa è importante valutare oltre alla cardiotocogra a, 65 I possibili di erenti scenari: cosa fare e cosa non fare, 66 I tempi e la gestione dell’emergenza in presenza di bradicardia grave e prolungata, 73 Manovre conservative: come e perché, 75 Cosa non fare quando la situazione è critica, 77 Esempi e casi clinici, 79 4 - La rotazione manuale per correggere la posizione occipito-posteriore 103 Massimo Stefano Cordone Introduzione, 104 Le posizioni cefaliche di vertice con occipite posteriore, 104 Fattori predisponenti, 107 La diagnosi di posizione, 110 Il travaglio in occipito-posteriore, 112 Il parto in occipito-posteriore, 114 I rischi materni e fetali del travaglio e parto in OP, 117 Meccanismi della rotazione, 118 Le posture terapeutiche, 119 La storia delle manovre di rotazione manuale, 120 La rotazione digitale e manuale nell’ostetricia moderna, 123 Casistica personale, 128 Consigli pratici, 130 Sitogra a, 134 5 - Il parto operativo con ventosa omnicup 135 Antonio Ragusa, Sara D’Avino Introduzione, 136 Generalità, 137 Indicazioni, 138 Domande che il medico deve porsi prima di adire a un parto operativo con ventosa ostetrica, 140 Gestione del rischio clinico nel parto con ventosa ostetrica, 162 Comunicazione, 162 Preparazione del campo di azione, 163 Tecnica, 163 Come ridurre il trauma feto/neonatale durante il parto vaginale con ventosa ostetrica, 168 E etti sul neonato del parto vaginale con ventosa ostetrica , 171 6 - Gestione della distocia di spalle 183 Pietro Alimondi, Alessandro Svelato Definizione e incidenza, 184 Fattori di rischio, 184 Sospetta macrosomia, stato diabetico materno e parto operativo vaginale, 185 Prevenzione, 190 Diagnosi, 191 Trattamento, 192 Il professionista di fronte all’evento DS: come evitare gli errori cognitivi, 193 Manovre di I livello, 196 Manovre di II livello, 198 Manovre di III livello, 201 Complicanze materne e lesioni fetali, 203 Compilazione della cartella clinica, 205 7 - Il clampaggio del funicolo: quando e perché 209 Denise Rinaldo Premessa, 210 Storia del timing del clampaggio del cordone ombelicale, 211 Fisiologia, 211 Dalla circolazione fetale alla circolazione neonatale, 212 L’e etto del clampaggio del cordone ombelicale prima della ventilazione polmonare, 213 E etti siologici del timing del clampaggio del cordone e determinanti della “trasfusione placentare”, 214 E etti a breve e lungo termine del timing del clampaggio del cordone sui nati pretermine e di basso peso, 218 E etti a breve e lungo termine del timing del clampaggio del cordone sui nati a termine , 220 E etti del timing del clampaggio del cordone sugli outcomes materni, 222 Stato marziale in età infantile e sviluppo: enfasi sulla prevenzione, 223 Tecnica del clampaggio ritardato del cordone, 224 E etti del timing del clampaggio sul bancaggio/raccolta del sangue cordonale, 225 Conclusioni, 225 8 - Importanza dell’equilibrio acido-base alla nascita 231 Alessandro Svelato Fisiologia dell’equilibrio acido-base fetale, 232 Equilibrio acido-base e transizione alla vita neonatale, 234 Signi cato e valutazione dell’equilibrio acido-base alla nascita, 235 Utilizzo dell’equilibrio acido-base come strumento didattico, 241 Rapporto tra equilibrio acido-base ed esiti neonatali, 242 9 - Profilassi e gestione medica dell’emorragia post partum (EPP) 249 Claudio Crescini De nizione, 250 Epidemiologia , 250 Stima della perdita ematica intra partum, 250 Sintomi a seconda del grado di perdita ematica e segni clinici precoci dello shock nella EPP , 253 I fattori di rischio della EPP, 253 Le quattro T: tono, trauma, tessuto, trombina, 254 Interventi preventivi nalizzati alla riduzione della perdita ematica post partum, 256 Trattamento attivo del terzo stadio del travaglio, 257 Farmaci uterotonici, 257 Farmaci antiemorragici, 259 Il team di sala parto per l’emergenza/urgenza nel trattamento dell’emorragia post partum , 260 I quattro punti di “attacco” per il controllo dell’EPP. Azioni di diretta responsabilità del personale ostetrico , 262 Il sostegno del circolo, 263 Emoderivati, 265 Embolizzazione delle arterie uterine, 266 Conclusioni, 266 10 - Analgesia epidurale e secondo stadio 269 Luca Maria Pietro D’Andrea Introduzione, 270 Cenni di anatomia, siopatologia e farmacologia, 271 Conduzione del II stadio in analgesia, 275 Conduzione dell’analgesia nel II stadio, 276 Conclusioni, 277 11 - Prevenzione dei possibili traumi perineali e ruolo dell’episiotomia 279 Anna Rosa Zilioli Il perineo al parto, 280 La “care” del perineo nel secondo stadio, 283 L’unità madre-feto e il perineo, 291 L’episiotomia , 293 L’esperienza di una nascita, 298 Bibliogra a, 300 Indice analitico 303 Acronimi e abbreviazioni 308 |
Questo libro è anche in:
