Immunologia. Un percorso breve (Con Contenuto digitale) 7/ed.
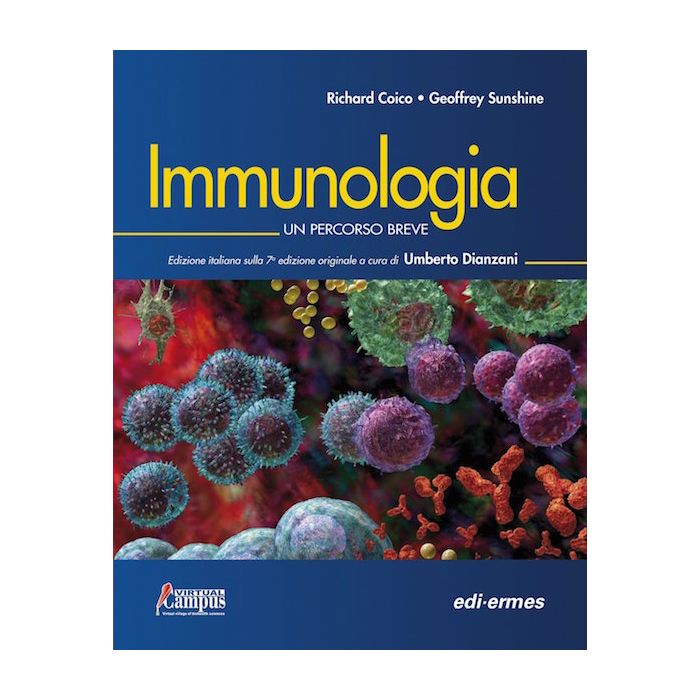
- ISBN/EAN
- 9788870516234
- Editore
- Edi. Ermes
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2018
- Edizione
- 7
- Pagine
- 424
Disponibile
50,00 €
La nuova edizione italiana, basata sulla settima americana, vuole fornire al lettore una visione concisa e chiara delle attuali conoscenze sulla fisiologia del sistema immunitario e sulla fisiopatologia delle malattie immunomediate. Informazioni essenziali affiancate dalle nuove conoscenze.
L’approccio di base è quello di trattare la risposta immunitaria sottolineando il coinvolgimento di due rami della risposta: innata e adattativa. Nell’ultimo decennio le nuove conoscenze sull’immunità innata hanno rivoluzionato la comprensione dell’interazione tra ospite e patogeno e del suo impatto sui meccanismi di difesa nelle infezioni e, pertanto, è stato aggiunto un nuovo capitolo su questo argomento.
Analisi completa della moderna immunologia, senza il peso di un eccesso di informazioni o di discussioni teoretiche: concetti base per garantire agli studenti un’adeguata preparazione.
La successione dei temi affrontati segue lo schema di un corso di Immunologia: ciascun capitolo è strutturato con breve introduzione, a cui fa seguito la trattazione fondamentale, un riassunto che riprende i concetti chiave e una serie di domande di verifica con le relative risposte commentate, che ha lo scopo di permettere allo studente di valutare e rafforzare il proprio apprendimento.
Particolare cura al ricco apparato iconografico del testo: accanto alle fotografie a colori, sono presenti illustrazioni realizzate in modo uniforme, con icone specifiche che identificano i vari elementi, così da permettere allo studente che predilige la modalità visiva di apprendimento di memorizzare meglio i concetti base.
Less is more: un insegnamento dal mondo dell’architettura che può essere applicato alla didattica e alla preparazione di un libro di testo rigoroso, lineare e completo.
Meno è di più: si tratta di una grande rivoluzione che capovolge il paradigma dell’abbondanza di nozioni e indica che in realtà il miglior risultato – il di più – si ottiene preparando un testo essenziale e perfetto per le sue funzioni.
Per ottenere ciò è necessaria una grandissima competenza nel sapere cosa inserire e che cosa togliere di superfluo.
L’approccio di base è quello di trattare la risposta immunitaria sottolineando il coinvolgimento di due rami della risposta: innata e adattativa. Nell’ultimo decennio le nuove conoscenze sull’immunità innata hanno rivoluzionato la comprensione dell’interazione tra ospite e patogeno e del suo impatto sui meccanismi di difesa nelle infezioni e, pertanto, è stato aggiunto un nuovo capitolo su questo argomento.
Analisi completa della moderna immunologia, senza il peso di un eccesso di informazioni o di discussioni teoretiche: concetti base per garantire agli studenti un’adeguata preparazione.
La successione dei temi affrontati segue lo schema di un corso di Immunologia: ciascun capitolo è strutturato con breve introduzione, a cui fa seguito la trattazione fondamentale, un riassunto che riprende i concetti chiave e una serie di domande di verifica con le relative risposte commentate, che ha lo scopo di permettere allo studente di valutare e rafforzare il proprio apprendimento.
Particolare cura al ricco apparato iconografico del testo: accanto alle fotografie a colori, sono presenti illustrazioni realizzate in modo uniforme, con icone specifiche che identificano i vari elementi, così da permettere allo studente che predilige la modalità visiva di apprendimento di memorizzare meglio i concetti base.
Less is more: un insegnamento dal mondo dell’architettura che può essere applicato alla didattica e alla preparazione di un libro di testo rigoroso, lineare e completo.
Meno è di più: si tratta di una grande rivoluzione che capovolge il paradigma dell’abbondanza di nozioni e indica che in realtà il miglior risultato – il di più – si ottiene preparando un testo essenziale e perfetto per le sue funzioni.
Per ottenere ciò è necessaria una grandissima competenza nel sapere cosa inserire e che cosa togliere di superfluo.
Maggiori Informazioni
| Autore | Coico Richard; Sunshine Geoffrey; Umberto Dianzani |
|---|---|
| Editore | Edi. Ermes |
| Anno | 2018 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | 1 PANORAMICA SUL SISTEMA IMMUNITARIO 1 Introduzione ........................................................ 1 Immunità innata e adattativa ............................... 2 Immunità innata ............................................. 2 Immunità adattativa ........................................ 2 Teoria della selezione clonale ............................. 3 Immunizzazione attiva, passiva e adottiva .......... 5 Principali caratteristiche della risposta immunitaria adattativa ........ 5 Cellule coinvolte nella risposta immunitaria adattativa ........ 5 Immunità umorale e cellulare .............................. 6 Immunità umorale .......................................... 6 Immunità cellulo-mediata .................................... 7 Origine della diversità nella risposta immunitaria .............................. 8 Benefici assicurati dall’immunologia .................. 8 Effetti dannosi della risposta immunitaria .......... 9 Il futuro dell’immunologia .................................. 9 Il breve corso inizia qui ....................................... 10 2 IMMUNITÀ INNATA 11 Introduzione ......................................................... 11 Barriere fisiche e chimiche dell’immunità innata ....................................... 11 Origine, differenziazione e caratterizzazione delle cellule del sistema immunitario innato ................. 12 Riconoscimento di spettri molecolari: la caratteristica della risposta immunitaria innata ............... 15 Recettori di riconoscimento di spettro .......... 16 Complemento ....................................................... 18 Uccisione intracellulare ed extracellulare dei microrganismi .......... 19 Infiammazione ..................................................... 20 Caratteri distintivi dell’infiammazione .......... 20 Risposta infiammatoria localizzata ................ 22 Infiammazione cronica ................................... 23 Febbre .............................................................. 23 Domande di autovalutazione ............................... 25 Risposte alle domande di autovalutazione ... 25 3 IMMUNITÀ ADATTATIVA 26 Cellule e organi coinvolti nell’immunità adattativa .............. 26 Organi linfatici ............................................... 27 Migrazione e ricircolo dei linfociti ................ 30 Il destino dell’antigene dopo l’ingresso nell’organismo ...................... 32 Frequenza dei linfociti naïve antigene-specifici ....................................... 32 Interazione tra immunità innata e adattativa ....... 33 Domande di autovalutazione ............................... 34 Risposte alle domande di autovalutazione ... 34 4 IMMUNOGENI E ANTIGENI 35 Introduzione ......................................................... 35 Requisiti per l’immunogenicità ........................... 35 Estraneità ........................................................ 35 Alto peso molecolare ...................................... 36 Complessità chimica ....................................... 36 Degradabilità .................................................. 37 Apteni .............................................................. 37 Ulteriori requisiti per l’immunogenicità ........ 38 Risposta primaria e secondaria ............................ 38 Antigenicità e sito di legame per l’antigene ....... 38 Epitopi riconosciuti dai linfociti B e dai linfociti T ........................ 39 Principali classi di antigeni ................................. 40 Legame dell’antigene con anticorpi o linfociti T antigene-specifici ........................ 41 Cross-reattività ..................................................... 41 Adiuvanti ............................................................. 42 Domande di autovalutazione ............................... 45 Risposte alle domande di autovalutazione ... 46 5 STRUTTURA E FUNZIONE DEGLI ANTICORPI 47 Introduzione ......................................................... 47 Isolamento e caratterizzazione delle immunoglobuline .......... 48 Struttura delle catene leggere e pesanti............... 48 Domini ................................................................. 50 Regione cerniera .................................................. 51 Regione variabile ................................................. 51 Varianti immunoglobuliniche .............................. 53 Isotipi .............................................................. 53 Allotipi ............................................................ 53 Idiotipi ............................................................. 54 Caratteristiche strutturali delle IgG ..................... 55 Proprietà biologiche delle IgG ....................... 55 Agglutinazione e formazione di precipitato .. 55 Passaggio attraverso la placenta e assorbimento nel neonato ....................... 56 Opsonizzazione ............................................... 57 Citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente ................................ 58 Attivazione del complemento ......................... 58 Neutralizzazione delle tossine ........................ 58 Immobilizzazione dei batteri ......................... 58 Neutralizzazione dei virus ............................. 58 Caratteristiche strutturali delle IgM .................... 59 Proprietà biologiche delle IgM ............................ 59 Fissazione del complemento ........................... 59 Immunità neonatale e prima linea di difesa umorale ................. 59 Agglutinazione ................................................ 60 Isoemoagglutinazione ..................................... 60 Caratteristiche strutturali e proprietà biologiche delle IgA ..................... 60 Proprietà biologiche delle IgA ....................... 60 Ruolo nelle infezioni delle mucose ................ 60 Attività battericida .......................................... 61 Attività antivirale ............................................ 61 Caratteristiche strutturali e proprietà biologiche delle IgD ..................... 61 Caratteristiche strutturali e proprietà biologiche delle IgE ..................... 61 Importanza delle IgE nelle infezioni parassitarie e nelle reazioni di ipersensibilità ............... 62 Cinetica della risposta anticorpale dopo l’immunizzazione ................................... 62 Risposta primaria ........................................... 62 Risposta secondaria ........................................ 62 Superfamiglia delle immunoglobuline ................ 63 Domande di autovalutazione ............................... 65 Risposte alle domande di autovalutazione ... 66 6 INTERAZIONI ANTIGENE-ANTICORPO, TEST IMMUNOLOGICI E SISTEMI SPERIMENTALI 67 Introduzione ......................................................... 67 Interazioni antigene-anticorpo ............................. 67 Interazioni primarie tra anticorpo e antigene ...... 69 Costante di associazione ................................ 69 Affinità e avidità ............................................. 69 Interazioni secondarie tra anticorpo e antigene .................................. 70 Reazioni di agglutinazione ............................. 70 Reazioni di precipitazione .............................. 71 Test immunologici ............................................... 74 Test immunologici a legame diretto............... 74 Test immunologici in fase solida ................... 75 Immunofluorescenza ............................................ 76 Immunofluorescenza diretta ........................... 76 Immunofluorescenza indiretta ........................ 76 Citofluorimetria .................................................. 76 Immunoassorbimento e immunoadsorbimento ... 78 Analisi della funzione dei linfociti ............... 78 Test di proliferazione di linfociti B e T ......... 78 Produzione anticorpale dei linfociti B ........... 78 Test funzionali per linfociti T e cellule natural killer ................................ 79 Colture cellulari ................................................... 79 Colture primarie e linee cellulari linfoidi clonate ................. 79 Ibridomi B e anticorpi monoclonali ............... 80 Ibridomi T ....................................................... 81 Molecole e recettori ingegnerizzati geneticamente .................... 81 Modelli sperimentali animali............................... 81 Ceppi inbred ................................................... 82 Trasferimento adottivo ................................... 82 Topi SCID ....................................................... 82 Topi timectomizzati e atimici congeniti (nudi) ............. 82 Topi transgenici e gene targeting ....................... 83 Topi transgenici .............................................. 83 Topi knockout e knock-in ............................... 83 Analisi dell’espressione genica ........................... 84 Microarray per valutare l’espressione genica . 84 Domande di autovalutazione ............................... 86 Risposte alle domande di autovalutazione ... 87 7 LE BASI GENETICHE DELLA STRUTTURA ANTICORPALE 88 Introduzione ......................................................... 88 Breve rassegna della struttura ed espressione di geni non immunoglobulinici ...................... 88 Eventi genetici nella sintesi delle catene delle Ig .................... 90 Organizzazione e riarrangiamento dei geni della catena leggera ..................... 90 Sintesi della catena j ................................... 90 Sintesi della catena k ..................................... 91 Organizzazione e riarrangiamento dei geni della catena pesante ..................... 92 Esclusione allelica e regolazione dell’espressione del gene dell’Ig ................ 93 Switch isotipico ................................................... 94 Generazione della diversità anticorpale .............. 95 Presenza di geni V multipli nella sequenza germinale .......................... 95 Associazione combinatoria VJ e VDJ .......... 95 Associazione casuale delle catene H ed L ................................... 95 Diversità giunzionale ...................................... 95 Ipermutazione somatica .................................. 96 Conversione genica somatica ........................ 96 Ruolo della citidina deaminasi indotta dall’attivazione nella generazione della diversità anticorpale .............. 97 Domande di autovalutazione ............................... 98 Risposte alle domande di autovalutazione ... 99 8 BIOLOGIA DEL LINFOCITA B 100 Introduzione ....................................................... 100 Differenziazione dei linfociti B ......................... 100 Aspetti generali............................................. 100 Sedi di differenziazione precoce dei linfociti B .......................................... 101 Linfociti pro-B e pre-B: primi riarrangiamenti delle Ig ................. 101 Linfociti B immaturi .................................... 103 Linfociti B transizionali ............................... 104 Linfociti B maturi ....................................... 104 Plasmacellule ................................................ 104 Linfociti B memoria ..................................... 105 Sedi della sintesi anticorpale ............................. 105 Interazione tra antigene, linfociti B e linfociti T helper nel linfonodo ............ 105 Eventi nel centro germinativo ...................... 106 Sintesi anticorpale nelle mucose .................. 108 Risposte anticorpali timo indipendenti ........ 109 Proteine di membrana dei linfociti B ................ 110 Marcatori stadio-specifici ............................. 110 Molecole che legano l’antigene: immunoglobuline di membrana .............. 110 Molecole di trasduzione del segnale associate alle immunoglobuline di membrana ................ 110 Molecole coinvolte nell’interazione dei linfociti T e B .................................... 111 Homing ......................................................... 112 Segnali intracellulari nel linfocita B .......... 112 Domande di autovalutazione ............................. 116 Risposte alle domande di autovalutazione ... 116 9 LINFOCITI T: RICONOSCIMENTO DELL’ANTIGENE E RUOLO DELLE MOLECOLE DEL COMPLESSO MAGGIORE DI ISTOCOMPATIBILITÀ 117 Introduzione ....................................................... 117 Origine del nome MHC ..................................... 117 Ruolo dell’MHC nella presentazione dell’antigene .................. 118 Le cellule dell’ospite esprimono diverse molecole MHC che interagiscono con diversi tipi di linfociti T .............. 119 MHC di classe I ............................................ 119 MHC di classe II .......................................... 119 Variabilità delle molecole MHC di classe I e II ............................................... 120 Struttura delle molecole MHC di classe I e II .. 120 MHC di classe I ............................................ 120 Struttura e funzione delle molecole MHC di classe II ............. 122 Processazione e presentazione dell’antigene: come le molecole MHC legano peptidi e creano ligandi che interagiscono con i linfociti T ........... 124 Antigeni esogeni e generazione di complessi peptide-MHC di classe II ... 124 Antigeni endogeni: generazione di complessi peptide-molecole MHC di classe I ......... 126 Cross-presentazione: antigeni esogeni presentati nella via dell’MHC di classe I 127 Quali risposte dei linfociti T sono indotte da quali antigeni? ................ 128 Le molecole MHC legano peptidi derivati da molecole self .......................... 128 Incapacità di rispondere a un antigene ........ 129 Altri tipi di antigene che attivano la risposta di linfociti T ............. 129 Superantigeni ................................................ 129 Lipidi e glicolipidi ........................................ 130 Numerosi antigeni attivano i linfociti T cd .. 130 Geni della regione HLA .................................... 131 Nomenclatura delle molecole MHC polimorfiche .............. 131 Regolazione dell’espressione dei geni MHC .... 131 Espressione codominante ............................. 131 Regolazione coordinata ................................ 132 Ereditarietà dei geni MHC ........................... 132 MHC in altre specie .......................................... 132 Diversità delle molecole MHC: associazione dell’MHC con la resistenza e la suscettibilità alle malattie .....................133 Domande di autovalutazione ............................... 135 Risposte alle domande di autovalutazione ... 136 10 BIOLOGIA DEL LINFOCITA T 137 Introduzione ....................................................... 137 Il recettore per l’antigene dei linfociti T ........... 137 Molecole che interagiscono con l’antigene .. 137 Il complesso del TCR ................................... 139 Corecettori .................................................... 140 Altre importanti molecole espresse sulla superficie cellulare ........... 141 Molecole coinvolte in adesione e homing .. 142 Linfociti T cd ............................................. 142 Geni che codificano per i TCR ......................... 143 Generazione della diversità del TCR ................ 143 Differenziamento dei linfociti T nel timo ......... 144 Il timo come organo primario del differenziamento dei linfociti T ........ 144 Stadi chiave della differenziazione timica ... 144 Riarrangiamenti genici iniziali: cellule doppie-negative e divergenza dei linfociti T cd ................ 145 Cellule pre-T ................................................. 146 Cellule doppie-positive ................................. 146 Selezione timica ........................................... 146 Fuoriuscita dal timo ...................................... 148 Generazione del repertorio di linfociti T ..... 148 Caratteristiche del linfocita T abche fuoriesce dal timo ............................. 149 Ulteriore differenziamento dei linfociti T CD4+ e CD8+ al di fuori del timo .......... 149 Differenziamento di altri tipi cellulari nel timo ................... 149 Domande di autovalutazione ............................... 151 Risposte alle domande di autovalutazione ... 152 11 ATTIVAZIONE E FUNZIONE DEI LINFOCITI T 153 Introduzione ....................................................... 153 Modello a due segnali dell’attivazione dei linfociti ......................... 153 Le cellule dendritiche sono APC chiave per i linfociti T naïve .................................... 154 Attivazione dei linfociti T CD4+ ....................... 155 Interazioni cellulari sulla superficie dell’APC e del linfocita T CD4+ ............................. 155 Eventi intracellulari di attivazione del linfocita T CD4+ ........ 156 Differenziazione in cellula effettrice e migrazione fuori dal linfonodo ............ 159 Spegnimento della risposta .......................... 159 Meccanismi alternativi di attivazione dei linfociti T CD4+ .......... 160 Funzione dei linfociti T CD4+ .......................... 161 Sintesi di citochine ....................................... 161 Principali subset dei linfociti T CD4+distinti in base alla produzione citochinica ................. 162 Cross-inibizione dei subset di linfociti T CD4+ ................. 164 Altri subset di linfociti T CD4+ produttori di citochine ............................. 165 Altri aspetti della sintesi di citochine .......... 165 Attività helper nella risposta agli antigeni TD ................ 165 Eventi nel centro germinativo ...................... 166 Riconoscimento combinato .......................... 167 Attivazione e funzione dei linfociti T CD8+ ...................................... 168 Generazione dei linfociti T CD8+ effettori . 168 Uccisione delle cellule bersaglio da parte dei linfociti T CD8+ ....................... 170 Restrizione per MHC e attività killer dei linfociti T CD8+ ........ 171 Linfociti T memoria .......................................... 171 Funzione di altri subset di linfociti T ................ 172 Linfociti NKT ............................................... 172 Linfociti T cd ................................................ 172 Cellule linfoidi innate .................................. 173 Domande di autovalutazione ............................... 174 Risposte alle domande di autovalutazione ... 175 12 CITOCHINE 176 Introduzione ....................................................... 176 Storia delle citochine ......................................... 176 Proprietà pleiotropiche e ridondanti delle citochine ..................... 177 Proprietà generali delle citochine ...................... 177 Proprietà funzionali comuni ........................ 177 Azioni sistemiche comuni ............................ 178 Sorgenti cellulari comuni ed eventi a cascata ................................... 179 Categorie funzionali delle citochine .................. 179 Citochine che promuovono le risposte immunitarie innate ................. 179 Citochine che regolano le risposte immunitarie adattative ........... 181 Citochine che inducono la differenziazione di distinti tipi di linfociti T .................... 181 Citochine che inibiscono la differenziazione dei vari tipi di linfociti T ........................ 182 Citochine che promuovono le risposte infi ammatorie ......................... 183 Citochine che agiscono sul movimento dei leucociti..................... 184 Citochine che stimolano l’ematopoiesi ......... 185 Recettori citochinici ........................................... 185 Famiglie dei recettori citochinici ................. 185 Catene comuni dei recettori citochinici ....... 186 Trasduzione del segnale mediato dai recettori citochinici ................... 187 Ruolo delle citochine e dei recettori citochinici nelle malattie ............................... 188 Sindrome da shock tossico ........................... 188 Shock settico batterico ................................. 189 Tumori ........................................................... 189 Autoimmunità e altre malattie su base immunitaria ....... 189 Utilizzo terapeutico delle citochine e dei recettori citochinici .............................. 189 Inibitori/antagonisti delle citochine ............. 189 Come contrastare i deficit cellulari .............. 190 Trattamento di immunodeficienze ............... 190 Trattamento dei pazienti affetti da tumori, infezioni virali e che hanno subìto trapianti di organi e tessuti ...................... 190 Trattamento di allergie e asma ..................... 191 Domande di autovalutazione ............................... 192 Risposte alle domande di autovalutazione ... 193 13 TOLLERANZA E AUTOIMMUNITÀ 194 Introduzione ....................................................... 194 Tolleranza centrale ............................................. 195 Meccanismi della tolleranza centrale: linfociti T e B ........................................... 195 Meccanismi di tolleranza centrale: linfociti B ................................................. 196 Tolleranza periferica .......................................... 197 Anergia .......................................................... 198 Linfociti T con attività regolatoria ............... 199 Interazione Fas-FasL .................................... 200 Tolleranza orale ................................................. 201 Privilegio immunitario ....................................... 201 Autoimmunità e malattia ................................... 201 Suscettibilità genetica ................................... 202 Suscettibilità ambientale ............................. 204 Farmaci e ormoni che stimolano l’autoimmunità ................. 205 Malattie autoimmuni.......................................... 206 Malattie autoimmuni in cui gli anticorpi hanno un ruolo predominante nel mediare il danno d’organo ................. 206 Malattie autoimmuni con prevalente ruolo dei linfociti T nel danno d’organo .......... 210 Strategie terapeutiche ................................... 213 Domande di autovalutazione ............................... 215 Risposte alle domande di autovalutazione ... 216 14 COMPLEMENTO 217 Introduzione ....................................................... 217 Panoramica sull’attivazione del complemento ........................................... 217 Via classica ................................................... 218 Via lectinica .................................................. 219 Via alternativa ............................................... 220 Fasi condivise da tutte le vie: attivazione di C3 e C5 ............................. 221 Via terminale ................................................ 222 Regolazione dell’attività del complemento ....................... 222 Attività biologiche del complemento ........................................... 224 Produzione di opsonine ................................ 225 Produzione di anafilotossine ........................ 225 Lisi ................................................................ 226 Altre importanti funzioni del complemento ...................................... 226 Deficit del complemento ................................... 228 Domande di autovalutazione ............................... 231 Risposte alle domande di autovalutazione ... 232 15 IPERSENSIBILITÀ DI TIPO I 233 Introduzione ....................................................... 233 Ipersensibilità ................................................ 233 Classificazione di Coombs-Gell ................... 233 Aspetti generali delle reazioni allergiche .......... 234 Fase di sensibilizzazione ................................... 234 La produzione di anticorpi IgE dipende dai linfociti TH2 ......................... 234 Fase di attivazione ............................................. 235 Fase effettrice .................................................... 237 Mediatori preformati .................................... 237 Mediatori neosintetizzati .............................. 238 Fase ritardata ................................................ 238 Aspetti clinici delle reazioni allergiche ............. 240 Rinite allergica ............................................. 240 Allergie alimentari........................................ 240 Dermatite atopica .......................................... 241 Asma ............................................................. 241 Diagnosi e terapia per l’allergia ........................ 242 Diagnosi ........................................................ 242 Terapia ........................................................... 242 Ruolo protettivo delle IgE ................................. 244 Domande di autovalutazione ............................... 246 Risposte alle domande di autovalutazione ... 247 16 IPERSENSIBILITÀ DI TIPO II E III 249 Introduzione ....................................................... 249 Ipersensibilità di tipo II ..................................... 249 Reazioni mediate dal complemento ............. 249 Citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente ............................... 249 Disfunzioni cellulari mediate da anticorpi ............................... 250 Esempi di reazioni di ipersensibilità di tipo II ............................ 251 Reazioni trasfusionali .................................. 251 Reazioni da farmaci ..................................... 251 Reazioni da incompatibilità Rh ................... 251 Reazioni che coinvolgono recettori di membrana .............................. 251 Reazioni che coinvolgono altri determinanti della membrana cellulare ......................... 252 Ipersensibilità di tipo III ...................................... 252 Malattie da immunocomplessi sistemiche ... 253 Malattie da immunocomplessi localizzate ... 255 Domande di autovalutazione ............................... 257 Risposte alle domande di autovalutazione ... 258 17 IPERSENSIBILITÀ DI TIPO IV 259 Introduzione ....................................................... 259 Caratteristiche generali e fisiopatologia della DTH............................ 259 Meccanismi coinvolti nella DTH ................. 259 Esempi di DTH .................................................. 261 Ipersensibilità da contatto ........................... 261 Ipersensibilità granulomatosa ....................... 262 Ipersensibilità di tipo tubercolinco .............. 263 Rigetto dei trapianti allogenici ..................... 264 Altri esempi di DTH .................................... 264 Terapia della DTH ............................................. 264 Domande di autovalutazione ............................... 266 Risposte alle domande di autovalutazione ... 266 18 IMMUNODEFICIENZE E NEOPLASIE DEL SISTEMA LINFOIDE 268 Introduzione ....................................................... 268 Sindromi da immunodeficienza ......................... 268 Immunodeficienze primarie ......................... 269 Immunodeficienze dei linfociti T e dell’immunità cellulo-mediata .............. 274 Immunodeficienze dei linfociti B o delle immunoglobuline ......................... 276 Disordini dell’interazione T-B ...................... 278 Difetti dei fagociti ........................................ 278 Deficit delle cellule natural killer ................ 280 Malattie causate da anomalie nel sistema del complemento ................... 280 Immunodeficienze secondarie ...................... 282 Sindrome da immunodeficienza acquisita ..................... 282 Descrizione iniziale ed epidemiologia ......... 282 Virus dell’immunodeficienza umana ........... 282 Decorso clinico ............................................. 284 Prevenzione, controllo, diagnosi e terapia dell’infezione da HIV ............... 286 Neoplasie del sistema linfoide .......................... 287 Neoplasie dei linfociti B .............................. 288 Neoplasie dei linfociti B maturi ................... 289 Neoplasie plasmacellulari ............................. 291 Neoplasie dei linfociti T ............................... 292 Neoplasie dei linfociti T maturi ................... 292 Immunoterapia .............................................. 293 Domande di autovalutazione ............................... 295 Risposte alle domande di autovalutazione ... 296 19 TRAPIANTI 298 Introduzione ....................................................... 298 Relazione tra donatore e ricevente ................... 299 Meccanismi immunitari del rigetto degli allotrapianti ........................ 299 Tipi di rigetto ..................................................... 300 Rigetto iperacuto .......................................... 300 Rigetto acuto ................................................ 300 Rigetto cronico ............................................ 300 Ruolo delle molecole MHC nel rigetto dell’allotrapianto ......................... 301 Meccanismi di riconoscimento dell’alloantigene da parte dei linfociti T . 301 Ruolo di linofociti T e citochine nel rigetto degli allotrapianti. ....................... 302 Test di laboratorio per la tipizzazione tessutale .......................... 303 Prolungamento della sopravvivenza dell’allotrapianto: terapia immunosoppressiva ........................... 304 Farmaci antinfiammatori ............................. 305 Farmaci citotossici ........................................ 305 Farmaci che interferiscono con la produzione e l’attività segnalatoria delle citochine .... 305 Terapia immunosoppressiva con anticorpi .. 306 Strategie innovative di immunosoppressione .......................... 306 Trapianto di cellule staminali emopoietiche ................. 307 Graft versus-host disease ................................... 308 Xenotrapianti ..................................................... 308 Il feto: un allotrapianto tollerato ....................... 309 Domande di autovalutazione ............................... 310 Risposte alle domande di autovalutazione ... 311 20 IMMUNOLOGIA DEI TUMORI 312 Introduzione ....................................................... 312 Antigeni tumorali ............................................... 312 Tipi di antigeni tumorali .................................... 313 Prodotti di geni cellulari normali ................ 313 Prodotti di geni cellulari mutati ................... 314 Antigeni tumorali codificati da oncogeni .... 315 Fattori immunologici che influenzano l’incidenza dei tumori ................................... 315 Meccanismi effettori dell’immunità tumorale ................................. 317 Risposta ai tumori mediata dai linfociti B .. 317 Distruzione delle cellule tumorali per opsonizzazione e fagocitosi ............... 317 Perdita delle proprietà adesive della cellula neoplastica mediata da anticorpi ............. 317 Risposta cellulo-mediata contro le cellule tumorali .............................. 317 Distruzione delle cellule tumorali da parte dei linfociti T ............................. 317 Citotossicità cellulo-mediata dipendente da anticorpi ........................... 318 Distruzione del tumore da parte delle cellule NK, NKT e cellule killer attivate da citochine ................................. 318 Distruzione delle cellule tumorali da parte di macrofagi attivati e neutrofili 318 Citochine ............................................................ 319 Limiti della risposta immunitaria antitumorale .............................. 319 Diagnostica immunologica ............................... 320 Proteine mielomatose prodotte da tumori plasmacellulari ......... 321 a-fetoproteina ................................................ 321 Antigene carcinoembrionario ....................... 321 Antigene prostatico ....................................... 321 Antigene tumorale 125 ................................. 321 Immunoprofilassi tumorale ................................ 321 Immunoterapia ................................................... 322 Altre strategie di immunoterapia dei tumori ................... 324 Domande di autovalutazione ............................... 326 Risposte alle domande di autovalutazione ... 327 21 RESISTENZA E IMMUNIZZAZIONE NEI CONFRONTI DELLE MALATTIE INFETTIVE 328 Introduzione ....................................................... 328 Difesa dell’ospite contro vari tipi di patogeni microbici ........... 330 Immunità contro i virus ............................... 330 Immunità contro i batteri ............................. 331 Immunità contro i parassiti .......................... 332 Immunità contro i funghi ............................. 333 Meccanismi di immunoelusione dei patogeni ... 334 Batteri capsulati ............................................ 334 Tossine .......................................................... 334 Superantigeni ................................................ 335 Variazione antigenica ................................... 335 Sopravvivenza intracellulare ........................ 336 Soppressione del sistema immunitario ........ 336 Enzimi extracellulari .................................... 336 Espressione di proteine che legano gli anticorpi ........................... 336 Principi dell’immunizzazione ............................ 336 Obiettivi dell’immunizzazione ......................... 337 Immunizzazione attiva ....................................... 337 Immunizzazioni raccomandate .................... 337 Uso di vaccini in popolazioni selezionate ... 339 Meccanismi di base della protezione ................ 339 Significato della risposta primaria e secondaria .............................. 339 Età e tempi di immunizzazione ................... 339 Precauzioni nell’uso dei vaccini ........................ 341 Sede di somministrazione dell’antigene ...... 341 Rischi ............................................................ 342 Nuovi approcci nella produzione di vaccini ........................... 342 Vaccini prodotti con DNA ricombinante ..... 343 Polisaccaridi coniugati ................................. 343 Vaccini con peptidi sintetici ........................ 343 Vaccini con vettori virali ............................ 343 Vaccini con vettori batterici ......................... 343 Vaccini a DNA.............................................. 344 Tossoidi ......................................................... 344 Immunizzazione passiva ................................... 344 Immunizzazione passiva per trasferimento placentare di anticorpi ............................ 344 Immunizzazione passiva tramite il colostro 344 Terapia anticorpale passiva e sieroterapia .... 345 Preparazioni monoclonali e policlonali ...... 346 Preparazioni e proprietà delle immunoglobuline sieriche umane .. 346 Indicazioni d’uso delle immunoglobuline ... 347 Precauzioni nell’uso di terapie con immunoglobuline sieriche umane .... 348 Fattori stimolanti le colonie ......................... 348 Domande di autovalutazione ............................... 349 Risposte alle domande di autovalutazione ... 350 GLOSSARIO ........................................................ 353 APPENDICE Lista parziale degli antigeni CD ......................... 380 INDICE ANALITICO ............................................. 383 |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
