Chimica Analitica Quantitativa 3/ed. [Harris - Zanichelli]
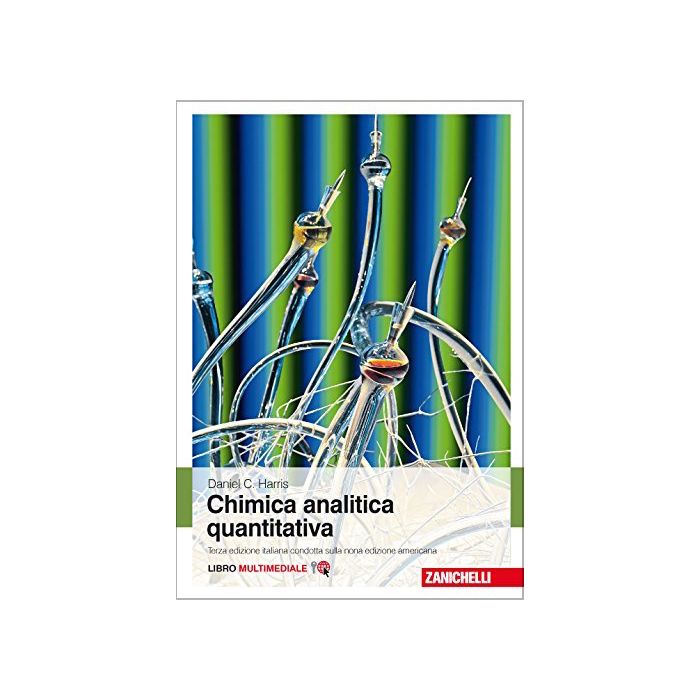
- ISBN/EAN
- 9788808821058
- Editore
- Zanichelli
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2017
- Edizione
- 3
- Pagine
- 928
Disponibile
109,70 €
L’interpretazione chimica e fisica dei fenomeni è considerata materia per specialisti, eppure è di interesse generale sapere come funziona un test di gravidanza, quali sono le implicazioni mediche di un falso positivo, perché si è verificato l’incidente dell’Apollo 13, su cosa si basa l’utilizzo forense del DNA. Queste sono solo alcune delle applicazioni spiegate nella terza edizione italiana di Chimica analitica quantitativa, che usa esempi concreti e interessanti per rendere più accessibile lo studio di una disciplina complessa.
Lo studente può integrare e verificare la propria preparazione grazie ad alcuni strumenti:
- gli esempi di lavoro che permettono di imparare un metodo per la risoluzione di problemi (ogni esempio si conclude con un autotest);
- gli esercizi e i problemi a fine capitolo, corredati da brevi soluzioni al termine del libro;
- i fogli di calcolo elettronici impiegati per simulare diversi tipi di titolazione, risolvere equilibri chimici e simulare separazioni cromatografiche;
- le tavole a colori che illustrano alcune dimostrazioni importanti, quali l’effetto della forza ionica sulla dissociazione, sul meccanismo di ripartizione tra le fasi nella cromatografia e sulla separazione dei pigmenti tramite estrazione in fase solida.
Le risorse multimediali
All’indirizzo online sono disponibili: i test interattivi a scelta multipla, il glossario, la tavola periodica interattiva, i problemi supplementari e, in lingua inglese, le appendici, i fogli di calcolo, i grafici interattivi e gli esperimenti. Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel libro.
Maggiori Informazioni
| Autore | Harris Daniel C. |
|---|---|
| Editore | Zanichelli |
| Anno | 2017 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Prefazione IX 0 Il processo analitico 1 Come funziona un test di gravidanza 1 0.1 Il lavoro del chimico analitico 2 0.2 I comuni passaggi nelle analisi chimiche 8 Box 0.1 Come preparare un campione rappresentativo 9 1 Misurazioni chimiche 11 Misurazioni biochimiche con un nanoelettrodo 11 1.1 Unità di misura SI 11 1.2 Espressioni della concentrazione chimica 15 1.3 Preparazione delle soluzioni 19 1.4 Calcoli stechiometrici per l’analisi gravimetrica 21 2 I ferri del mestiere 27 Misurare l’allungamento di un’unità del filamento di DNA con una bilancia a cristallo di quarzo 27 2.1 Manipolazione responsabile di prodotti chimici e rifiuti 28 2.2 Il quaderno di laboratorio 29 2.3 La bilancia analitica 29 2.4 Burette 33 2.5 Matracci tarati 35 2.6 Pipette e siringhe 36 2.7 Filtrazione 40 2.8 Essiccamento 41 2.9 Calibrazione della vetreria tarata 43 2.10 Introduzione a Microsoft Excel® 44 2.11 Realizzare grafici con Microsoft Excel® 47 Procedura di riferimento Calibrazione di una buretta da 50 mL 51 3 L’errore sperimentale 53 L’errore sperimentale 53 3.1 Cifre significative 53 3.2 Cifre significative nei calcoli aritmetici 54 3.3 Tipi di errori 57 Box 3.1 Un caso di etica: l’errore sistematico nella misurazione dell’ozono 58 Box 3.2 Materiali di riferimento certificati 59 3.4 Propagazione dell’incertezza di un errore casuale 60 3.5 Propagazione dell’incertezza di un errore sistematico 66 Box 3.3 Le masse atomiche degli elementi 67 4 Statistica 73 Il conteggio dei miei globuli rossi è troppo alto oggi? 73 4.1 Distribuzione gaussiana 74 4.2 Confronto di deviazioni standard tramite il test F 78 Box 4.1 La scelta dell’ipotesi nulla in epidemiologia 80 4.3 Intervalli di confidenza 80 4.4 Confronto di medie utilizzando la t di Student 83 4.5 Eseguire il test t con un foglio di calcolo 89 4.6 Test di Grubbs per un dato sospetto (outlier) 90 4.7 Il metodo dei minimi quadrati 91 4.8 Curve di calibrazione 94 Box 4.2 L’utilizzo di una curva di calibrazione non lineare 96 4.9 Un foglio di calcolo per i minimi quadrati 97 5 Assicurazione di qualità e metodi di calibrazione 107 L’esigenza dell’assicurazione di qualità 107 5.1 Le basi dell’assicurazione di qualità 108 Box 5.1 Implicazioni mediche di risultati falsi positivi 109 Box 5.2 Carte di controllo 112 5.2 Validazione del metodo 112 Box 5.3 La tromba di Horwitz: variazione nella precisione interlaboratorio 116 5.3 Addizione standard 119 5.4 Standard interni 122 6 Equilibrio chimico 133 L’equilibrio chimico nell’ambiente 133 6.1 La costante di equilibrio 134 6.2 Equilibrio e termodinamica 135 6.3 Prodotto di solubilità 138 Box 6.1 La solubilità è governata da altre leggi oltre al prodotto di solubilità 139 dimostrazione 6.1 Effetto dello ione comune 140 6.4 Formazione di complessi 141 Box 6.2 Notazioni per le costanti di formazione 141 6.5 Acidi e basi protici 143 6.6 Il pH 146 6.7 Forza degli acidi e delle basi 148 dimostrazione 6.2 La fontana di HCl 149 Box 6.3 Lo strano comportamento dell’acido fluoridrico 150 Box 6.4 L’acido carbonico 152 7 Introduzione alle titolazioni 161 Titolazioni su Marte 161 7.1 Titolazioni 162 7.2 Calcoli nelle titolazioni 164 7.3 La curva di titolazione per precipitazione 165 7.4 Titolazione di una miscela 169 7.5 Computo delle curve di titolazione con foglio di calcolo 171 7.6 Determinazione del punto finale 172 dimostrazione 7.1 Titolazione di Fajans 173 8 L’attività e il trattamento sistematico dell’equilibrio 179 Raggio dello ione idratato 179 8.1 L’effetto della forza ionica sulla solubilità dei sali 180 dimostrazione 8.1 Effetto della forza ionica sulla dissociazione ionica 180 Box 8.1 Sali di ioni con carica $|2| non sono completamente dissociati in acqua 182 8.2 Coefficienti di attività 182 8.3 Una rivisitazione della definizione di pH 186 8.4 Trattamento sistematico dell’equilibrio 187 Box 8.2 Il bilancio di massa del carbonato di calcio nei fiumi 190 8.5 Applicare il trattamento sistematico dell’equilibrio 191 9 Equilibri acido-base monoprotici 207 Misurazione del pH all’interno dei comparti cellulari 207 9.1 Acidi e basi forti 208 Box 9.1 HNO3 concentrato è poco dissociato 208 9.2 Acidi e basi deboli 210 9.3 Equilibri di acidi deboli 212 Box 9.2 La tintura dei tessuti e il grado di dissociazione 214 9.4 Equilibri di basi deboli 215 9.5 Tamponi 217 Box 9.3 Il forte reagisce completamente con il debole 220 dimostrazione 9.1 Funzionamento dei tamponi 222 10 Equilibri acido-base poliprotici 233 Il diossido di carbonio nell’atmosfera 233 10.1 Acidi e basi diprotici 234 Box 10.1 Il diossido di carbonio negli oceani 236 Box 10.2 Approssimazioni successive 240 10.2 Tamponi diprotici 242 10.3 Acidi e basi poliprotici 243 10.4 Qual è la specie principale? 244 10.5 Equazioni di composizione frazionaria 246 Box 10.3 Costanti di microequilibrio 246 10.6 pH isoelettrico e isoionico 248 Box 10.4 Focalizzazione isoelettrica 251 11 Titolazioni acido-base 257 Titolazione acido-base dell’RNA 257 11.1 Titolazione di un acido forte con una base forte 258 11.2 Titolazione di un acido debole con una base forte 260 11.3 Titolazione di una base debole con un acido forte 263 11.4 Titolazioni nei sistemi diprotici 264 11.5 Determinazione del punto finale con un elettrodo per il pH 267 Box 11.1 Alcalinità e acidità 267 11.6 Determinazione del punto finale mediante indicatori 270 dimostrazione 11.1 Indicatori e acidità di CO2 271 Box 11.2 Qual è il significato di un pH negativo? 272 11.7 Osservazioni pratiche 274 11.8 Determinazione dell’azoto secondo Kjeldahl 274 Box 11.3 La determinazione dell’azoto secondo Kjeldahl oltre le linee guida 276 11.9 Effetto livellante 277 11.10 Calcolo delle curve di titolazione con fogli di calcolo 278 Procedura di riferimento Preparazione di soluzioni standard di acidi o basi 288 12 Titolazioni con EDTA 291 La terapia chelante nella talassemia 291 12.1 Complessi metallo-chelante 292 12.2 EDTA 293 12.3 Curve di titolazione con EDTA 298 12.4 Uso del foglio di calcolo 300 12.5 Agenti complessanti ausiliari 301 Box 12.1 L’idrolisi dello ione metallico diminuisce la costante di formazione effettiva per i complessi con EDTA 302 12.6 Indicatori metallocromici 304 dimostrazione 12.1 Variazioni di colore degli indicatori metallocromici 304 12.7 Tecniche di titolazione con EDTA 306 Box 12.2 Durezza dell’acqua 308 13 Trattamento avanzato degli equilibri 315 Piogge acide 315 13.1 Approccio generale ai sistemi acido-base 316 13.2 Coefficienti di attività 319 13.3 La dipendenza della solubilità dal pH 322 13.4 L’analisi delle titolazioni acido-base tramite grafici differenziali 328 14 Fondamenti di elettrochimica 335 Batterie a ioni di litio 335 14.1 Concetti di base 336 Box 14.1 Legge di Ohm, conduttanza e fili molecolari 339 14.2 Celle galvaniche 340 dimostrazione 14.1 Il ponte salino umano 343 Box 14.2 Cella a combustibile a idrogeno e ossigeno 344 Box 14.3 Accumulatori al piombo 345 14.3 Potenziali standard 345 14.4 L’equazione di Nernst 347 Box 14.4 E° e il voltaggio di cella non dipendono da come è scritta la reazione di cella 348 Box 14.5 I diagrammi di Latimer: come trovare E° per una semireazione sconosciuta 350 14.5 Relazione tra E° e la costante di equilibrio 352 Box 14.6 Concentrazioni in una cella in funzione 352 14.6 Impiego delle celle come sonde chimiche 354 14.7 I biochimici utilizzano E°9 356 15 Elettrodi e potenziometria 369 Sequenziamento del DNA per rilascio e misura dei protoni 369 15.1 Elettrodi di riferimento 370 15.2 Elettrodi indicatori 372 dimostrazione 15.1 Applicazione della potenziometria a una reazione oscillante 374 15.3 Che cos’è un potenziale di giunzione? 374 15.4 Come funzionano gli elettrodi iono-selettivi 376 15.5 Misura del pH con un elettrodo a vetro 379 Box 15.1 Errori sistematici nella misurazione del pH dell’acqua piovana: l’effetto del potenziale di giunzione 385 15.6 Elettrodi iono-selettivi 386 Box 15.2 Misurazione dei coefficienti di selettività per un elettrodo iono-selettivo 388 Box 15.3 Come è stato scoperto il perclorato su Marte? 392 Box 15.4 Elettrodi iono-selettivi che impiegano polimeri conduttori, per dosaggi immunologici a “sandwich” 395 15.7 Uso degli elettrodi iono-selettivi 396 15.8 Sensori chimici allo stato solido 398 16 Titolazioni redox 409 Analisi chimica di superconduttori ad alta temperatura 409 16.1 La forma di una curva di titolazione redox 410 Box 16.1 Molte reazioni redox sono reazioni di trasferimento atomico 411 16.2 Determinazione del punto finale 413 dimostrazione 16.1 Titolazione potenziometrica di Fe21 con MnO4 2 414 16.3 Regolazione dello stato di ossidazione dell’analita 416 16.4 Ossidazione con permanganato di potassio 418 16.5 Ossidazione con Ce41 420 16.6 Ossidazione con dicromato di potassio 420 16.7 Metodi basati sullo iodio 421 Box 16.2 Analisi ambientale del carbonio e domanda di ossigeno 422 Box 16.3 Analisi iodometrica di superconduttori ad alta temperatura 426 17 Tecniche elettroanalitiche 433 Quanto è dolce! 433 17.1 Fondamenti di elettrolisi 434 dimostrazione 17.1 Scrittura elettrochimica 434 Box 17.1 Reazioni dei metalli in prossimità dei gradini atomici 440 17.2 Analisi elettrogravimetrica 441 17.3 Coulombometria 443 17.4 Amperometria 446 Box 17.2 L’elettrodo di Clark per l’ossigeno 446 Box 17.3 Che cos’è un “naso elettronico”? 447 17.5 Voltammetria 451 Box 17.4 Il doppio strato elettrico 454 Box 17.5 Biosensori per uso clinico basati su aptameri 456 17.6 Titolazione di H2O con il metodo Karl Fischer 461 18 Fondamenti di spettrofotometria 473 Il buco nell’ozono 473 18.1 Le proprietà della luce 474 18.2 L’assorbimento della luce 474 Box 18.1 Perché la relazione tra la trasmittanza e la concentrazione è logaritmica? 477 dimostrazione 18.1 Gli spettri di assorbimento 479 18.3 Misurazione dell’assorbanza 479 18.4 La legge di Beer applicata all’analisi chimica 481 18.5 Titolazioni spettrofotometriche 485 18.6 Che cosa accade quando una molecola assorbe la luce? 486 Box 18.2 La fluorescenza è ovunque intorno a noi 489 18.7 Luminescenza 490 Box 18.3 Diffusione Raman e Rayleigh 494 Box 18.4 Realizzare una molecola per la determinazione fluorimetrica 496 19 Applicazioni della spettrofotometria 505 Biosensore del trasferimento energetico di risonanza di fluorescenza 505 19.1 Analisi di una miscela 506 19.2 Misurazione di una costante di equilibrio 511 19.3 Il metodo della variazione continua 514 19.4 Analisi per iniezione in flusso e a iniezione sequenziale 515 19.5 Saggi immunologici 519 19.6 Sensori basati sullo spegnimento della luminescenza 521 Box 19.1 Convertire la luce in elettricità 522 Box 19.2 Sovraconversione fotonica 526 20 Spettrofotometri 537 Spettroscopia cavity ring-down 537 20.1 Lampade e laser: sorgenti luminose 538 Box 20.1 La radiazione di un corpo nero e l’effetto serra 540 20.2 Monocromatori 542 20.3 Rivelatori 547 Box 20.2 Il fotorecettore più importante 549 Box 20.3 Misurazione infrarossa fotoacustica non dispersiva della CO2 sul Mauna Loa 553 20.4 Sensori ottici 554 20.5 Spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier 560 20.6 Trattamento del rumore 566 21 Spettroscopia atomica 577 Un enigma antropologico 577 21.1 Una panoramica 578 Box 21.1 Analisi del mercurio per fluorescenza atomica dei vapori freddi 580 21.2 Atomizzazione: fiamme, fornetti e tipi di plasma 580 Box 21.2 Determinazione del sodio con un fotometro e un becco Bunsen 583 21.3 L’influenza della temperatura sulla spettroscopia atomica 587 21.4 Strumentazione 589 21.5 Interferenza 594 21.6 Campionamento con l’ablazione laser 596 Box 21.3 Spettroscopia di emissione atomica su Marte 597 21.7 Spettrometria di massa con plasma ad accoppiamento induttivo 598 21.8 Fluorescenza di raggi X 600 22 Spettrometria di massa 609 Elettronebulizzazione 609 22.1 Che cos’è la spettrometria di massa? 609 Box 22.1 Massa molecolare e massa nominale 611 Box 22.2 Come vengono separati da un campo magnetico gli ioni di massa differente 611 22.2 Oh, spettro di massa, parlami! 614 Box 22.3 Spettrometria di massa a distribuzione isotopica e temperatura corporea dei dinosauri 617 22.3 Tipi di spettrometria di massa 622 22.4 Interfacce cromatografia – spettrometria di massa 630 22.5 Tecniche di cromatografia – spettrometria di massa 635 Box 22.4 Ionizzazione laser assistita dal desorbimento della matrice 639 Box 22.5 Come far volare gli elefanti (meccanismi di elettronebulizzazione delle proteine) 640 22.6 Campionamento all’aria aperta per la spettrometria di massa 644 22.7 Spettrometria di mobilità ionica 646 23 Introduzione alle separazioni analitiche 657 Il latte fa bene al neonato 657 23.1 Estrazione con solvente 657 dimostrazione 23.1 Estrazione con ditizone 660 23.2 Che cos’è la cromatografia? 661 Box 23.1 Gli eteri corona e gli agenti per il trasferimento di fase 662 23.3 L’opinione dell’idraulico sulla cromatografia 664 23.4 Efficienza della separazione 668 23.5 Perché le bande si allargano 674 Box 23.2 Descrizione della cromatografia a livello microscopico 678 24 Gascromatografia 687 Il doping negli sport 687 24.1 Il processo separativo in gascromatografia 688 Box 24.1 Fasi chirali per separare isomeri ottici 692 24.2 Iniezione del campione 699 24.3 Rivelatori 702 Box 24.2 Colonna cromatografica in un chip 706 24.4 Preparazione del campione 709 24.5 Sviluppo di metodi in gascromatografia 712 Box 24.3 Gascromatografia bidimensionale 715 25 Cromatografia liquida ad alta efficienza 723 Paleotermometria: come misurare lo storico delle temperature oceaniche 723 25.1 Il processo cromatografico 724 Box 25.1 Colonne in cristalli colloidali con un milione di piatti operanti con flusso di slittamento 731 Box 25.2 Struttura dell’interfaccia solventefase legata 733 Box 25.3 Tecnologia “verde”: la cromatografia con fluidi supercritici 736 25.2 Iniezione e rivelazione in HPLC 741 25.3 Sviluppo di metodi per separazioni isocratiche in fase inversa 748 25.4 Separazioni a gradiente 756 Box 25.4 La scelta delle condizioni di gradiente e come scalarle 758 25.5 Simulazioni al computer 759 26 Metodi cromatografici ed elettroforesi capillare 771 Impronta genetica 771 26.1 Cromatografia a scambio ionico 772 26.2 La cromatografia ionica 778 Box 26.1 Tensioattivi e micelle 783 26.3 Cromatografia per esclusione molecolare 784 26.4 Cromatografia per affinità 786 Box 26.2 Stampo molecolare 787 26.5 Cromatografia di interazione idrofobica 787 26.6 Principi dell’elettroforesi capillare 787 26.7 Esecuzione di una elettroforesi capillare 794 26.8 Laboratorio in un chip: impronta genetica del DNA 802 27 Analisi gravimetrica e per combustione 811 La scala temporale geologica e l’analisi gravimetrica 811 27.1 Un esempio di analisi gravimetrica 812 27.2 Precipitazione 814 dimostrazione 27.1 Colloidi, dialisi e microdialisi 815 Box 27.1 L’attrazione di Van der Waals 819 27.3 Esempi di calcoli gravimetrici 820 27.4 Analisi per combustione 823 28 Preparazione del campione 831 Abuso di cocaina? Chiedi al fiume 831 28.1 Statistica del campionamento 833 28.2 Solubilizzazione del campione per l’analisi 838 28.3 Tecniche di preparazione del campione 844 Note e riferimenti bibliografici 855 Tavole a colori TC-1 Indice analitico I-1 |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
