Chimica analitica ed analisi quantitativa [Hage; Carr - Piccin Editore]
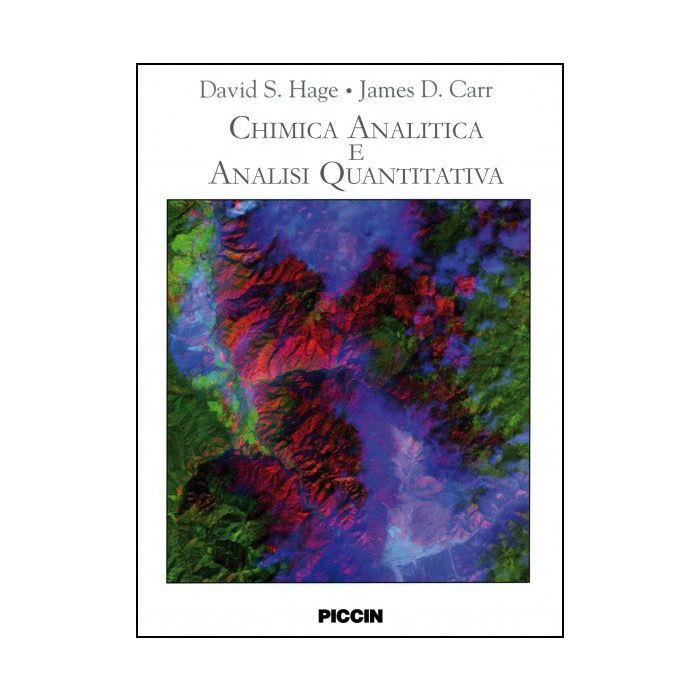
- ISBN/EAN
- 9788829921188
- Editore
- Piccin Editore
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2012
- Edizione
- 1
- Pagine
- 700
Disponibile
50,00 €
Lo scopo della presente opera è quello di mettere lo studente al corrente delle principali tecniche di laboratorio per l’analisi chimica e dei criteri per la loro scelta ed il loro impiego.
Essa include, inoltre, argomenti quali il corretto utilizzo e la manutenzione delle bilance, della vetreria e dei quaderni di laboratorio, così come gli strumenti matematici per la valutazione e il confronto dei risultati sperimentali.
Vengono affrontate e utilizzate le nozioni fondamentali dell’equilibrio chimico, per facilitare la dimostrazione dei principi e l’impiego appropriato di metodi classici di analisi quali la gravimetria e le titolazioni. Agli studenti vengono inoltre presentate le comuni tecniche strumentali, come la spettroscopia, la cromatografia e i metodi elettrochimici. Una differenza significativa rispetto ad altri testi è il tentativo da parte nostra di organizzare e ponderare gli argomenti trattati in maniera tale da riflettere al meglio l’importanza di questi metodi negli odierni laboratori di analisi.
I capitoli sono suddivisi in gruppi differenti caratterizzati da temi comuni. Una tale architettura consente di passare facilmente da un argomento a quello successivo in vari modi. Per esempio, gli studenti che avessero bisogno di apprendere la parte riguardante gli equilibri chimici e i calcoli correlati potranno fare riferimento ai Capitoli dal 6 al 10, mentre coloro che già possedessero una solida base su questo argomento potrebbero passare direttamente ai capitoli successivi, che trattano tecniche quali la gravimetria o la titolazione.
Un docente che volesse anticipare alcuni metodi strumentali prima ancora di trattare i metodi classici potrebbe ricorrere ai capitoli iniziali per fornire informazioni generali relative all’analisi chimica, per poi passare ad argomenti quali l’elettrochimica, la spettroscopia, o la cromatografia. Riteniamo che una tale impostazione dia agli insegnanti maggiore flessibilità nell’impiego di questo testo sia come fonte per un’introduzione alla chimica analitica di durata semestrale, che come parte di una più tradizionale sequenza di argomenti per un corso di durata annuale, che inizi con l’analisi quantitativa per poi proseguire coi metodi strumentali. Una tale organizzazione degli argomenti fa di questo testo uno strumento pratico e flessibile che può essere utilizzato per tenere corsi di base in chimica analitica, in sintonia con le linee guida recentemente delineate dall’ACS in un rapporto pubblicato nel 2008 dal titolo “Undergraduate Professional Education in Chemistry: ACS Guidelines and Evaluation Procedures for Bachelor’s Degree Programs.”
Un ulteriore obiettivo al quale abbiamo mirato con la realizzazione di questa opera è stato quello di fornire agli studenti un’idea del ruolo che la chimica analitica ha giocato nello sviluppo della scienza e continua a giocare nella vita quotidiana. Per fare ciò, abbiamo fatto riferimento in ogni capitolo a situazioni reali per facilitare la descrizione dei principi in esso trattati. Questa scelta riflette fra l’altro le recenti linee guida che incoraggiano l’utilizzo delle tecniche di apprendimento basato su un problema e di apprendimento basato sull’indagine. Sono inoltre presenti sezioni speciali, sotto forma di riquadri aggiuntivi, per indicare importanti sviluppi nella storia dell’analisi chimica e/o applicazioni comuni della chimica analitica ai problemi del mondo reale. Nella descrizione dei metodi siamo andati al di là delle analisi di tipo organico e inorganico comuni a molti libri, includendo esempi provenienti da campi che vanno dalle scienze ambientali, il monitoraggio dell’inquinamento e i processi industriali alle scienze farmaceutiche, il controllo degli alimenti e le analisi cliniche. Nel fare tutto ciò, la nostra speranza è che gli studenti che leggono questo testo acquisiscano una concezione della chimica analitica come scienza fondamentale, viva ed in continua evoluzione. Essi dovrebbero inoltre raggiungere una maggiore consapevolezza di come la realizzazione e l’utilizzo di metodi per l’analisi chimica sia importante nel processo della scoperta scientifica.
Un altro aspetto che differenzia sostanzialmente quest’opera da altre è il modo in cui gli studenti apprendono gli argomenti. Per esempio, molti capitoli si aprono con uno scenario iniziale in cui allo studente vengono proposti un problema o un gruppo di problemi che richiedono l’impiego di un particolare metodo di analisi. Lo studente viene così introdotto al metodo e guidato attraverso una serie di argomenti indispensabili alla comprensione e l’utilizzo di quella tecnica. Questa impostazione ci consente di trattare gli stessi temi riportati in altri testi di analisi quantitativa, facendo ricorso però ad uno stile più affine allo studente, rispetto al più tradizionale approccio basato sull’argomento. Inoltre aiuterà gli studenti a comprendere più facilmente il valore di ogni argomento nel momento in cui viene presentato. Tutto ciò è rafforzato da esercizi disseminati nel corso del testo e da problemi correlati che figurano al termine di ogni capitolo. La maggior parte di questi problemi possono essere risolti utilizzando l’algebra elementare; tuttavia, alla fine di ciascun capitolo sono stati inseriti “Problemi impegnativi”, alcuni dei quali richiedono l’impiego di fogli di calcolo, e che consentono allo studente di affrontare gli argomenti del capitolo a livello più approfondito. Alla fine di ogni capitolo è inoltre presente una sezione intitolata “Temi per la Discussione e le Relazioni”, che fornisce a docente e studente l’opportunità di esplorare argomenti e metodi correlati a quelli presentati nel capitolo ma che non sono normalmente trattati in un corso tradizionale di analisi quantitativa. Le sezioni “Problemi impegnativi” e “Temi per la Discussione e le Relazioni” sono ideate per sviluppare le abilità dello studente nelle indagini aperte e basate sulla ricerca nell’ambito della chimica analitica. All’interno di queste sezioni sono anche presenti molti spunti per la scrittura, il pensiero critico e il ragionamento in argomenti correlati all’analisi chimica.
Maggiori Informazioni
| Autore | Hage David S.; Carr James D. |
|---|---|
| Editore | Piccin Editore |
| Anno | 2012 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Capitolo 1 Una panoramica sulla chimica analitica 1 1.1 Introduzione: Il caso del chimico misterioso 1 1.2 La storia dell’analisi chimica 2 1.2A Origini dell’analisi chimica 2 1.2B L’analisi chimica nel mondo moderno 4 1.3 Terminologia generale utilizzata in chimica analitica 5 1.3A Termini relativi al campione 5 1.3B Termini relativi al metodo 6 1.4 Le informazioni fornite dall’analisi chimica 8 1.5 Panoramica del testo 10 Parole chiave 10 • Altri termini 10 • Quesiti 11 • Bibliografia 12 Capitolo 2 Buone pratiche di laboratorio 13 2.1 Introduzione: una questione di qualità 13 2.1A Cosa sono le buone pratiche di laboratorio? 13 2.1B Definizione delle buone pratiche di laboratorio 14 n BOX 2.1: La reazione polimerasica a catena 15 2.2 Sicurezza in laboratorio 17 2.2A Elementi comuni della sicurezza in laboratorio 17 2.2B Identificazione dei rischi chimici 17 n BOX 2.2: Determinazione della sicurezza dei prodotti chimici 19 2.2C Fonti di informazione sui prodotti chimici 21 2.2D Corretto impiego delle sostanze chimiche 21 2.3 Il quaderno di laboratorio 24 2.3A Consigli per una buona compilazione del quaderno di laboratorio 25 2.3B Quaderni elettronici e fogli di calcolo 27 2.4 Registrazione dei dati sperimentali 29 2.4A Il sistema internazionale di misura SI 29 2.4B Le cifre significative 32 Parole chiave 34 • Altri termini 34 • Quesiti 34 • Bibliografia 38 Capitolo 3 Misure di massa e di volume 39 3.1 Introduzione: J. J. Berzelius 39 3.2 Misure di massa 40 3.2A La determinazione della massa 40 3.1: Microscopia a forza atomica 42 3.2B Tipologie di bilance da laboratorio 42 3.2C Procedure raccomandate per la misura della massa 44 3.3 Misure di volume 48 3.3A La determinazione del volume 48 3.3B Tipologie di attrezzature volumetriche 48 3.3C Procedure raccomandate per la misura del volume 53 3.4 Campioni, reagenti e soluzioni 55 3.4A Descrizione della composizione di campioni e reagenti 55 3.4B Preparazione delle soluzioni 59 Parole chiave 63 • Altri termini 63 • Quesiti 63 • Bibliografia 68 Capitolo 4 Elaborazione dei dati 69 4.1 Introduzione: take me out to the ball game? 69 4.1A Tipi di errori in laboratorio 70 4.1B Accuratezza e precisione 70 4.2 Descrizione dei risultati sperimentali 71 4.2A Determinazione del valore più rappresentativo 71 4.2B Registrazione della variazione in un gruppo di risultati 72 4.3 La propagazione dell’errore 74 4.3A Addizione e sottrazione 74 4.3B Moltiplicazione e divisione 75 4.3C Logaritmi, antilogaritmi e potenze 76 4.3D Calcoli misti 77 4.4 Distribuzioni del campione ed intervalli di confidenza 77 4.4A Descrizione della variazione in grandi insiemi di dati 78 4.4B Descrizione della variazione in piccoli insiemi di dati 79 4.5 Confronto dei risultati sperimentali 81 4.5A Requisiti generali per il confronto dei dati 81 n BOX 4.1: Chi era “Student”? 82 4.5B Confronto di un risultato sperimentale con un valore di riferimento 83 4.5C Confronto di due o più risultati sperimentali 84 n BOX 4.2: Scelta di un livello di fiducia 85 4.5D Confronto della variazione nei risultati 87 4.6 Individuazione di dati anomali 88 4.6A Strategia generale per il trattamento dei dati anomali 88 4.6B Test statistici per i dati anomali 88 4.7 Rielaborazione dei risultati sperimentali 90 4.7A Regressione lineare 90 4.7B Valutazione della validità di una regressione lineare 92 Parole chiave 95 • Altri termini 95 • Quesiti 95 • Bibliografia 102 Capitolo 5 Caratterizzazione e selezione dei metodi analitici 103 5.1 Introduzione: la mappa di Vinland 103 5.2 Caratterizzazione e validazione del metodo 104 n BOX 5.1: Uno sguardo più ravvicinato ai campioni in piccola scala 105 5.2A Accuratezza e precisione 105 5.2B Risposta al saggio 108 5.2C Altre proprietà dei metodi analitici 111 5.3 Controllo della qualità 112 5.3A Requisiti generali per il controllo di qualità 112 5.3B Preparazione e utilizzo delle carte di controllo 112 5.4 Raccolta e preparazione del campione 113 5.4A Raccolta dei campioni 114 5.4B Preparazione del campione 115 Parole chiave 118 • Altri termini 118 • Quesiti 119 • Bibliografia 123 Capitolo 6 Attività chimica ed equilibrio chimico 124 6.1 Introduzione: “e le previsioni meteo a lungo termine dicono che...” 124 6.1A Tipologie di reazioni e transizioni chimiche 125 6.1B Descrizione delle reazioni chimiche 126 6.2 Attività chimica 126 n BOX 6.1: Datazione al carbonio-14 127 6.2A Cosa si intende per attività chimica? 128 6.2B Attività chimica nei metodi analitici 131 6.3 Equilibrio chimico 136 6.3A Cosa si intende per equilibrio chimico? 136 6.3B Risoluzione di problemi sull’equilibrio chimico 140 Parole chiave 147 • Altri termini 147 • Quesiti 147 • Bibliografia 150 Capitolo 7 Solubilità e precipitazione in chimica 151 7.1 Introduzione: la lotta contro il cancro allo stomaco 151 7.1A Che cos’è la solubilità? 151 7.1B Che cos’è la precipitazione? 152 7.1C Perché solubilità e precipitazione sono importanti nelle analisi chimiche? 153 7.2 Solubilità chimica 154 7.2A Che cosa determina la solubilità di una sostanza? 154 n BOX 7.1: Cristallografia ai Raggi X 155 7.2B Come si può descrivere la solubilità delle sostanze? 157 7.2C Come si determina la solubilità di una sostanza? 164 7.3 Precipitazione chimica 165 7.3A Il processo di precipitazione 165 7.3B Impiego dei prodotti di solubilità per lo studio della precipitazione 166 7.3C Effetti di altre sostanze e reazioni sul processo di precipitazione 168 Parole chiave 170 • Altri termini 170 • Quesiti 170 • Bibliografia 175 Capitolo 8 Reazioni acido-base 176 8.1 Introduzione: “rain, rain go away” 176 8.1A Che cosa sono gli acidi e le basi? 177 8.1B Perché gli acidi e le basi sono importanti nell’analisi chimica? 179 8.2 Descrizione degli acidi e delle basi 180 8.2A Acidi forti e deboli 180 8.2B Basi forti e basi deboli 182 8.2C Le proprietà acide e basiche dell’acqua 182 8.3 Le proprietà acide o basiche di una soluzione 185 8.3A Che cos’è il pH? 185 8.3B Fattori che influenzano il pH 187 8.4 Stima del pH di semplici soluzioni acido-base 187 8.4A Acidi e basi forti monoprotici 187 8.4B Acidi e basi deboli monoprotici 190 8.5 Tamponi e sistemi poliprotici acido-base 193 8.5A Soluzioni tampone 193 n BOX 8.1: Preparazione dei tamponi 194 8.5B Sistemi acido-base poliprotici 196 8.5C Zwitterioni 203 Parole chiave 208 • Altri termini 208 • Quesiti 208 • Bibliografia 215 Capitolo 9 Formazione di complessi 216 9.1 Introduzione: cosa c’è nella mia maionese? 216 9.1A Che cos’è la complessazione? 216 9.1B Quali sono le applicazioni analitiche della complessazione? 217 9.2 Complessi semplici metallo-legante 217 9.2A Che cos’è un complesso metallo-legante? 218 9.2B Costanti di formazione dei complessi metallo-legante 220 9.2C Previsione della distribuzione dei complessi metallo-legante 221 n BOX 9.1: Uno sguardo più ravvicinato ai processi di formazione dei complessi metallo-legante 222 9.3 Complessi di agenti chelanti con ioni metallici 227 9.3A Che cos’è un agente chelante? 227 9.3B L’effetto chelato 227 9.3C Acido etilendiamminotetracetico 228 9.3D Trattamento delle reazioni collaterali 231 9.4 Altri tipi di complessi 234 9.4A Una descrizione generale della formazione dei complessi 234 9.4B Esempi di complessi alternativi 235 n BOX 9.2: Immunodosaggi 236 Parole chiave 237 • Altri termini 237 • Quesiti 237 • Bibliografia 243 Capitolo 10 Le reazioni di ossidoriduzione 244 10.1 Introduzione: salvare l’Arizona 244 10.1A Cosa sono le reazioni di ossidoriduzione? 244 10.1B Come sono utilizzate in chimica analitica le reazioni di ossidoriduzione? 246 10.2 Principi generali delle reazioni di ossidoriduzione 246 10.2A Descrizione delle reazioni di ossidoriduzione 246 10.2B Identificazione delle reazioni di ossidoriduzione 247 10.2C Previsione dell’entità delle reazioni di ossidoriduzione 249 10.3 Celle elettrochimiche 252 10.3A Descrizione delle celle elettrochimiche 252 n BOX 10.1: Una descrizione schematica delle celle elettrochimiche 255 10.3B Previsione del comportamento delle celle elettrochimiche 255 10.4 L’equazione di Nernst 257 10.4A Impiego dell’equazione di Nernst 257 n BOX 10.2: L’equazione di Nernst vista da più vicino 259 10.4B Calcolo dei potenziali delle reazioni di ossidoriduzione 260 10.4C Effetti della matrice del campione e di reazioni collaterali 262 Parole chiave 266 • Altri termini 266 • Quesiti 266 • Bibliografia 272 Capitolo 11 Analisi gravimetrica 274 11.1 “Introduzione:” “messa a punto” della tavola periodica 274 11.1A Cosa si intende per analisi gravimetrica? 274 11.1B Come viene impiegata l’analisi gravimetrica in chimica analitica? 275 11.2 Esecuzione di un’analisi gravimetrica tradizionale 277 11.2A Strategie e metodi generali 277 11.2B Filtrazione del precipitato 278 11.2C Essiccamento e pesata dei precipitati 281 11.2D Metodi per ottenere precipitati di elevata qualità 282 11.3 Esempi di metodi gravimetrici 285 11.3A Precipitazione dell’argento con il cloruro 285 11.3B Precipitazione del ferro con l’idrossido 287 11.3C Precipitazione del nichel con la dimetilgliossima 288 11.3D Analisi per combustione 289 11.3E Analisi termogravimetrica 291 n BOX 11.1: Analisi per combustione, ieri e oggi 292 Parole chiave 293 • Altri termini 294 • Quesiti 294 • Bibliografia 298 Capitolo 12 Titolazioni acido-base 299 12.1 L’origine della titolazione 299 12.1A Cosa si intende per titolazione acido-base? 299 12.1B Come sono utilizzate le titolazioni acido-base in chimica analitica? 301 n BOX 12.1: Il metodo Kjeldahl 304 12.2 Esecuzione di una titolazione acido-base 305 12.2A Preparazione della soluzione del titolante e della soluzione del campione 305 12.2B Esecuzione di una titolazione 307 12.2C Determinazione del punto finale 310 12.3 Previsione ed ottimizzazione delle titolazioni acido-base 313 12.3A Descrizione delle titolazioni acido-base 313 12.3B Curve di titolazione di acidi e basi forti 315 12.3C Curve di titolazione per acidi e basi deboli 319 12.3D Uno sguardo più attento alle titolazioni acido-base 324 Parole chiave 329 • Altri termini 329 • Quesiti 330 • Bibliografia 336 Capitolo 13 Titolazioni complessometriche e per precipitazione 337 13.1 Introduzione: qual è la durezza dell’acqua? 337 13.1A Che cosa sono le titolazioni complessometriche o per precipitazione? 337 13.1B Come sono utilizzate le titolazioni complessometriche e per precipitazione in chimica analitica? 340 13.2 Esecuzione di una titolazione complessometrica 341 13.2A Titolanti e soluzioni standard 341 13.2B Utilizzo di leganti ausiliari e di agenti mascheranti 343 13.2C Determinazione del punto finale 345 13.2D Previsione e ottimizzazione delle titolazioni complessometriche 348 13.3 Esecuzione di una titolazione per precipitazione 352 13.3A Titolanti e soluzioni standard 352 n BOX 13.1: Un Re con un problema 354 13.3B Determinazione del punto finale 355 13.3C Previsione e ottimizzazione delle titolazioni per precipitazione 356 Parole chiave 360 • Altri termini 360 • Quesiti 361 • Bibliografia 366 Capitolo 14 Introduzione all’analisi elettrochimica 367 14.1 Introduzione: avere un sorriso più luminoso 367 14.1A Unità di misura elettriche 367 14.1B Metodi di analisi elettrochimica 370 14.2 Principi generali di potenziometria 370 14.2A Potenziali di cella ed equazione di Nernst 370 14.2B Componenti delle celle per potenziometria 371 14.2C Applicazioni della potenziometria 375 14.3 Elettrodi ionoselettivi e dispositivi correlati 376 14.3A Elettrodi a membrana di vetro 376 n BOX 14.1: L'invenzione del pHmetro 377 14.3B Elettrodi ionoselettivi a stato solido 378 14.3C Elettrodi modificati 380 Parole chiave 381 • Altri termini 381 • Quesiti 381 • Bibliografia 384 Capitolo 15 Titolazioni redox 385 15.1 Introduzione: domanda chimica di ossigeno 385 15.1A Che cos’è una titolazione redox? 385 15.1B Utilizzo delle titolazioni redox in chimica analitica 387 15.2 Esecuzione di una titolazione redox 388 15.2A Preparazione di titolanti e campioni 388 15.2B Rilevamento del punto finale 390 15.3 Previsione e ottimizzazione delle titolazioni redox 394 15.3A Approccio generale ai calcoli per le titolazioni redox 394 15.3B Previsione della forma della curva di una titolazione redox 395 15.3C Utilizzo della frazione di titolazione 398 15.4 Esempi di titolazioni redox 399 15.4A Titolazioni con ceriato 399 15.4B Titolazioni con permanganato 399 15.4C Titolazioni con dicromato 403 15.4D Titolazioni con iodio 405 n BOX 15.1: Il metodo di Karl Fischer 406 Parole chiave 407 • Altri termini 407 • Quesiti 407 • Bibliografia 412 Capitolo 16 Coulombometria, voltammetria e metodi correlati 413 16.1 Introduzione: la zona morta 413 16.2 Elettrogravimetria 413 16.3 Coulombometria 415 16.3A Coulombometria diretta 416 16.3B Titolazioni coulombometriche 416 16.3C Coulombometria a potenziale costante 418 16.4 Voltammetria e amperometria 418 16.4A Voltammetria a corrente continua (o diretta) 419 16.4B Amperometria 421 n BOX 16.1: Voltammetria ciclica 422 16.4C Voltammetria di stripping anodico 423 Parole chiave 424 • Altri termini 424 • Quesiti 424 • Bibliografia 426 Capitolo 17 Introduzione alla spettroscopia 427 17.1 Introduzione: la vista dall’alto 427 17.1A Che cos’è la spettroscopia? 427 17.1B Applicazioni della spettroscopia in chimica analitica 428 17.2 Le proprietà della luce 430 17.2A Che cos’è la luce? 430 n BOX 17.1: NMR: Sincronizzarsi con la struttura chimica 434 17.2B Assorbimento e rilascio della luce da parte della materia 435 17.2C Interazione fisica della luce con la materia 439 17.3 Analisi quantitativa basata sulla spettroscopia 444 17.3A Analisi basate sull’emissione 444 17.3B Analisi basate sull’assorbimento 444 n BOX 17.2: Uno sguardo più ravvicinato alla legge di Beer 446 Parole chiave 450 • Altri termini 451 • Quesiti 451 • Bibliografia 457 Capitolo 18 Spettroscopia molecolare 18.1 Introduzione: il buono, il brutto e il cattivo 458 18.1A Cosa si intende per spettroscopia molecolare? 459 18.1B Come viene utilizzata la spettroscopia molecolare nell’analisi chimica? 459 18.2 Spettroscopia ultravioletta-visibile 460 18.2A Principi generali di spettroscopia ultravioletta-visibile 460 18.2B Strumentazione per spettroscopia UV-visibile 462 18.2C Applicazioni della spettroscopia UV-visibile 464 18.3 Spettroscopia infrarossa 470 18.3A Principi generali di spettroscopia infrarossa 470 18.3B Strumentazione per la spettroscopia infrarossa 471 n BOX 18.1: Spettroscopia Raman 472 18.3C Applicazioni della spettroscopia infrarossa 475 18.4 Luminescenza molecolare 475 18.4A Principi generali di luminescenza 475 18.4B Strumentazione per misure di luminescenza 477 18.4C Applicazioni della luminescenza molecolare 478 Parole chiave 479 • Altri termini 479 • Quesiti 479 • Bibliografia 483 Capitolo 19 Spettroscopia atomica 485 19.1 Introduzione: star light, star bright 485 19.1A Cosa si intende per spettroscopia atomica? 485 19.1B Come viene impiegata la spettroscopia atomica nell’analisi chimica? 486 19.2 Principi di spettroscopia atomica 487 19.2A Atomizzazione del campione 487 19.2B Eccitazione del campione 487 19.2C Proprietà della fiamma 488 19.2D Misurazione dell’analita 489 n BOX 19.1: Entrare in sintonia con i laser 490 19.3 Spettroscopia di assorbimento atomico 491 19.3A Strumenti a flusso laminare 492 19.3B Strumenti a fornace in grafite 493 19.3C Ottimizzazione della spettroscopia di assorbimento atomico 494 19.4 Spettroscopia di emissione atomica 496 19.4A Strumenti a fiamma 496 19.4B Strumenti al plasma 497 Parole chiave 499 • Altri termini 499 • Quesiti 500 • Bibliografia 503 Capitolo 20 Introduzione alle separazioni chimiche 504 20.1 Introduzione: la rivoluzione verde 504 20.1A Che cosa si intende per separazione chimica? 504 20.1B Applicazioni delle tecniche separative alla chimica analitica 505 20.2 Separazioni chimiche basate sull’estrazione 506 20.2A Che cos’è un’estrazione? 506 20.2B Impiego e descrizione delle estrazioni 508 n BOX 20.1: Estrazioni con fluidi supercritici 509 20.2C Uno sguardo più attento alle estrazioni 511 20.3 Separazioni chimiche basate sulla cromatografia 514 20.3A Che cos’è la cromatografia? 514 20.3B Utilizzo e descrizione della cromatografia 516 20.4 Uno sguardo più attento alla cromatografia 518 20.4A Ritenzione dell’analita in cromatografia 518 20.4B Allargamento delle bande cromatografiche 520 n BOX 20.2: Uno sguardo più attento all’equazione di van Deemter 525 20.4C Controllo delle separazioni cromatografiche 526 Parole chiave 529 • Altri termini 529 • Quesiti 529 • Bibliografia 536 Capitolo 21 Gascromatografia 538 21.1 Introduzione: c’è qualcosa nell’aria 538 21.1A Che cos’è la gascromatografia? 539 21.1B Come viene eseguita una gascromatografia? 539 21.2 Fattori che influenzano la gascromatografia 541 21.2A Requisiti dell’analita 541 21.2B Fattori che determinano la ritenzione in gascromatografia 543 21.2C Efficienza della colonna in gascromatografia 546 n BOX 21.1: Confronto delle fasi stazionarie per gascromatografia 547 21.3 Gascromatografia, fasi mobili e metodi di eluizione 547 21.3A Fasi mobili di uso comune in gascromatografia 547 21.3B Metodi di eluizione in gascromatografia 548 21.4 Supporti e fasi stazionarie per gascromatografia 549 21.4A Materiali di supporto per gascromatografia 549 n BOX 21.2: La chimica analitica nello spazio 550 21.4B Fasi stazionarie in gascromatografia 552 21. 5 Rivelatori e manipolazione del campione in gascromatografia 555 21.5A Tipi di rivelatori per gascromatografia 555 21.5B Pretrattamento e iniezione del campione 560 Parole chiave 563 • Altri termini 564 • Quesiti 564 • Bibliografia 569 Capitolo 22 Cromatografia liquida 570 22.1 Introduzione: combattere una moderna epidemia 570 22.1A Che cos’è la cromatografia liquida? 570 22.1B Come si realizza una cromatografia liquida? 571 22.2 Fattori che influenzano la cromatografia liquida 573 22.2A Requisiti dell’analita 573 22.2B Efficienza della colonna in cromatografia liquida 573 22.2C Ruolo della fase mobile nella cromatografia liquida 575 22.3 Tipi di cromatografia liquida 575 n BOX 22.1: Cromatografia su carta e TLC 576 22.3A Cromatografia di adsorbimento 576 22.3B Cromatografia di ripartizione 580 22.3C Cromatografia a scambio ionico 583 22.3D Cromatografia di esclusione dimensionale 586 22.3E Cromatografia di affinità 588 n BOX 22.2: Separazioni chirali 592 22. 4 Rivelatori per cromatografia liquida e pretrattamento del campione 593 22.4A Tipi di rivelatori per cromatografia liquida 593 22.4B Attrezzatura per la cromatografia liquida e pretrattamento del campione 598 Parole chiave 600 • Altri termini 600 • Quesiti 600 • Bibliografia 606 Capitolo 23 Elettroforesi 608 23.1 Introduzione: il progetto genoma umano 608 23.1A Che cos’è l’elettroforesi? 608 23.1B Come si esegue un’elettroforesi? 610 23.2 Principi generali dell’elettroforesi 611 23.2A Fattori che influenzano la migrazione dell’analita 611 23.2B Fattori che influenzano l’allargamento delle bande 614 23.3 Elettroforesi su gel 615 23.3A Che cos’è l’elettroforesi su gel? 615 23.3B Come si esegue un’elettroforesi su gel? 616 n BOX 23.1: Desorbimento/ionizzazione laser assistito da matrice accoppiato alla spettrometria di massa con analizzatore a tempo di volo 618 23.3C Tipi speciali di elettroforesi su gel 618 23.4 Elettroforesi capillare 621 23.4A Che cos’è l’elettroforesi capillare? 621 23.4B Come si effettua un’elettroforesi capillare? 622 23.4C Tipi speciali di elettroforesi capillare 625 n BOX 23.2: La chimica analitica in un chip 627 Parole chiave 629 • Altri termini 629 • Quesiti 629 • Bibliografia 634 Appendici 636 Risposte selezionate 678 Glossario 689 |
Questo libro è anche in:
