Biologia Molecolare 3/Ed.
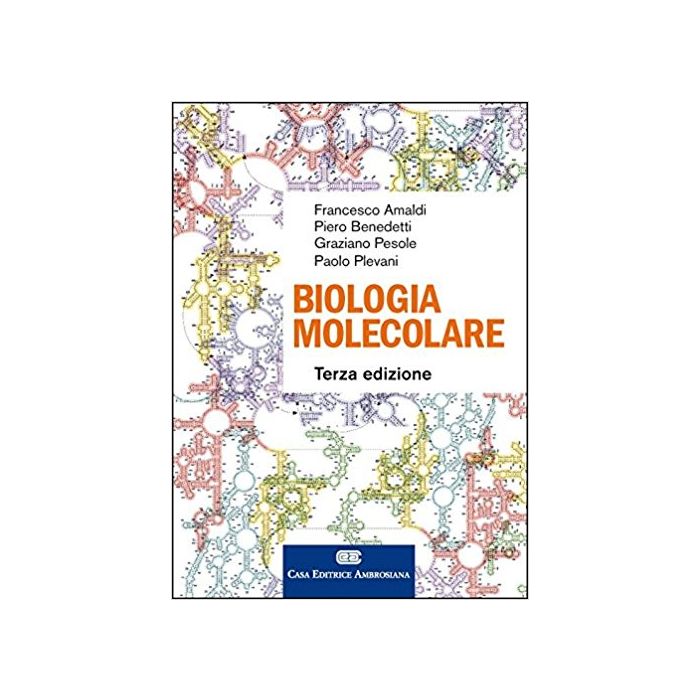
- ISBN/EAN
- 9788808185181
- Editore
- Ambrosiana / CEA
- Formato
- Cartonato
- Anno
- 2018
- Edizione
- 3
- Pagine
- 672
Disponibile
85,10 €
La storia e lo sviluppo della Biologia Molecolare dimostrano come la comprensione a livello molecolare di fenomeni biologici complessi sia possibile solo integrando approcci sperimentali tipici di discipline biologiche diverse. Gli autori, consapevoli di quanto sia import ante trasferire le nuove conoscenze e i metodi di analisi anche nei corsi di studio, hanno preparato quest a terza edizione di Biologia Molecolare mantenendo l’approccio allo studio dei processi biologici che combina l’aspetto biochimico-strutturale a quello genetico-informazionale.
Il filo conduttore del libro è quello classico: il flusso dell’informazione genetica dal DNA alle proteine. In tale contesto si è dato ampio spazio ai diversi livelli di regolazione dell’espressione genica: la struttura e l’organizzazione del D NA in cromatina e cromosomi, la regolazione ai livelli trascrizionale, di processamento di RNA, traduzionale e posttraduzionale. Si è approfondito anche il ruolo regolativo dei ncRNA, si sono descritti i più recenti meccanismi di “genome editing”, le più innovative metodologie di sequenziamento del DNA ed è stata ampiamente aggiornata e riorganizzata la sezione dedicata alle tecniche sperimentali maggiormente utilizzate.
Il testo si caratterizza anche per altri aspetti:
la centralità riservata ai concetti e alle nozioni fondamentali della Biologia Molecolare;
gli approfondimenti inseriti in apposite finestre, per non interrompere il flusso del testo;
la suddivisione in moduli sufficientemente autonomi, offrendo la possibilità di seguire percorsi diversi da quello proposto dall’indice;
il riconoscimento dell’importanza attuale dell’approccio bioinformatico e dell’utilizzo di organismi modello in studi di Biologia Molecolare;
l’inquadramento storico e la forte integrazione tra gli approcci sperimentali.
Maggiori Informazioni
| Autore | Amaldi Francesco; Benedetti Piero; Pesole Graziano; Plevani Paolo |
|---|---|
| Editore | Ambrosiana / CEA |
| Anno | 2018 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | A - DALLA SCOPERTA DEL DNAAL CODICE GENETICO E STRUTTURA DEGLI ACIDI NUCLEICI CAP. 1 - Introduzione alla Biologia Molecolare 3 1.1 Che cos’è la Biologia Molecolare? 3 1.2 Il gruppo del fago e la nascita della Biologia Molecolare 4 1.3 Dalla scoperta del DNA alla dimostrazione del suo ruolo come materiale genetico 6 ■ Letture di approfondimento e siti web 11 CAP. 2 - Struttura degli acidi nucleici 12 2.1 Struttura chimica degli acidi nucleici 12 2.2 Struttura fisica del DNA: la scoperta della struttura a doppia elica 17 2.3 Struttura fisica del DNA: i parametri strutturali della doppia elica 21 – Stabilità della doppia elica di DNA in soluzione 23 – Strutture alternative e strutture superiori degli acidi nucleici 25 2.4 Topologia del DNA e DNA topoisomerasi 33 – DNA topoisomerasi 39 Finestra 2.1 - Varietà e classificazione delle dna topoisomerasi 42 2.5 Struttura dell’RNA 43 Finestra 2.2 - L’RNA Tie Club 44 Finestra 2.3 - Struttura dell’RNA ed energia libera 47 ■ Letture di approfondimento 54 B - ORGANIZZAZIONE ED EVOLUZIONE DI GENI, CROMOSOMI E GENOMI CAP. 3 - Codice genetico 55 3.1 Il “dogma centrale” e prime ipotesi sul codice genetico 55 3.2 Decifrazione del codice genetico 56 3.3 Fasi di lettura e ORF 60 3.4 Mutazioni a soppressione e codice genetico 61 Finestra 3.1 - Origine del nome Amber suppressor 62 3.5 Struttura del codice genetico e sue proprietà 63 3.6 Origine ed evoluzione del codice genetico 65 ■ Letture di approfondimento e siti web 68 CAP. 4 - Impacchettamento del DNA genomico:cromosomi e cromatina 71 4.1 Impacchettamento dei genomi virali 72 4.2 Impacchettamento del genoma batterico 74 4.3 Organizzazione e impacchettamento del DNA eucariotico 75 4.4 Cromatina interfasica e cromosomi mitotici 76 4.5 Organizzazioni atipiche di cromosomi e genomi 78 – Cromosomi a spazzola 78 – Cromosomi politenici 78 – Micronucleo e macronucleo dei ciliati 80 4.6 Centromeri 80 4.7 Telomeri 81 4.8 Nucleosomi e proprietà strutturali e funzionali della cromatina 84 – Posizionamento in fase (phasing) dei nucleosomi 90 – Il posizionamento di un nucleosoma può essere “intrinseco” o “estrinseco” 90 – Nucleosomi e replicazione del DNA 92 – Nucleosomi e trascrizione dei geni 92 – Modificazioni post-traduzionali degli istoni e modulazione dell’attività trascrizionale della cromatina 94 ■ Letture di approfondimento 95 CAP. - 5 - Genomi procariotici ed eucariotici 96 5.1 Era genomica 96 5.2 Genomi procariotici 97 – Caratteristiche, struttura e plasticità dei genomi procariotici 97 – Contenuto genico e composizione in basi dei genomi procariotici 99 – Geni non codificanti proteine ed elementi mobili nei genomi procariotici100 – Applicazioni della Genomica microbica 101 5.3 Genomi eucariotici 102 – Struttura e organizzazione dei genomi eucariotici 102 – Caratteristiche composizionali dei genomi eucariotici 103 – Contenuto genico dei genomi eucariotici 104 – Caratteristiche dei geni eucariotici 105 – Ruolo degli introni nell’evoluzione dei geni eucariotici 106 – Pseudogeni 108 – Sequenze ripetute dei genomi eucariotici 110 – DNA satellite o altamente ripetitivo 111 – DNA mediamente ripetitivo: microsatelliti e minisatelliti 113 Finestra 5.1 - Il test del DNA 114 – Sequenze di DNA ripetitivo intersperse nel genoma 116 – Duplicazioni segmentali 119 – Famiglie geniche 119 – Geni reiterati ed evoluzione parallela 121 5.4 Genoma mitocondriale 123 Finestra 5.2 - Patologie mitocondriali 127 5.5 Genoma dei cloroplasti 129 5.6 Genoma dei virus 130 ■ Letture di approfondimento e siti web 130 C - REPLICAZIONE E MANTENIMENTO DEL GENOMA CAP. 6 - Replicazione del DNA 133 6.1 Replicazione semiconservativa del DNA 134 – L’esperimento di Meselson e Stahl 134 6.2 Modello del replicone 136 6.3 Identificazione delle origini di replicazione 138 – Origine di replicazione di Escherichia coli 138 – Origini di replicazione negli eucarioti 140 – ARS del lievito Saccharomyces cerevisiae 143 – Origini precoci e origini tardive: influenza della struttura del cromosoma 144 Finestra 6.1 - Mappatura fisica delle origini di replicazione 146 6.4 Meccanismo della replicazione del DNA nei procarioti 147 – Isolamento di mutanti letali-condizionali in Escherichia coli alterati nella replicazione del DNA 147 – “Replisoma” di Escherichia coli 148 Finestra 6.2 - Isolamento di mutazioni temperatura-sensibili in Escherichia coli 148 – Scoperta della DNA polimerasi e sue proprietà biochimiche 150 Finestra 6.3 - In Escherichia coli non tutte le DNA polimerasi sono coinvolte nella replicazione del DNA 151 – Fedeltà di replicazione del DNA 152 – Forcella di replicazione: sintesi del filamento continuo e del filamento discontinuo 154 – Innesco della sintesi di DNA 154 – Saggi di complementazione in vitro 156 – Proteine replicative di Escherichia coli 157 Finestra 6.4 - Purificazione di una proteina e saggio di complementazione in vitro 158 Finestra 6.5 - Modalità di generazione dell’estremità 3'Oh richiesta come innesco dalle DNA polimerasi 162 6.5 Meccanismo della replicazione del DNA negli eucarioti 164 – Isolamento di proteine replicative negli eucarioti 164 – Sistemi di ricostituzione in vitro del processo di replicazione 164 Finestra 6.6 - Replicazione del DNA del virus SV40 e proteine umane richieste in tale processo 165 – Sintesi di DNA translesione 168 6.6 Replicazione dei telomeri nei cromosomi lineari degli eucarioti 169 – Replicazione del DNA nella sua struttura cromatinica 172 6.7 Controllo della replicazione del DNA durante il ciclo cellulare 173 – Aspetti generali del ciclo cellulare 173 – Motore del ciclo cellulare 175 – Meccanismi molecolari che assicurano che la replicazione del DNA possa avvenire una volta sola ogni ciclo cellulare 177 6.8 Alterazioni nei meccanismi di replicazione possono provocare cambiamenti quantitativi di sequenze di DNA nel genoma 179 – Amplificazione genica 180 – Politenizzazione 180 – Diminuzione genica, cromatinica e cromosomica 182 – Micro- e macronucleo dei protozoi ciliati 182 ■ Letture di approfondimento 183 CAP. 7 - Riparazione del DNA 184 7.1 Mutazioni 184 7.2 Sistemi di riparazione del DNA 187 Finestra 7.1 - I meccanismi di riparazione sono funzionalmente conservati in tutti gli organismi viventi, dai procarioti agli eucarioti 188 – Riparazione per escissione delle basi (BER) 190 – Riparazione per escissione di nucleotidi (NER) 192 – Riparazione di errori replicativi (MMR) 195 – Meccanismi di tolleranza al danno (PRR) 195 – Riparazione di rotture su entrambi i filamenti del DNA 197 7.3 Risposta cellulare a danni sul DNA e connessioni tra riparazione e ciclo cellulare 200 ■ Letture di approfondimento 203 CAP. 8 - Ricombinazione 204 8.1 Introduzione e ricombinazione in meiosi 204 8.2 Ricombinazione omologa o generalizzata 205 Finestra 8.1 - Conversione genica 208 – Ricombinazione sito-specifica 209 Finestra 8.2 - Proprietà e ciclo virale del fago lambda 210 8.3 Trasposizione 212 Finestra 8.3 - I retrovirus 214 8.4 Riarrangiamenti di sequenze di DNA e controllo dell’espressione genica 218 – Cambiamento della specificità d’ospite nel fago Mu 218 – Variazione di fase in Salmonella 219 – Cambiamento del tipo sessuale in lievito (locus MAT) 220 – Variazione antigenica in Trypanosoma (geni VSG) 223 – Ricombinazione V(D)J dei geni per le immunoglobuline nei vertebrati 224 ■ Letture di approfondimento 227 D - TRASCRIZIONE E SUE REGOLAZIONI CAP. 9 - Trascrizione nei procarioti 231 9.1 Unità di trascrizione 232 9.2 Le tre fasi della trascrizione 233 9.3 Struttura delle RNA polimerasi 236 9.4 Inizio della trascrizione nei procarioti 238 – Promotori e fattore sigma 240 – Diversi fattori sigma controllano promotori diversi 241 Finestra 9.1 - Interazioni del fattore e dei suoi domini con l’RNA polimerasi e con il promotore 242 9.5 Distacco dell’RNA polimerasi dal promotore e allungamento dell’RNA 244 – Topologia e trascrizione 245 9.6 Terminazione della trascrizione nei procarioti 246 – Terminatori intrinseci 246 – Terminatori Rho-dipendenti 248 ■ Letture di approfondimento 250 CAP. 10 - Regolazione della trascrizione nei procarioti 251 10.1 Elementi di controllo nella trascrizione dei procarioti 251 – Attivatori trascrizionali, repressori e operatori 251 – Organizzazione degli operoni procariotici 252 10.2 Operone lac 253 – Controllo negativo dell’operone lac 253 Finestra 10.1 - Gli esperimenti di Jacob e Monod 254 – Repressore Lac e sue interazioni con il promotore 258 – Controllo positivo dell’operone lac e ruolo di CAP 260 – Interazione della regione promotore/operatore con CAP, repressore Lac e RNA polimerasi 264 10.3 Operone del triptofano 265 Finestra 10.2 - Operoni inducibili e reprimibili, controlli negativi e controlli positivi 266 – Regolazioni a livello di terminazione della trascrizione 268 10.4 Controllo dell’espressione genica nel fago lambda 269 – I due cicli vitali del fago lambda: ciclo litico e ciclo lisogenico 271 – Ciclo litico 273 – Ciclo lisogenico 275 – Regione di controllo del fago 275 – Struttura del repressore e di Cro 276 – CI e Cro si legano con diversa affinità alla regione di controllo 278 – Il repressore CI e Cro controllano in modo mutuamente esclusivo la trascrizione nella regione di controllo del fago lambda 279 – Legame cooperativo del repressore al DNA 280 – Induzione del ciclo litico di lambda in un batterio lisogenico 282 – Ruolo dell’attivatore trascrizionale CII 283 Finestra 10.3 - Identificazione di mutazioni nella regione di controllo 283 – Controllo dell’integrazione e dell’escissione del fago nel cromosoma di Escherichia coli 285 ■ Letture di approfondimento 287 CAP. 11 - Trascrizione e regolazione negli eucarioti 288 11.1 Tre sistemi di trascrizione nel nucleo 289 11.2 Promotore dei geni per gli rRNA e fattori che regolano la trascrizione dell’RNA polimerasi I 291 11.3 RNA polimerasi III: promotori di Pol III interni ed esterni e suoi fattori di trascrizione 294 11.4 RNA polimerasi II: struttura del promotore minimo di Pol II 294 – Fattori basali di Pol II e assemblaggio del complesso d’inizio 297 – Ruolo del “mediatore” nella trascrizione di Pol II 299 Finestra 11.1 - Il “mediatore” e la sua scoperta 301 – Struttura di Pol II e reazione di allungamento nella sintesi dell’RNA 302 11.5 Regolazione 304 – Struttura modulare dei promotori eucariotici 304 11.6 Struttura modulare e domini dei fattori di trascrizione (transattivatori) 309 11.7 Domini funzionali dei transattivatori: domini di legame al DNA 311 – Elica-giro-elica (helix-turn-helix) e omeodominio 312 – Dominio a dita di zinco (zinc finger) 313 – Domini a cerniere di leucina (leucine zipper) 314 – Dominio elica-ansa-elica (helix-loop-helix) 315 – Controllo combinatoriale della trascrizione 316 – Reclutamento del complesso di trascrizione 319 – Attivatori e cromatina 319 Finestra 11.2 - I fattori di trascrizione agiscono attraverso una vasta rete di interazioni 320 – Attivazione e segnali 323 – Recettori degli ormoni steroidei 323 – Risposta all’AMP ciclico e fattore CREB 323 – Fattore trascrizionale NF-kB 324 ■ Letture di approfondimento 325 E - PROCESSAMENTO E MATURAZIONE DELL’RNA CAP. - 12 - Maturazione dell’RNA: tagli nucleolitici e modificazioni chimiche 329 12.1 Processamento degli rRNA nei procarioti e negli eucarioti 329 Finestra 12.1 - Le nucleasi 330 12.2 Processamento dei tRNA nei procarioti e negli eucarioti 332 12.3 Ribozimi autocatalitici a “testa di martello” 333 12.4 Modificazioni chimiche delle basi e del ribosio 335 – Modificazioni chimiche delle basi nei tRNA procarioti ed eucarioti 336 – Modificazioni chimiche degli rRNA eucariotici 336 Finestra 12.2 - Il nucleolo 337 12.5 Aggiunta del “cap” agli mRNA eucariotici 339 12.6 Poliadenilazione e terminazione della trascrizione degli mRNA eucariotici 342 – Funzioni della coda di poli(A) 345 – Turnover della coda di poli(A) 345 – Poliadenilazione nei procarioti e negli organelli 345 ■ Letture di approfondimento 346 CAP. - 13 - Splicing ed editing 347 13.1 Splicing 347 – Geni “discontinui” e splicing 347 – Meccanismo dello splicing nucleare 350 Finestra 13.1 - Splicing e patologie 356 – Autosplicing: introni di gruppo I e II 357 – Splicing del tRNA 359 – Trans-splicing 360 – Accoppiamento tra splicing e trascrizione 362 – Splicing alternativo 363 – Regolazione dello splicing 365 13.2 Editing 368 – Editing per conversione di basi 369 – Editing inserzionale 372 13.3 Traslocazione nucleo-citoplasmatica degli RNA 375 ■ Letture di approfondimento F - TRADUZIONE E SUE REGOLAZIONI CAP. 14 - Apparato di traduzione e suoi componenti 379 14.1 Ribosoma 379 – rRNA 381 – r-proteine 381 – Struttura tridimensionale 384 – Ribosoma come ribozima 388 14.2 RNA transfer (tRNA, RNA di trasferimento) e amminoacil-tRNA sintetasi 389 Finestra 14.1 - Quanti amminoacidi sono codificati dal codice genetico? 391 14.3 RNA messaggero (mRNA) 395 Finestra 14.2 - La coda di poli(A) come maniglia per purificare l’mRNA 396 ■ Letture di approfondimento 397 CAP. 15 - Meccanismo della sintesi proteica 398 15.1 Inizio nei procarioti 400 – tRNA di inizio 400 – Riconoscimento del sito di inizio sull’mRNA 401 – Fattori di inizio nei procarioti 402 – Processo di inizio della traduzione nei procarioti 403 15.2 Inizio negli eucarioti 404 – Fattori di inizio negli eucarioti 405 – Processo di inizio della traduzione negli eucarioti 406 – Meccanismo di inizio alternativo cap-indipendente negli eucarioti 410 15.3 Allungamento 410 Finestra 15.1 - Mimetismo molecolare dei fattori che interagiscono con il sito a del ribosoma 415 15.4 Terminazione 416 15.5 Bilancio energetico 416 Finestra 15.2 - Sistemi di sintesi proteica in vitro 418 15.6 Velocità e accuratezza della sintesi proteica 418 15.7 Traduzione a livello strutturale 419 Finestra 15.3 - Inibitori della sintesi proteica e antibiotici 420 ■ Letture di approfondimento 422 CAP. 16 - Regolazione della traduzione 423 16.1 Regolazione generale della traduzione 423 – “Risposta stringente” nei procarioti 423 – Controllo generale della traduzione negli eucarioti 424 16.2 Regolazioni traduzionali di geni specifici 425 – Controlli traduzionali autogeni 426 – Controlli traduzionali non autogeni 428 16.3 Regolazione della stabilità e degradazione degli mRNA 432 – Degradazione dell’mRNA nei procarioti 432 – Degradazione dell’mRNA nelle cellule eucariotiche 432 – Meccanismi di “controllo qualità” dell’mRNA 435 Finestra 16.1 - Patologie dell’apparato di traduzione 439 16.4 Trasporto e localizzazione degli mRNA 440 – Localizzazione dell’mRNA di ASh1 in lievito 440 – Localizzazione di mRNA nell’uovo di Drosophila 442 – Localizzazione di mRNA nei dendriti neuronali 443 16.5 Granuli citoplasmatici di RNA 444 ■ Letture di approfondimento 445 G - ALTRI LIVELLI DI REGOLAZIONE: REGOLAZIONI EPIGENETIChE E POST-TRADUZIONALI, RUOLI DI RNA NON CODIFICANTI (ncRNA) CAP. 17 - Regolazioni epigenetiche: metilazione del DNA e rimodellamento della cromatina 449 17.1 Metilazione del DNA ed espressione genica 449 Finestra 17.1 - Epigenesi, epigenetica e regolazioni epigenetiche 450 – Metilazione del DNA genomico nei mammiferi 450 Finestra 17.2 - Identificazione delle CpG metilate nel DNA genomico 451 – Isole CpG 452 – Metilazione delle CpG e trascrizione 454 – Imprinting genetico 454 Finestra 17.3 - Regolazioni epigenetiche e patologia 456 17.2 Rimodellamento della cromatina 456 – Modificazioni post-traduzionali degli istoni 457 – Complessi di rimodellamento (rimodellatori) ATP-dipendenti 458 – Sostituzione di varianti istoniche 460 ■ Letture di approfondimento 460 CAPITOLO 18 Ruoli regolativi dei ncRNA e l’ipotesi del mondo a RNA 461 18.1 RNA regolatori nei procarioti 462 – sRNA 462 – Riboswitch 463 18.2 RNA regolatori negli eucarioti 464 – MicroRNA 464 – Lunghi RNA non codificanti (lncRNA) 468 18.3 Il mondo a RNA e l’origine della vita sulla Terra 471 ■ Letture di approfondimento 474 CAP. 19 - Modificazioni e regolazioni post-traduzionali di proteine 475 19.1 Stabilità e processamento di proteine 476 19.2 Ubiquitinazione di proteine 478 19.3 Sumoilazione di proteine 481 19.4 Fosforilazione e defosforilazione di proteine 483 19.5 Acetilazione di proteine 488 19.6 Metilazione di proteine 489 19.7 Glicosilazione e modificazioni lipidiche di proteine 490 ■ Letture di approfondimento 493 H - APPROCCI, TECNIChE E MODELLI IN BIOLOGIA MOLECOLARE CAP. 20 -Tecniche della Biologia Molecolare 497 20.1 Tecniche spettrofotometriche per l’analisi della denaturazione e riassociazione del DNA 497 – Spettro di assorbimento 497 – Denaturazione del DNA, Tm 498 – Riassociazione del DNA, cinetica di riassociazione, Cot 499 20.2 Uso di sonde di DNA per l’identificazione e analisi di sequenze nucleotidiche 502 Finestra 20.1 - Marcatura del DNA con atomi radioattivi 503 – Ibridazione a saturazione 503 – Ibridazione in situ o citologica 503 – Southern e Northern blot 504 – Ibridazione su colonia o su placca 505 20.3 Ultracentrifugazione 506 – Sedimentazione in gradienti di saccarosio 507 – Gradienti di densità di cloruro di cesio (CsCl) 510 Finestra 20.2 - Ultracentrifuga analitica 512 20.4 Tecnologie di base per l’isolamento e la manipolazione di geni 512 Finestra 20.3 - Utilizzo dell’elettroforesi per separare molecole di acidi nucleici e proteine 514 – Enzimi di restrizione e DNA ligasi 516 – Vettori di clonaggio 519 – Plasmidi 519 – Trasformazione di cellule di Escherichia coli e selezione dei trasformanti 521 – Plasmidi della serie pUC: selezione bianco o blu 522 – Vettori di espressione e produzione di proteine ricombinanti 522 – Batteriofago lambda come vettore di clonaggio 528 – Cosmidi 529 – Vettori per il clonaggio e l’espressione in cellule eucariotiche 529 – Vettori di lievito 531 – Vettori per il trasferimento genetico in cellule animali 534 – Trasferimento di DNA nei vegetali 535 20.5 Banche di DNA 536 – Banche genomiche 536 – Rappresentatività di una libreria di DNA genomico 538 – Librerie di cDNA 539 – Identificazione del clone contenente il DNA d’interesse da una libreria 541 20.6 PCR: reazione a catena della polimerasi 547 20.7 Determinazione della sequenza nucleotidica del DNA 550 20.8 Piattaforme di sequenziamento di nuova generazione 554 20.9 Metodologie recenti per la modificazione mirata dei genomi (“genome editing”) 565 Finestra 20.4 - Il northern blot e il western blot 566 – Zinc-Finger e TALE nucleasi (ZFN e TALEN) 567 – Il sistema CRISPR/Cas9 568 20.10 Valutazione dell’espressione di un gene 569 20.11 Inibizione dell’espressione di geni specifici: RNA antisenso e interferenza da RNA 571 Finestra 20.5 - Mutagenesi sito-specifica o mutagenesi mirata 572 20.12 Interazioni tra macromolecole biologiche 574 – Interazioni proteina-DNA 574 – Interazioni proteina-proteina 581 ■ Letture di approfondimento 588 – Microarray (o microchip) 505 CAP. 21 - Bioinformatica e Genomica 589 21.1 Sequenziamento e assemblaggio di genomi completi 589 21.2 Sequenziamento del trascrittoma 593 21.3 Identificazione e annotazione di geni 597 21.4 Confronto e allineamento di sequenze 598 21.5 Identificazione e annotazione di regioni regolatorie e caratterizzazione delle proprietà epigenetiche della cromatina 600 Finestra 21.1 - Rappresentazione di motivi regolativi mediante il sequence logo 602 21.6 Annotazione delle sequenze proteiche 603 21.7 Banche dati e browser genomici 604 21.8 Evoluzione molecolare 605 ■ Indirizzi web delle principali risorse bioinformatiche 607 Cap. 22 - Organismi modello 608 22.1 Il lievito Saccharomyces cerevisiae 610 22.2 Il moscerino della frutta Drosophila melanogaster 616 22.3 Il nematode Caenorhabditis elegans 620 22.4 L’anfibio Xenopus laevis e il suo successore Xenopus tropicalis 622 22.5 Il pesce Danio rerio o “zebrafish” 625 22.6 Il topo comune Mus musculus 628 22.7 La pianta Arabidopsis thaliana 634 ■ Letture di approfondimento 635 Indice analitico 637 Risorse online: appendice a I sistemi modello vegetali |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
