Biologia delle piante Vol. 1 - Evoluzione Sviluppo Metabolismo
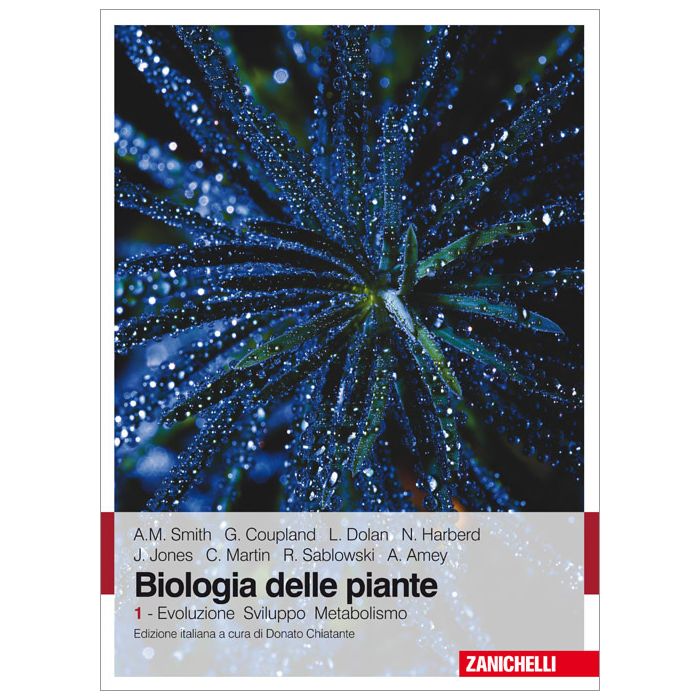
- ISBN/EAN
- 9788808061836
- Editore
- Zanichelli
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2011
- Edizione
- 1
- Pagine
- 400
Disponibile
50,10 €
Biologia delle piante attribuisce il giusto riconoscimento alla straordinaria storia di questa disciplina e, allo stesso tempo, adotta un approccio influenzato fortemente dalla prospettiva emersa negli ultimi vent’anni.
Infatti la crescita, lo sviluppo, il metabolismo delle piante sono stati considerati in un primo tempo solo a livello biochimico, cellulare e di intero organismo.
Agli inizi degli anni Ottanta è sopraggiunta la prima di due ondate di cambiamenti che hanno modificato radicalmente il modo stesso di pensare la biologia vegetale: si è capito che la genetica molecolare poteva essere utilizzata come strumento per comprendere alcuni aspetti biologici in precedenza esclusi dal campo di indagine della genetica vegetale. Le funzioni biologiche cominciarono perciò a essere analizzate studiando le caratteristiche di piante portatrici di geni mutanti, che ne alteravano i normali processi metabolici.
La seconda è stata la cosiddetta «ondata del genoma» alla fine del 1999, quando venne pubblicata la prima
sequenza completa del DNA di un genoma vegetale.
Il libro inizia con una sintesi sull’origine delle piante attuali: su come si pensa che i loro progenitori possano essere stati delle specie acquatiche di tipo algale; sulla conquista della terraferma; e su come le angiosperme siano riuscite a dominare la vegetazione terrestre. Vengono poi prese in esame le caratteristiche principali dei genomi vegetali e viene fornita una panoramica aggiornata della biologia cellulare, del metabolismo e dello sviluppo delle piante.
Nel secondo volume di Biologia delle piante vengono invece trattate le risposte degli organismi vegetali ai fattori ambientali, le interazioni con batteri, virus e altri organismi e la domesticazione a fini agricoli.
Maggiori Informazioni
| Autore | Smith Alison M.; Coupland George; Dolan Liam; Harberd Nicholas; Jones Jonathan; Martin Cathie; Sablowski Robert; Amey A. |
|---|---|
| Editore | Zanichelli |
| Anno | 2011 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | CAPITOLO 1 • Le origini 1 1.1 • TERRA, CELLULE E FOTOSINTESI 2 La Terra si formò 4,6 miliardi di anni fa 2 La fotosintesi è comparsa approssimativamente 3,5 miliardi di anni fa 3 La fotosintesi ossigenica si diffuse circa 2,2 miliardi di anni fa 4 La fotosintesi dei cianobatteri ha prodotto un’atmosfera ricca di ossigeno 5 La vita primordiale sul pianeta si è evoluta in assenza di uno strato protettivo di ozono atmosferico 5 1.2 • LE CELLULE EUCARIOTICHE 6 Le cellule eucariotiche fotosintetiche si sono formate mediante due eventi endosimbiontici 6 Dall’evento endosimbiontico che diede origine ai plastidi sono derivati molti gruppi di organismi fotosintetici 7 Le evidenze fossili indicano che gli organismi eucariotici si sono evoluti circa 2,7 miliardi di anni fa e gli organismi pluricellulari circa 1,2 miliardi di anni fa 8 Gli animali e le alghe si sono differenziati nel periodo Cambriano inferiore 9 1.3 • LE PIANTE TERRESTRI 9 Le piante verdi sono monofiletiche 10 Le piante terrestri potrebbero essersi evolute da alghe appartenenti alla classe delle caroficee (carofite) 10 I microfossili indicano che le prime piante terrestri sono apparse nel periodo Ordoviciano medio, circa 475 milioni di anni fa 11 Box 1.1 • Che cosa può rivelarci il DNA riguardo alla filogenesi e all’evoluzione 11 La diversità vegetale è cresciuta durante i periodi Siluriano e Devoniano 12 Il numero di sporangi distingue le prime piante terrestri dalle loro discendenti 13 L’incremento nelle dimensioni delle piante è stato accompagnato dall’evoluzione di un sistema vascolare 14 Alcune delle prime piante vascolari erano imparentate con le attuali licofite 15 Gli equiseti, le felci e le piante a seme derivano da un gruppo di piante prive di foglie sviluppatosi nel Devoniano inferiore, circa 400 milioni di anni fa 16 Le felci e gli equiseti si sono evoluti nel periodo Devoniano 18 L’aumento della complessità chimica e cellulare è un fenomeno precoce nell’evoluzione delle piante terrestri 18 I livelli di CO2 e di O2 nell’atmosfera sono determinati dai tassi di fotosintesi e di immagazzinamento del carbonio 19 L’evoluzione delle piante terrestri fu almeno in parte responsabile della diminuzione nel livello di CO2 atmosferica, che ebbe inizio 450 milioni di anni fa 21 La diminuzione del livello di CO2 atmosferica nel Paleozoico medio ha favorito l’evoluzione di foglie con grandi dimensioni 22 1.4 • LE PIANTE A SEME (SPERMATOFITE) 23 I semi contengono i prodotti genetici della fecondazione protetti da un tessuto derivato dallo sporofito 23 Le piante a seme si sono evolute nel Devoniano e si sono diversificate nel Permiano in un periodo compreso tra 290 e 250 milioni di anni fa 24 La generazione sporofitica divenne dominante nel ciclo vitale delle piante terrestri durante il periodo Devoniano 24 Cinque gruppi di piante a seme vivono attualmente sulla Terra 27 1.5 • LE ANGIOSPERME 28 Le angiosperme compaiono nei resti fossili del periodo Cretacico inferiore, circa 135 milioni di anni fa 28 Le angiosperme si sono evolute nelle zone tropicali e poi si sono diffuse a latitudini più elevate 28 Amborella trichopoda è sorella di tutte le angiosperme viventi 29 Le eudicotiledoni si distinguono dalle altre piante con fiore in base al numero delle aperture del polline 31 I primi fiori delle angiosperme erano piccoli e composti da molte parti 31 Le monocotiledoni sono un gruppo monofiletico 31 La famiglia delle poacee (graminacee) è comparsa circa 60 milioni di anni fa ma si è diversificata più recentemente 32 Riassunto 35 Letture consigliate 35 CAPITOLO 2 • I genomi 36 2.1 • IL GENOMA NUCLEARE: I CROMOSOMI 37 2.2 • IL DNA CROMOSOMICO 37 Sequenze specializzate di DNA ripetitivo si trovano nei centromeri e nei telomeri 37 I geni nucleari sono trascritti in diversi tipi di RNA 39 I cromosomi vegetali contengono molti elementi genetici mobili, i trasposoni 41 2.3 • LA REGOLAZIONE DEI GENI NUCLEARI 42 Le sequenze regolatrici e i fattori di trascrizione controllano dove e quando un gene è trascritto 43 Box 2.1 • Fattori di trascrizione: controllo combinatorio 44 L’attività genica può essere regolata da cambiamenti chimici che avvengono nel DNA e nelle proteine della cromatina 46 La modificazione della cromatina viene ereditata tramite la divisione cellulare 49 La funzione genica è controllata anche a livello dell’RNA 50 Piccoli RNA di regolazione controllano la funzione degli mRNA 51 I piccoli RNA possono dirigere la modificazione della cromatina a livello di specifiche sequenze 52 2.4 • SEQUENZE GENOMICHE 53 Il genoma di Arabidopsis è stato il primo genoma vegetale a essere interamente sequenziato 53 Le sequenze genomiche sono analizzate al fine di identificare singoli geni 54 Il sequenziamento del genoma di Arabidopsis ha rivelato la presenza sia di un livello di complessità simile a quello dei genomi animali, sia di un’elevata proporzione di geni specifici delle piante 55 L’analisi comparativa dei genomi vegetali rivela sia caratteristiche conservate sia divergenti 57 La maggioranza delle angiosperme ha subito la duplicazione del genoma nel corso dell’evoluzione 57 I geni possono acquisire nuove funzioni mediante la duplicazione e la divergenza 58 L’ordine dei geni è conservato nelle specie vegetali strettamente imparentate 61 2.5 • GENOMI E BIOTECNOLOGIE 62 I geni mutati possono essere localizzati sul genoma mediante la cosegregazione con marcatori noti 62 I geni mutati in seguito all’inserzione di DNA possono essere isolati mediante l’individuazione della sequenza inserita 63 Si possono individuare mutazioni analizzando i geni a livello del DNA, indipendentemente dal fenotipo 64 L’interferenza dell’RNA è un metodo alternativo per eliminare la funzione di un gene 65 L’ereditarietà multigenica è analizzata mediante la mappatura dei “loci dei tratti quantitativi” (QTL) 65 Il sequenziamento genomico consente lo sviluppo di metodi per studiare simultaneamente le attività di molti geni 66 2.6 • I GENOMI CITOPLASMATICI 67 I plastidi e i mitocondri si sono evoluti da batteri inglobati da altre cellule 67 I geni degli organuli non seguono le leggi dell’ereditarietà di Mendel 68 I genomi dei plastidi e dei mitocondri si sono ridotti nel corso dell’evoluzione 69 La maggioranza dei polipeptidi organulari è codificata dal genoma nucleare e indirizzata poi agli organuli 69 La replicazione e la ricombinazione del DNA plastidiale non sono strettamente accoppiate con la divisione cellulare 69 L’espressione genica ha caratteristiche comuni nei plastidi e negli eubatteri 70 I plastidi contengono due distinte RNA polimerasi 70 I processi post-trascrizionali sono importanti per la regolazione dell’espressione dei geni plastidiali 71 I trascritti degli organuli sono soggetti a processi di “editing dell’RNA” 72 I processi post-trascrizionali contribuiscono al mantenimento del corretto rapporto tra componenti codificate dal nucleo e dal plastidio nei complessi composti da più subunità 72 Durante lo sviluppo, la regolazione dell’espressione dei geni plastidiali comprende scambi di segnali tra plastidi e nucleo 73 Riassunto 74 Letture consigliate 74 CAPITOLO 3 • Le cellule 76 3.1 • IL CICLO CELLULARE 77 Box 3.1 • Il nucleo 78 La transizione da una fase del ciclo cellulare alla successiva è controllata da un complesso insieme di meccanismi 79 Il ciclo cellulare nelle piante è controllato da segnali derivanti dalle fasi dello sviluppo e dai fattori ambientali 81 Molte delle cellule che si differenziano vanno incontro a endoreduplicazione, cioè replicazione del DNA senza la conseguente divisione del nucleo e della cellula 82 3.2 • LA DIVISIONE CELLULARE 84 Il citoscheletro muove le componenti cellulari durante la divisione cellulare 84 Una banda preprofasica si genera nel sito in cui si formerà la futura parete cellulare 85 Box 3.2 • Il citoscheletro 86 Le coppie di cromosomi replicati vengono separate dal fuso di microtubuli 87 I microtubuli determinano la formazione del fragmoplasto il quale dirige la deposizione della nuova parete cellulare 89 Le vescicole trasportano i materiali dall’apparato del Golgi fino al sito di costruzione della nuova parete 90 La meiosi è un tipo specializzato di divisione cellulare che dà origine a cellule aploidi e alla variabilità genetica 92 3.3 • GLI ORGANULI 95 I plastidi e i mitocondri si replicano indipendentemente dalla divisione cellulare 96 La biogenesi dei plastidi e dei mitocondri implica l’importazione post-traduzionale di molte proteine 97 Il sistema di endomembrane trasporta le proteine alla superficie della cellula e ai vacuoli 101 Gli organuli si spostano entro la cellula lungo filamenti di actina 104 3.4 • LA PARETE CELLULARE PRIMARIA 105 La matrice della parete cellulare è costituita da pectine e da emicellulose 105 La cellulosa è sintetizzata sulla superficie della cellula dopo la formazione della piastra cellulare 107 I carboidrati che formano la parete cellulare interagiscono in modo da formare una struttura resistente e flessibile 108 Le glicoproteine e gli enzimi svolgono importanti funzioni nella parete cellulare 110 I plasmodesmi formano canali tra le cellule 110 3.5 • DISTENSIONE E FORMA DELLA CELLULA 113 Le proprietà della membrana plasmatica determinano la composizione della cellula e mediano la sua interazione con l’ambiente 113 Il trasporto protonico attraverso la membrana plasmatica genera i gradienti elettrici e protonici che sostengono gli altri processi di trasporto 113 Il movimento dell’acqua attraverso la membrana plasmatica è facilitato dalle acquaporine 115 Il movimento di soluti verso il vacuolo cellulare guida l’espansione della cellula 116 Il vacuolo funziona come compartimento di accumulo e sequestro di sostanze 118 Il trasporto di ioni e il movimento dell’acqua regolano in modo coordinato l’apertura degli stomi 119 La direzione della distensione cellulare è determinata dai microtubuli presenti nella corteccia cellulare 121 Durante la distensione cellulare, i filamenti di actina indirizzano il nuovo materiale verso la superficie della cellula 123 Nei peli radicali e nei tubetti pollinici, il processo di distensione cellulare è localizzato solo all’apice della cellula 124 3.6 • PARETE SECONDARIA E CUTICOLA 125 La struttura e le componenti della parete secondaria variano da un tipo di cellula all’altro 126 La lignina è la componente principale di molte pareti secondarie 126 La lignificazione è una caratteristica identificativa delle trachee e delle tracheidi 130 Il legno è formato dalla crescita secondaria dei tessuti vascolari 131 La cuticola forma una barriera idrofobica sulle parti aeree della pianta 132 Riassunto 133 Letture consigliate 134 CAPITOLO 4 • I tessuti 136 4.1 • I TESSUTI MERISTEMATICI 136 Le cellule meristematiche si possono distinguere in iniziali, derivate, e determinate 140 Solo la presenza di cellule iniziali assicura la crescita indefinita 142 La velocità di divisione delle cellule meristematiche iniziali è considerevolmente più bassa di quella di tutti gli altri tipi di cellule meristematiche 142 4.2 • I TESSUTI PARENCHIMATICI 143 Il parenchima di fotosintesi 143 Il parenchima di secrezione 145 I parenchimi aeriferi 145 Il parenchima di trasporto 146 Il parenchima di riserva 146 4.3 • I TESSUTI TEGUMENTALI 148 L’epidermide è un tessuto tegumentale di intermediazione tra i tessuti interni della pianta e i fattori ambientali 148 Le cellule ordinarie dell’epidermide sono responsabili della funzione di copertura delle parti aeree del corpo primario della pianta 149 Tra le cellule ordinarie si ritrovano altre cellule che conferiscono all’epidermide funzioni speciali 150 Il rizoderma è il tessuto tegumentale che ricopre il corpo primario della radice e si distingue dall’epidermide del fusto e delle foglie per la forma e la funzione delle sue cellule 154 L’endoderma seleziona i sali assorbiti dal rizoderma prima della loro immissione nei tessuti di conduzione della stele centrale 155 L’esoderma sostituisce il rizoderma a una certa distanza dall’apice radicale e determina il blocco dell’assorbimento di acqua e soluti dal suolo 156 Il periderma è responsabile della produzione del sughero e rappresenta il tessuto tegumentale che assicura una migliore protezione del corpo della pianta dai fattori ambientali 157 4.4 • I TESSUTI DI CONDUZIONE 160 Xilema: proprietà e formazione degli elementi di conduzione 160 Le tracheidi e le trachee sono i principali elementi di conduzione dello xilema e presentano ispessimenti di parete secondaria lignificati 162 Elementi di conduzione con punteggiature semplici e areolate 164 Successione di tipologie di ispessimenti in funzione dello stato di differenziamento dei tessuti circostanti 164 Contatto tra elementi di conduzione e altri elementi dello xilema 165 Floema: proprietà e formazione degli elementi di conduzione 165 Box 4.1 • Geni che controllano lo sviluppo del fascio di conduzione in Arabidopsis 166 Le cellule cribrose e i tubi cribrosi sono i principali elementi di conduzione del floema e presentano differenze morfologiche 167 Il trasporto di sostanze e lo sviluppo delle cellule e dei tubi cribrosi 168 Cellule associate agli elementi di conduzione che contribuiscono al trasporto floematico 168 4.5 • I TESSUTI MECCANICI 169 Il collenchima: un tessuto meccanico dotato di grande plasticità 169 La funzione meccanica delle cellule del collenchima deriva, oltre che dall’architettura, anche dalla composizione chimica della parete 170 Esempi di rinforzo meccanico dovuto alla presenza di collenchima 171 Sclerenchima: un tessuto meccanico dotato di grande elasticità e forte resistenza 172 La composizione chimica e la struttura della parete secondaria è responsabile delle proprietà meccaniche delle cellule sclerenchimatiche 173 Distinzione tra due differenti elementi che costituiscono il tessuto sclerenchimatico: le fibre e le sclereidi 174 4.6 • I TESSUTI SECRETORI 175 Gli idioblasti secretori sono presenti in diverse parti del corpo di una pianta e accumulano sostanze complesse che a volte sono di difficile identificazione e di funzione ignota 175 Le tasche e i canali secretori si differenziano per forma, dimensione e sostanze prodotte 176 I laticiferi sono composti da singole cellule o gruppi di cellule; in questo ultimo caso le diverse cellule si possono fondere o rimanere separate 176 Riassunto 177 Letture consigliate 177 CAPITOLO 5 • Il metabolismo 178 5.1 • IL CONTROLLO DELLE VIE METABOLICHE 179 La compartimentazione accresce il potenziale di diversità metabolica 179 I processi metabolici sono coordinati e controllati mediante la regolazione delle attività enzimatiche 180 5.2 • L’ASSIMILAZIONE DEL CARBONIO: LA FOTOSINTESI 182 L’assimilazione netta di carbonio avviene nel ciclo di Calvin 183 L’energia per l’assimilazione del carbonio deriva dai processi di cattura della luce che hanno luogo sui tilacoidi del cloroplasto 184 L’energia luminosa è catturata dalle molecole di clorofilla ed è trasferita ai centri di reazione 186 Il trasferimento di elettroni tra due centri di reazione mediante una catena di trasporto degli elettroni riduce il NADP+, e genera un gradiente protonico attraverso la membrana del tilacoide 186 Box 5.1 • La luce 187 Il gradiente di protoni sostiene la sintesi di ATP a opera di un complesso di ATP sintasi 191 I processi di raccolta della luce sono regolati in modo da rendere massima la dissipazione dell’energia di eccitazione in eccesso 192 L’assimilazione del carbonio e il rifornimento energetico sono coordinati mediante la complessa regolazione degli enzimi del ciclo di Calvin 194 La sintesi di saccarosio è strettamente controllata dalla velocità di fotosintesi e dalla richiesta di carbonio proveniente dalle parti della pianta che non effettuano la fotosintesi 196 La sintesi di amido permette alla velocità di fotosintesi di rimanere a livelli alti quando la sintesi di saccarosio è limitata 199 5.3 • LA FOTORESPIRAZIONE 200 La Rubisco può usare come substrato l’ossigeno anziché l’anidride carbonica 200 Il metabolismo della fotorespirazione ha implicazioni sull’economia del carbonio e dell’azoto della foglia 203 Le piante C4 eliminano la fotorespirazione mediante un meccanismo che concentra l’anidride carbonica 204 5.4 • IL TRASPORTO DEL SACCAROSIO 210 Il saccarosio si muove attraverso il floema verso le parti non fotosintetiche della pianta 210 Il caricamento del floema può essere di tipo apoplastico o simplastico 211 Il rifornimento di assimilati dalla foglia è coordinato con la domanda proveniente dalle altre parti della pianta 215 5.5 • LA GENERAZIONE NON FOTOSINTETICA DI ENERGIA E PRECURSORI 216 L’interconversione del saccarosio e degli esoso fosfati consente una regolazione fine del metabolismo del saccarosio 217 La glicolisi e la via ossidativa dei pentoso fosfati generano potere riducente, ATP e precursori per le vie metaboliche di biosintesi 218 Il ciclo di Krebs e le catene di trasporto degli elettroni nei mitocondri sono la principale fonte di ATP per le cellule che non effettuano la fotosintesi 220 La ripartizione del saccarosio tra le vie dell’ossatura metabolica è estremamente flessibile ed è correlata alla funzione cellulare 226 5.6 • L’ACCUMULO DEL CARBONIO 227 Il saccarosio è accumulato nel vacuolo 228 Il granulo di amido è una struttura semicristallina sintetizzata da piccole famiglie di sintasi e di enzimi di ramificazione dell’amido 229 La via di degradazione dell’amido dipende dal tipo di organo della pianta 231 Alcune piante accumulano polimeri solubili di fruttosio anziché l’amido 233 I lipidi di riserva sono sintetizzati nel reticolo endoplasmatico a partire dagli acidi grassi 234 La composizione in acidi grassi dei lipidi di riserva varia tra le diverse specie 236 I triacilgliceroli sono convertiti a zuccheri mediante la β ossidazione e la gluconeogenesi 239 Gli zuccheri possono agire come segnali per determinare l’entità delle riserve di carbonio 240 5.7 • IL METABOLISMO DEI PLASTIDI 242 I plastidi scambiano specifici metaboliti con il citosol mediante l’azione dei trasportatori di metaboliti 242 Gli acidi grassi sono sintetizzati da un complesso enzimatico all’interno dei plastidi 244 La sintesi dei lipidi di membrana nei plastidi procede secondo una via “procariotica” differente dalla via “eucariotica” seguita nelle altre parti della cellula 246 Vie per la sintesi dei terpenoidi diverse nel plastidio e nel citosol danno origine a prodotti differenti 249 I tetrapirroli, cioè i precursori della clorofilla e del gruppo eme, sono sintetizzati nei plastidi 251 5.8 • L’ASSIMILAZIONE DELL’AZOTO 254 Le piante contengono vari tipi di trasportatori di nitrato, che sono regolati in risposta a segnali differenti 254 L’attività della nitrato reduttasi è regolata a molti livelli differenti 256 L’assimilazione dell’azoto negli amminoacidi è accoppiata alla domanda e alla disponibilità di nitrato, e alla disponibilità di precursori della biosintesi 257 La biosintesi degli amminoacidi è parzialmente regolata mediante un controllo a feedback (retroazione) 259 L’azoto è accumulato sotto forma di amminoacidi e di specifiche proteine di riserva 263 5.9 • L’ASSIMILAZIONE DI FOSFORO, ZOLFO E FERRO 266 La disponibilità di fosforo costituisce la principale limitazione per la crescita della pianta 268 Lo zolfo è assorbito come solfato, poi è ridotto a solfuro e viene assimilato nella cisteina 269 L’assorbimento del ferro richiede meccanismi specializzati per accrescere la solubilità del ferro nel suolo 272 5.10 • IL MOVIMENTO DELL’ACQUA E DEI MINERALI 273 L’acqua si muove dal suolo alle foglie, dove viene perduta per traspirazione 273 L’acqua si muove dalle radici alle foglie mediante un meccanismo idraulico 274 Il movimento dei nutrienti minerali nella pianta coinvolge sia il floema che lo xilema 276 Riassunto 278 Letture consigliate 279 CAPITOLO 6 • Lo sviluppo 280 6.1 • PANORAMICA DELLO SVILUPPO VEGETALE 280 La plucellularità si è evoluta in modo indipendente negli animali e nelle piante 282 L’alga Volvox rappresenta un sistema semplice utile per studiare le basi genetiche della pluricellularità 283 6.2 • LO SVILUPPO DELL’EMBRIONE E DEL SEME 284 Segnali esterni inducono la formazione dell’asse apicale-basale nell’embrione dell’alga Fucus 285 La parete cellulare determina il destino delle cellule dell’embrione di Fucus 286 Lo sviluppo dell’embrione nelle piante superiori avviene all’interno del seme 286 Il destino delle cellule embrionali è deciso dalla loro posizione 287 Box 6.1 • L’analisi clonale 288 La progressiva polarizzazione dei trasportatori dell’auxina media la formazione del polo basale dell’embrione 289 Il pattern di distribuzione radiale delle cellule nella radice embrionale e nell’ipocotile è definito dai fattori di trascrizione SCARECROW e SHORT ROOT 290 La posizione del meristema dell’apice radicale è determinata dalla combinazione dei segnali generati dai pattern apicale-basale e radiale 291 Il meristema dell’apice del fusto si stabilisce gradualmente e in modo indipendente dal meristema dell’apice della radice 292 L’endosperma e l’embrione si sviluppano parallelamente 292 La divisione delle cellule che daranno origine all’endosperma rimane bloccata fino alla fecondazione 294 Al termine dello sviluppo dell’embrione e dell’endosperma, normalmente i semi diventano dormienti 294 6.3 • LO SVILUPPO DELLA RADICE 296 Le radici delle piante si sono evolute in modo indipendente almeno due volte 296 Le radici sono caratterizzate da varie zone contenenti cellule che si trovano in stadi successivi di differenziamento 296 La radice di Arabidopsis ha una organizzazione cellulare molto semplice 297 Box 6.2 • Le cellule staminali nelle piante e negli animali 298 Il destino delle cellule dipende dalla posizione che occupano nella radice 298 L’analisi genetica conferma che la determinazione del tipo dipende dalla posizione della cellula 299 Lo sviluppo di radici laterali richiede l’intervento dell’auxina 300 L’organizzazione esterna della radice primaria 301 Suddivisione dell’organizzazione interna della radice in zone differenti 302 Organizzazione della zona dei meristemi primari e della cuffia 303 La zona di determinazione è la sede in cui viene deciso il destino delle cellule 305 Nella zona di differenziamento tutti i tessuti assumono la forma e la funzione definitive 305 La zona di struttura primaria presenta una organizzazione differente nelle monocotiledoni e nelle eudicotiledoni 306 Le radici possono essere modificate per svolgere funzioni diverse da quella dell’assorbimento 308 Nelle radici delle gimnosperme e delle angiosperme legnose la struttura primaria viene sostituita da una struttura secondaria, costruita dall’attività del cambio cribro-vascolare 309 Nella struttura secondaria, il rizoderma è sostituito da un periderma che impermeabilizza la radice ma consente l’uscita di nuove radici laterali 310 6.4 • LO SVILUPPO DEL FUSTO 310 Le cellule dell’apice meristematico del fusto sono organizzate in zone radiali e in strati concentrici 311 Il numero di nuove cellule meristematiche è costantemente bilanciato dal numero di cellule che vanno a formare nuovi organi 313 Le bozze fogliari emergono dai fianchi dell’apice meristematico del fusto secondo un pattern ripetitivo 315 Variazioni dell’espressione genica precedono la formazione della bozza fogliare 316 Lo sviluppo delle foglie composte è associato all’espressione di geni dei meristemi apicali durante le fasi iniziali dello sviluppo della foglia 317 La forma delle foglie deriva da divisioni cellulari organizzate, seguite da un periodo di distensione e differenziamento cellulare 317 Regioni diverse della bozza fogliare assumono destini differenti durante le prime fasi di sviluppo 318 Le differenze tra le due facce della foglia sono soggette a regolazione da parte di geni specifici 320 La crescita laterale necessita di un confine tra il lato dorsale e quello ventrale della foglia 320 La foglia raggiunge la forma e le dimensioni finali mediante processi regolati di divisione e distensione cellulare 321 La crescita della foglia è accompagnata dal contemporaneo sviluppo di un sistema di conduzione sempre più complesso, controllato dal trasporto dell’auxina 322 La comunicazione tra cellule e il preciso orientamento delle divisioni cellulari sono due fattori che controllano la localizzazione nella foglia di tipi cellulari specializzati 324 La senescenza fogliare è un processo attivo che recupera i nutrienti dalle foglie alla fine della loro vita funzionale 326 I rami sono formati da meristemi laterali la cui crescita è influenzata dal meristema apicale del fusto 327 La crescita degli internodi è dovuta alla divisione e alla distensione cellulare ed è controllata dalle gibberelline 328 La distanza tra internodi e nodi determina l’aspetto esterno che assumerà il fusto durante il suo sviluppo 330 L’organizzazione anatomica interna della struttura primaria del fusto è condizionata dalla posizione delle foglie e dei rami laterali 332 La disposizione dei fasci di conduzione nella struttura primaria del fusto nelle gimnosperme e nelle eudicotiledoni presenta considerevoli differenze rispetto a quella delle monocotiledoni 334 Uno strato di cellule meristematiche è responsabile della formazione dei tessuti di conduzione e provoca l’ispessimento secondario del fusto 336 La struttura secondaria del fusto delle eudicotiledoni legnose è differente da quella delle gimnosperme 339 Le differenze osservabili nella struttura secondaria del fusto e della radice potrebbero derivare dalle differenze esistenti nella loro struttura primaria 341 Box 6.3 • Le tappe evolutive della stele nelle prime piante vascolari: le felci 341 6.5 • DALLO SVILUPPO VEGETATIVO A QUELLO RIPRODUTTIVO 342 Nelle angiosperme le strutture riproduttive sono prodotte dai meristemi del fiore e dell’infiorescenza 342 Lo sviluppo dei meristemi fiorali è avviato da un gene regolatore conservato 343 Il pattern di espressione dei geni simili a LEAFY determina l’architettura dell’infiorescenza 343 I fiori presentano una considerevole variabilità nell’aspetto esteriore, tuttavia la loro struttura di base è regolata da geni altamente conservati 345 Nel modello ABC dell’identità dell’organo fiorale, ogni tipo di organo è determinato da una specifica combinazione di geni omeotici 346 I geni dell’identità degli organi fiorali sono conservati in tutte le angiosperme 348 La crescita asimmetrica degli organi fiorali dà origine a fiori con simmetria bilaterale 348 Altri geni regolatori controllano gli stadi tardivi dello sviluppo degli organi fiorali 349 6.6 • DALLO SPOROFITO AL GAMETOFITO 350 Il gametofito maschile è il granulo pollinico, costituito da una cellula vegetativa, dai gameti e da una spessa parete cellulare 350 Lo sviluppo del polline è favorito dai tessuti circostanti dello sporofito 352 Il gametofito femminile si sviluppa entro l’ovulo, che contiene i gameti necessari per i due eventi di fecondazione che danno origine allo zigote e all’endosperma 353 Lo sviluppo del gametofito femminile è coordinato con lo sviluppo dei tessuti sporofitici dell’ovulo 354 Un granulo pollinico germina sul pistillo e forma un tubetto che trasporta i nuclei spermatici verso l’ovulo 354 La crescita del tubetto pollinico è orientata da segnali a lungo raggio dei tessuti del pistillo, e da segnali a corto raggio prodotti dall’ovulo 355 Le piante sono provviste di un meccanismo che consente la crescita solo dei tubetti pollinici che portano geni specifici 355 L’autoincompatibilità può essere gametofitica o sporofitica, a seconda dell’origine della proteina del polline che viene riconosciuta 356 Dopo la fecondazione, i geni provenienti dal gamete maschile e da quello femminile non sono espressi in modo equivalente 358 Alcune piante possono formare semi in assenza di fecondazione 359 Riassunto 359 Letture consigliate 360 |
| Stato editoriale | In Commercio |
Questo libro è anche in:
