Aspetti normativi ed operativi delle sperimentazioni cliniche. Guida per le segreterie tecnico scientifiche dei Comitati Etici
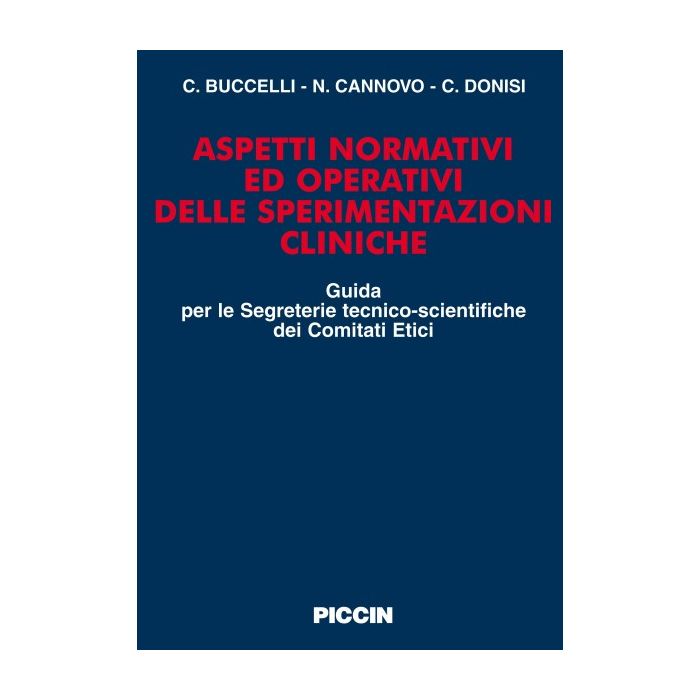
- ISBN/EAN
- 9788829920808
- Editore
- Piccin Editore
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2011
- Pagine
- 220
Disponibile
20,00 €
In base al Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 (“Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al Comitato Etico”, d’ora in poi “D.M. CTA”) le procedure operative per l’inoltro ai Comitati Etici (d’ora in poi “CE”) della documentazione per la valutazione di un protocollo sperimentale hanno subito delle variazioni.
Poiché il ruolo della Segreteria tecnico-scientifica (d’ora in poi “Segreteria”) è divenuto preminente, si è avvertita la necessità, anche sulla base dell’esperienza maturata nel funzionamento del CE dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di approntare la seguente guida che descrive in modo sintetico quanto è indispensabile per gestire in modo corretto gli adempimenti amministrativi previsti per legge. Già con il Decreto Ministeriale 18 marzo 1998 (“Linee guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei CE”) si prescriveva, all’art.2, comma 5, l’istituzione “dell’ufficio di Segreteria del Comitato (…) dotato di risorse informatiche per la ricerca bibliografica e, per quanto possibile, per l’archiviazione degli atti”. Inoltre, nel successivo art. 4, comma 1, si disponeva che il CE adottasse un regolamento diretto a disciplinare “tutti gli aspetti del funzionamento proprio e dell’ufficio di Segreteria,
con particolare attenzione ai tempi e alle modalità di convocazione delle riunioni […], alla verbalizzazione delle attività del Comitato, alle procedure di decadenza o per le dimissioni dei componenti […]”.
Successivamente con il D.Lgs. del 24 giugno 2003, n. 211 (“Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”), all’art. 6, comma 7, si annunciava la prossima pubblicazione di un Decreto Ministeriale che avrebbe “[…] aggiornato […] i requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei CE per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”.
Dopo circa tre anni è stato pubblicato il D.M. 12 maggio 2006(“Requisiti minimi per l’istituzione e il funzionamento dei CE per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”), il quale, oltre a ristrutturare i CE,ha ribadito, all’art. 4, comma 2, l’obbligo di “dotarsi” di “un ufficio di segreteria tecnico-scientifica qualificata”.
Su cosa debba intendersi per ufficio di Segreteria “qualificata” vi sono ancora numerose perplessità, ma su tale argomento si ritornerà successivamente in questo lavoro.
In particolare, il predetto articolo sottolinea l’esigenza di dotare detta Segreteria delle “necessarie infrastrutture per assicurare il collegamento all’Osservatorio, per l’inserimento nelle banche dati nazionale ed europea dei dati di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 211 del 2003 […]”.
La trasmissione delle informazioni tra CE, Autorità Competenti (d’ora in poi “AC”) ed Osservatorio Nazionale per le Sperimentazioni Cliniche (d’ora in poi OsSC), costituisce un adempimento importante ai fini del monitoraggio dell’attività sperimentale nel nostro Paese. Infatti, il D.Lgs. 200/2007, all’art. 5, comma 3, afferma che “parte integrante dei compiti dei CE” è proprio la trasmissione delle informazioni ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che deve avvenire senza “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Inoltre, alla luce del già citato D.M. CTA, la Segreteria svolge molte delle attività previste dal D.M. 15 luglio 1997 (“Recepimento delle Norme di Buona Pratica Clinica”). Con specifico riferimento al D.M. CTA, particolarmente ampio (113 pagine) e complesso, deve evidenziarsi che esso è nato dalla rielaborazione effettuata dall’Agenzia italiana del Farmaco (d’ora in poi AIFA) delle linee guida dell’Unione Europea 1, secondo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 9 del D.Lgs. 211/032
.
Le finalità di questo decreto sono numerose e spaziano dall’intento di omogeneizzare i regolamenti dei CE a quello di armonizzare l’istruttoria delle Segreterie degli stessi; dal proposito di fornire una guida a supporto del processo di preparazione della Clinical Trial Application – CTA (Promotori/CRO) alla volontà di assicurare una maggiore aderenzapratica ai dettami del D.Lgs. n. 211 per la valutazione delle domande, in particolare per ciò che concerne la tempistica, finora ampiamente disattesa. Il nuovo D.M. consta di un “articolato” costituito da una sezione denominata “basi legali”, da un “GLOSSARIO”, da due Allegati (“Guida per la richiesta di autorizzazione all’Autorità Competente” e “Guida per la richiesta di parere al CE”) e da ben quindici “APPENDICI”. La “Comunicazione di parere sugli emendamenti sostanziali”, che idealmente può essere considerata la sedicesima APPENDICE, è stata pubblicata sul sito dell’OsSC nel settembre 2008. Inoltre, col passare dei mesi sono state apportate nuove modifiche a quest’ultimo, dettate proprio dalle esigenze operative prospettate dal D.M. CTA; sicché è prevedibile che il numero delle “APPENDICI” virtuali del succitato D.M. sarà ulteriormente incrementato. In sintesi, il D.M. CTA indica ad oggi il modello ed i contenuti dalle domande da presentare ai CE ed all’AC per tutti i medicinali sperimentali che sono regolamentati dal D.Lgs. 211/03, ossia: i prodotti di sintesi chimica; i prodotti biotecnologici; i prodotti di terapia cellulare; i prodotti di terapia genica; i plasma-derivati; gli altri prodotti estrattivi; i prodotti medicinali immunologici (quali: vaccini, allergeni, sieri immuni); i prodotti a base di erbe medicinali; i radiofarmaci ed i prodotti omeopatici.
Maggiori Informazioni
| Autore | Buccelli C; Cannovo N.; Dionisi C. |
|---|---|
| Editore | Piccin Editore |
| Anno | 2011 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Capitolo primo I PROTAGONISTI DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA IN ITALIA 1.1 Autorità competenti, Comitato Etico e Case Farmaceutiche . . . . . . . . . . 1 Capitolo secondo LE PROCEDURE OPERATIVE 2.1 L’Osservatorio Nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali . 5 2.2 L’istituzione/modifica di un CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3 I ruoli della Segreteria tecnico-scientifica di un CE. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.3.1 La composizione della Segreteria tecnico-scientifica . . . . . . . . . . . 11 2.4 La richiesta di autorizzazione della sperimentazione. . . . . . . . . . . . . . . 13 2.4.1 Lista di controllo del dossier CTA form. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.4.2 Informazioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.4.3 Informazioni concernenti i soggetti in sperimentazione. . . . . . . . 16 2.4.4 Informazioni relative al protocollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.4.5 Informazioni relative all’IMP e PeIMP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.4.6 Informazioni relative a struttura e personale . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.4.7 Informazioni relative alle questioni finanziarie . . . . . . . . . . . . . . . 21 Capitolo terzo LA DOMANDA PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI AD USO UMANO 3.1 La CTA form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.1.1 Parte riservata all’Autorità competente ed al CE . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2 Richiesta di Parere Unico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.3 Aggiornamento/modifica dei dati inseriti in OsSC. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.4 L’Osservatorio del futuro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Capitolo quarto RICHIESTA DI PARERI PER EMENDAMENTI 4.1 Gli emendamenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Capitolo quinto LE SPERIMENTAZIONI NO PROFIT 5.1 Le problematiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5.2 L’attività di comunicazione negli studi no profit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5.3 Tipologia di sperimentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 5.4 Requisiti per una sperimentazione no profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 5.5 Cenni sull’autorizzazione alla produzione dei farmaci in ambiente ospedaliero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Capitolo sesto SPERIMENTAZIONI PARTICOLARI 6.1 Studi osservazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6.1.1 La classificazione degli studi non interventistici . . . . . . . . . . . . . . 47 6.1.2 Procedure operative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6.1.3 Il Registro degli Studi osservazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6.2 Studi di Fase I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6.2.1 Farmaci costituiti da prodotti per sintesi chimica o per estrazione. 55 6.3 Studi cellulari e di terapia genica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 6.3.1 Farmaci costituiti da prodotti biologici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 6.4 Studi con integratori alimentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6.5 Biobanche e studi su tessuti umani in vitro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 6.6 Sperimentazioni cliniche e dispositivi medici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6.7 Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica. . 73 6.8 Studi con medicinali omeopatici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Capitolo settimo LINEE GUIDA PER IL RISPETTO DELLA PRIVACY NELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DI MEDICINALI 7.1 La tutela della privacy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 7.2 Studi di farmaco-genetica/genomica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Capitolo ottavo PROCEDURE OPERATIVE SUCCESSIVE ALLA DOMANDA 8.1 La comunicazione dei pareri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 8.2 Il monitoraggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 8.2.1 Apertura del singolo Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 8.2.2 Chiusura del singolo Centro e della sperimentazione in toto. . . 101 8.2.3 Chiusura o interruzione definitiva di una sperimentazione da parte dell’Autorità competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 8.2.4 Chiusura o interruzione definitiva di una sperimentazione da parte del CE competente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 8.2.5 Sospensione temporanea di una sperimentazione . . . . . . . . . . . . 103 8.3 Relazione sulla sperimentazione clinica e follow up . . . . . . . . . . . . . . . 103 8.4 Verbalizzazione ed archiviazione della documentazione. . . . . . . . . . . 104 8.5 Consultazione ed analisi dei dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 8.6 Comunicazione tra utenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 8.7 Le ispezioni AIFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Capitolo nono LA FARMACOVIGILANZA 9.1 Reazioni ed eventi avversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 9.2 Vigilanza sui dispositivi medici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Capitolo decimo LA COPERTURA ASSICURATIVA NELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 10.1 La copertura assicurativa come sinonimo di eticità di una ricerca clinica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 10.2 La normativa italiana in tema di copertura assicurativa per le sperimentazioni cliniche anteriori al 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 10.3 Il D.M. 14 luglio 2009: una svolta nel campo assicurativo . . . . . . . . . 124 Capitolo undicesimo SPUNTI SUI CONTRATTI DI SPERIMENTAZIONE E DI AFFIDAMENTO E SULLA RESPONSABILITÀ DEL CE 11.1 Il contratto di sperimentazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 11.2 Il contratto di affidamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 11.3 Cenni sulla responsabilità dei Comitati Etici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Glossario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Fonti normative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Allegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Allegato 1. Procedure Operative Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Allegato 2. Dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi . . . . . . . . . . . 177 Allegato 3. Informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Allegato 4. Dichiarazione sulla natura osservazionale della sperimentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Allegato 5. Modello standard di certificato assicurativo ex DM 14 luglio 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Indice analitico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 |
Questo libro è anche in:
