Arboricoltura Generale [Sansavini - Patron Editore]
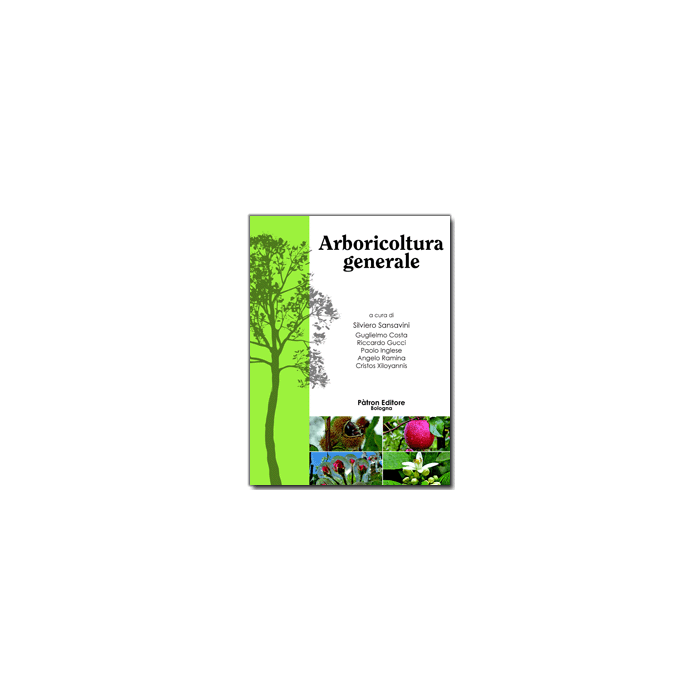
- ISBN/EAN
- 9788855531894
- Editore
- Pàtron
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2012
- Edizione
- 1
- Pagine
- 534
Disponibile
49,50 €
55,00 €
Questo volume di Arboricoltura Generale è rivolto prevalentemente agli studenti che seguono i corsi di laurea universitari nel settore dell’arboricoltura da frutto (inclusi vite, agrumi ed olivo) e contiene numerosi riferimenti ed esempi riguardanti gli alberi ornamentali, forestali e di ambiente urbano
L’opera è diretta principalmente alle lauree triennali di 1° livello; ma il contenuto programmatico è arricchito da specifici approfondimenti sia nel testo che sotto forma di “quadri”, che sono di fatto delle anticipazioni utilizzabili anche per le successive lauree magistrali di 2° livello o per i corsi di Master. L’ampiezza della trattazione e la multidirezionalità degli argomenti obbligheranno il docente della disciplina a indirizzare lo studente verso un approccio didattico personale, necessariamente legato al solo programma oggettivamente svolto.
L’arboricoltura generale, infatti, viene sviluppata ormai, in forza dei numerosi corsi esistenti nelle varie università, con ampiezza e finalità alquanto differenziate, caso per caso. Scopo di quest’opera non è solo quello di spiegare ad un tempo i meccanismi e la comprensione dei vari fenomeni che contraddistinguono i processi di crescita, sviluppo, fruttificazione, propagazione delle piante arboree, ma anche quello di dare un’aggiornata e articolata illustrazione delle tecniche operative di governo e gestione dell’albero e del suolo, nel corso della vita economico-produttiva degli impianti arborei. È stato, dunque, impostato un lavoro collegiale, rispettando la specifica competenza degli oltre 44 autori, pur avendo ben presente il rischio di eterogeneità di stili e di trattazione degli argomenti svolti, nonostante il lungo lavoro preparatorio e il clima collaborativo instaurato fra i numerosi autori. Il contenuto dei sedici capitoli è stato suddiviso in due parti, la prima, quella propedeutica generale, che tratta delle basi teoriche e concettuali dell’arboricoltura e la seconda, applicativa, dove lo studente si troverà a suo agio nella lettura della disamina e illustrazione delle operazioni tecniche, gestionali, agronomiche fra loro interdipendenti inerenti gli impianti arborei, di cui viene offerta ampia descrizione di come vanno eseguite. Il perché è spiegato prima, nella parte generale. Si va dalla progettazione dell’arboreto all’utilizzo di tutte le più avanzate tecnologie agronomiche e di campo, inclusa l’introduzione di strumenti e servizi di rete disponibili nelle varie zone di coltivazione.
L’opera si conclude con un ampio capitolo dedicato alla multifunzionalità dell’arboricoltura, che prelude appunto alle tematiche dell’arboricoltura speciale e che affronta le nuove possibili sfide che, grazie agli alberi, gli agro-ecosistemi e la nostra società sono chiamati urgentemente ad affrontare e cioè gli alberi non più visti solo come fabbrica agroalimentare qual è la produzione di frutti, ma anche per gli utilizzi alternativi, non alimentari.
Maggiori Informazioni
| Autore | Sansavini Silviero; Costa Guglielmo; Gucci Riccardo; Inglese Paolo; Ramina Angelo; Xiloyannis Cristos |
|---|---|
| Editore | Pàtron |
| Anno | 2012 |
| Tipologia | Libro |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Capitolo 1 Struttura dell’albero .................................. 23 1.1. Introduzione .................................................... 23 1.2. Apparato radicale ............................................ 23 1.2.1. Funzioni delle radici ................................ 23 1.2.2. Morfologia dell’apparato radicale ........... 24 1.2.3. Anatomia delle radici .............................. 25 1.2.4. Classificazione delle radici ...................... 27 1.2.5. Distribuzione delle radici nel terreno ...... 28 1.2.6. Accrescimento radicale ........................... 28 Q. 1.1. Apparati radicali in ambiente urbano .............. 30 1.2.7. Sistema radicale e tecnica colturale ......... 33 1.3. Strutture epigee ............................................... 35 1.3.1. Chioma .................................................... 35 Q. 1.2. La rizosfera e l’associazione con altri organismi36 1.3.2. Struttura scheletrica (tronco e branche) ... 38 1.3.3. Foglie ...................................................... 40 Q. 1.3. La differenziazione a fiore delle gemme ......... 42 1.3.4. Gemme .................................................... 42 1.3.5. Germogli e Rami ..................................... 45 1.3.6. Fiore e infiorescenze ............................... 47 1.3.7. Frutto e seme ........................................... 50 Letture consigliate ............................................. 52 Capitolo 2 Segnali endogeni ed ambientali che regolano lo sviluppo dell’albero ................ 53 2.1. Introduzione .................................................... 53 2.2. Segnali endogeni ............................................. 54 2.2.1. Ormoni .................................................... 54 Q. 2.1. Trasporto polare delle auxine ......................... 58 2.2.2. Regolatori di crescita ............................... 59 2.2.3. Altri segnali endogeni (zuccheri, nutrienti, segnali elettrici) ............................................. 60 2.2.4. Meccanismo di azione dei segnali endogeni ........................................................ 60 2.3. Segnali esogeni ............................................... 61 2.3.1. Gravità ..................................................... 61 Q. 2.2. Meccanismo di azione degli ormoni ............... 62 2.3.2. Temperatura ............................................ 64 Q. 2.3. I segnali chimico-elettrici degli apici radicali . 65 2.3.3. Luce ......................................................... 68 2.4. I bioregolatori e il quadro ormonale della pianta71 Letture consigliate ............................................. 72 Capitolo 3 Funzionalità dell’albero ............................. 73 3.1. Relazioni luminose.......................................... 73 3.1.1. Aspetti fisici della radiazione .................. 73 3.1.2. La foglia è un filtro luminoso .................. 74 3.1.3. Influenza dell’ambiente luminoso sulle caratteristiche delle foglie, dei frutti e della chioma ..... 75 3.1.4. Risposte spettrali ..................................... 77 3.1.5. Controllo luminoso degli scambi gassosi 78 3.1.6. Fotoinibizione, foto-ossidazione, danni da eccesso di luce ............................................... 78 3.1.7. Interazione chioma/luce ........................... 79 3.1.8. Fisiologia delle risposte alla luce e produttività degli alberi: uno sguardo al futuro prossimo .......... 80 3.2. Assimilazione del carbonio ............................. 81 3.2.1. Fotosintesi fogliare .................................. 81 3.2.2. Risposta fotosintetica a fattori ambientali 82 3.2.3. Regolazione fotosintetica da fattori endogeni ......... 85 Q. 3.1. La fotosintesi è esclusiva delle foglie? ............ 86 3.2.4. Fotosintesi e produttività nelle colture perenni da frutto ............................................ 86 3.3. Ripartizione, trasporto ed utilizzazione dei carboidrati non strutturali .................................. 87 3.3.1. Ripartizione del carbonio fotosintetico e sintesi dei carboidrati ....... 88 3.3.2. Trasporto ed utilizzazione dei carboidrati 90 3.3.3. Ruolo dei carboidrati solubili .................. 92 3.3.4. Carboidrati con funzioni di riserva .......... 92 3.3.5. Dinamica dei carboidrati nella pianta ed indice di raccolta ............................................ 93 3.4. Nutrizione minerale ........................................ 94 3.4.1. Disponibilità dei nutrienti ........................ 94 3.4.2. Assorbimento radicale ............................. 95 Q. 3.2. Assorbimento degli elementi nutritivi da parte dei tessuti epigei.......................................................... 95 3.4.3. Trasporto e ciclo dei nutrienti interno all’albero ........................................................ 98 3.4.4. Funzioni dei principali nutrienti e risposte dell’albero .................................................... 100 Q. 3.3. La rizosfera ................................................... 102 3.5. Fisiologia degli stress .................................... 103 3.5.1. Carenza idrica ........................................ 103 3.5.2. Asfissia radicale ..................................... 107 3.5.3. Stress termici ......................................... 108 3.5.4. Salinità ................................................... 109 3.5.5. Inquinanti atmosferici ............................ 110 3.6. Altre funzioni biochimiche fogliari ............... 111 3.6.1. Riduzione dei nitrati e sintesi degli amminoacidi ................................................ 111 3.6.2. Sintesi dei fenoli e terpenoidi ................ 113 Q. 3.4. Alcaloidi, fenoli e terpenoidi ........................ 115 Letture consigliate ........................................... 116 Riferimenti per figure e tabelle ....................... 116 Capitolo 4 Il Ciclo vitale, architettura dell’albero e funzioni correlate ..................................... 117 4.1. Il ciclo ontogenetico dell’albero ................... 117 4.2. L’architettura dell’albero .............................. 119 4.2.1. I modelli architettonici nelle specie frutticole ...................................................... 120 4.2.2. Ideotipo architettonico dell’albero da frutto121 4.3. Funzioni correlate ......................................... 123 4.3.1. Rapporti tra organi dello stesso tipo ...... 123 Q. 4.1. Determinismo della dominanza apicale (DA)123 Q. 4.2. Rapporti chioma-radice (C/R)....................... 124 4.3.2. Rapporti tra organi diversi ..................... 126 4.4. Regolazione dell’attività vegetativa dell’albero127 Letture consigliate ........................................... 128 Capitolo 5 Ciclo ontogenetico dell’albero ................. 129 5.1. Dalla germinazione del seme all’acquisizione della maturità fisiologica ................................. 129 5.1.1. Germinazione del seme e sviluppo dei semenzali ..................................................... 129 5.1.2. Fase giovanile dei semenzali e acquisizione della maturità fisiologica ........ 132 5.1.3. Fase vegetativa giovanile ...................... 132 5.1.4. La fase vegetativa adulta ....................... 135 Q. 5.1. Aspetti genetici e molecolari della transizione di fase ....................................................................... 136 5.1.5. Fase riproduttiva adulta ......................... 136 5.2. Fioritura, sporogenesi, impollinazione e fecondazione ................................................... 136 5.2.1. La transizione di fase nelle specie decidue e sempreverdi .............................................. 136 5.2.2. Sviluppo degli organi fiorali.................. 137 Q. 5.2. I geni omeotici che controllano la differenziazione del fiore .......................................... 139 5.2.3. Microsporogenesi e produzione del polline141 5.2.4. Macrosporogenesi e formazione della cellula uovo ................................................. 141 5.2.5. Impollinazione, germinazione del polline e crescita del tubetto pollinico ....................... 142 Q. 5.3. Interazioni polline-stigma ............................. 144 5.2.6. Meccanismi che ostacolano l’autogamia 145 Q. 5.4. Il locus S nelle Rosacee ................................ 148 Q. 5.5. Combinazioni degli S-alleli per conoscere le consociazioni varietali interfertili ............................. 153 5.2.7. Partenocarpia, stenospermocarpia, apomissia, xenia e metaxenia ...................... 154 5.3. Sviluppo del seme e del frutto....................... 156 5.3.1. Sviluppo dell’endosperma, embriogenesi e maturazione del seme .................................. 156 5.3.2. Allegagione e cascola fisiologica .......... 159 5.3.3. Sviluppo del frutto ................................. 159 Q. 5.6. Basi fisiologiche e molecolari della cascola dei frutticini .................................................................... 160 5.3.4. Controllo ormonale dello sviluppo del frutto ............................................................ 163 5.3.5. Interazione tra sviluppo del seme e del frutto ............................................................ 165 5.3.6. Processi metabolici nel corso della crescita e dello sviluppo dei frutti ............................. 165 5.4. Maturazione .................................................. 167 5.4.1. Il processo .............................................. 167 5.4.2. Fisiologia della maturazione e regolazione ormonale nei frutti climaterici e non climaterici .................................................... 169 5.4.3. Processi che caratterizzano la sindrome di maturazione ................................................. 170 Q. 5.7. Verso un modello unico di maturazione ....... 172 Q. 5.8. Gli allergeni nelle specie fruttifere ................ 175 5.4.4. Indici di maturazione e di raccolta, distruttivi e non distruttivi ........................... 176 5.5. Qualità e postraccolta .................................... 180 5.5.1. Qualità e maturazione di raccolta .......... 180 5.5.2. Conservazione e mantenimento della qualità .......................................................... 183 Letture consigliate ........................................... 186 Capitolo 6 Il miglioramento genetico nelle piante arboree: fondamenti e applicazioni ......... 187 6.1. Il miglioramento genetico delle piante arboree187 6.2. Obiettivi dei programmi di miglioramento genetico ........................................................... 189 6.3. Programmi di miglioramento genetico ed utilizzazione del germoplasma arboreo ........... 190 6.3.1. Aspetti generali ...................................... 190 6.3.2. La conoscenza delle basi morfo-genetiche191 Q. 6.1. Selezione di ideotipi arborei adatti alle finalità degli impianti ............................................................ 191 6.3.3. La variabilità genetica intraspecifica: la cultivar ed il clone ....................................... 193 Q. 6.2. Conservazione del germoplasma................... 194 Q. 6.3. Modalità di incrocio, trattamento dei semi e allevamento dei semenzali ........................................ 198 6.3.4. Le modificazioni epigenetiche ............... 201 Q. 6.4. Il reincrocio nelle piante da frutto ................. 202 6.4. Metodi di miglioramento genetico ................ 202 6.4.1. La mutagenesi ........................................ 202 6.4.2. Incrocio e selezione ............................... 204 Q. 6.5. Procedure per la selezione: l’esempio dei fruttiferi ..................................................................... 206 6.4.3. La selezione dei semenzali: il modello dei fruttiferi ....................................................... 207 6.6. Tutela giuridica europea (UE) ...................... 208 6.5. Diffusione del nuovo materiale genetico ...... 208 6.5.1. La tutela giuridica delle nuove varietà di fruttiferi ....................................................... 208 6.5.2. Le strategie di promozione commerciale delle cultivar ................................................ 209 Letture consigliate ........................................... 209 Capitolo 7 Biotecnologie di supporto a breeding e propagazione............................................. 211 7.1. Genetica molecolare applicata al miglioramento genetico ........................................................... 211 7.1.1. Marcatori molecolari e mappe genetiche212 7.1.2. Mappe fisiche e sequenziamento ........... 213 Q. 7.1. Uso dei marcatori molecolari nella caratterizzazione del germoplasma ........................... 214 7.1.3. Mappatura di geni, clonaggio e sequenziamento: esempio del gene Vf ........ 215 7.1.4. La selezione assistita da marcatori (MAS)216 7.1.5. La selezione assistita dalla conoscenza dei genomi (GS) ................................................ 217 7.1.6. Strumenti molecolari per studi di biologia e fisiologia (System Biology) ...................... 217 7.2. La trasformazione genetica e le sue potenzialità218 7.2.1. La tecnica di trasformazione ................. 219 7.2.2. Principali risultati per le piante da frutto 221 Q. 7.2. Trasformare una pianta ................................. 225 Q. 7.3. Costrutto genico ............................................ 226 7.2.3. La normativa sulla sperimentazione delle piante geneticamente modificate ................. 226 7.2.4. Accettabilità e interesse per piante da frutto GM per la nostra agricoltura .............. 227 7.3. Altri approcci biotecnologici al miglioramento genetico di specie da frutto ............................. 227 7.3.1. Variabilità somaclonale e selezione in vitro227 7.3.2. Colture di protoplasti e ibridazione somatica ...................................................... 228 7.3.3. Colture di aploidi e doppi aploidi .......... 229 7.4. Prospettive .................................................... 230 Letture consigliate ........................................... 230 Capitolo 8 Metodi di propagazione ........................... 231 8.1. Propagazione gamica .................................... 231 8.1.1. Cenni sulla morfologia e struttura del seme231 8.1.2. Aspetti generali della propagazione gamica232 8.1.3. Dormienza dei semi ............................... 233 8.1.4. Aspetti tecnici della propagazione gamica233 8.2. Propagazione agamica .................................. 234 8.2.1. Propagazione per talea .......................... 235 8.2.2. Aspetti anatomici .................................. 236 8.2.3. Aspetti fisiologici .................................. 237 8.2.4. Aspetti genetico-molecolari .................. 239 8.2.5. Aspetti tecnici ........................................ 240 8.2.6. Tecniche di propagazione per talea ....... 241 8.3. Propagazione in vitro .................................... 245 8.3.1. Micropropagazione ................................ 245 8.3.2. Fasi della micropropagazione ................ 245 8.3.3. Embriocoltura ........................................ 248 8.3.4. Organogenesi ......................................... 248 8.3.5. Embriogenesi somatica .......................... 248 8.3.6. Seme artificiale ...................................... 249 8.4. Innesto ........................................................... 250 8.4.1. Le basi dell’innesto ................................ 250 Q. 8.1. Sintomatologia della disaffinità di innesto .... 252 8.4.2. Le operazioni di innesto ........................ 254 Q. 8.2. Cause della disaffinità ................................... 256 8.4.3. Cure dopo l’innesto ............................... 261 8.5. Altri metodi di propagazione agamica .......... 262 8.5.1. Pollone radicato ..................................... 262 8.5.2. Margottaggio ......................................... 262 Letture consigliate ........................................... 265 Capitolo 9 Vivaismo .................................................... 267 9.1. Aspetti agronomici e normativi del vivaismo delle specie decidue ........................................ 268 9.1.1. Piante da frutto ...................................... 268 Q. 9.1. Legislazione europea e conformità della produzione vivaistica ................................................ 270 Q. 9.2. Innovazioni tecniche nel vivaismo: i “cicli brevi” nel pesco ........................................................ 272 9.2. Aspetti specialistici ....................................... 274 Q. 9.3. La micorrizazione delle piante in vivaio ....... 275 Q. 9.4. I substrati nel vivaismo ................................. 276 9.3. Specie sempreverdi ....................................... 278 9.2.1. Agrumi ................................................... 278 9.2.2. Olivo ...................................................... 279 Q. 9.5. Impiego di bioregolatori in vivaio................. 281 Letture consigliate ........................................... 282 Capitolo 10 Vocazionalità ambientale ......................... 283 10.1. Vocazionalità ambientale, areale di coltivazione e scelta varietale ......................... 283 10.2. Clima e singoli elementi climatici .............. 284 10.2.1. Temperatura ......................................... 286 10.2.2. Precipitazioni ....................................... 290 10.2.3. Vento ................................................... 291 10.2.4. Classificazione del clima ..................... 291 Q. 10.1. Agrometeorologia e colture arboree ............ 294 10.3. Suolo e valutazione dell’adattabilità delle terre alla coltivazione .............................................. 295 10.4. Classificazione territoriale e cartografia tematica ........................................................... 296 10.5. Variabilità ambientale e climatica come risorsa nella valorizzazione delle produzioni tipiche .............................................................. 298 Q. 10.2. Denominazioni di origine e zonazione ........ 302 10.6. Cambiamenti climatici e impatto sulle colture arboree ............................................................ 302 Letture consigliate ........................................... 306 Capitolo 11 Progettazione e impianto del frutteto ..... 307 11.1. Progetto dell’arboreto ................................. 307 11.1.1. Introduzione ........................................ 307 11.1.2. Criteri generali per la scelta della specie, della varietà, del portinnesto e del modello di impianto ........... 308 11.1.3. La valutazione delle risorse ambientali disponibili .................................................... 310 11.1.4. La sindrome della stanchezza del suolo da reimpianto ................................................... 312 11.2. Sistemazioni idrauliche e operazioni preimpianto .......................................................... 313 11.2.1. La lavorazione del suolo ..................... 315 11.2.2. Le analisi del suolo, la concimazione di fondo e gli ammendanti ............................... 316 11.3. Il disegno e l’impianto dell’arboreto ........... 316 11.3.1. Criteri di scelta per la disposizione delle piante in campo: orientamento dei filari, sesti e distanze di piantagione ................................ 316 11.3.2. Evoluzione dei sistemi di allevamento ad alta densità ................................................... 318 11.3.3. La messa a dimora delle piante ........... 321 11.3.4. Preparazione delle piante per l’impianto322 11.3.5. I sostegni e le coperture: materiali, funzioni e tecniche ...................................... 323 11.3.6. I frangiventi, tipologia, funzione e dislocazione ................................................. 323 11.3.7. Il ruolo dell’avifauna: sistemi di promozione e difesa .................................... 325 11.3.8. Protezione delle radici e del tronco dalle arvicole e dai roditori e della pianta dalle scottature ..................................................... 326 11.4. Frutticoltura protetta ................................... 327 11.4.1. Principi e scopi delle coperture ........... 327 11.4.2. Strutture e materiali utilizzati .............. 328 11.4.3. Specie utilizzate e cicli produttivi ....... 328 11.4.4. Le reti antigrandine e ombreggianti .... 329 Letture consigliate ........................................... 331 Capitolo 12 Impianti e forme di allevamento, potatura, controllo della fruttificazione e raccolta 333 PARTE GENERALE: Principi teorici dell’allevamento e risposte fisiologiche della potatura ....................................................... 333 12.1. Evoluzione degli impianti arborei da frutto 333 12.2. Definizione e obiettivi della potatura .......... 334 12.3. Architettura dell’albero ............................... 335 12.4. Operazioni di potatura ................................. 336 12.4.1. Taglio ................................................... 336 Q. 12.1. Operazioni di potatura “al verde” ............... 338 Q. 12.2. Altre operazioni complementari di potatura 342 12.5. Forme d’allevamento .................................. 342 12.5.1. Forme di allevamento in base all’architettura .............................................. 342 12.5.1. Forme di allevamento in base alla tecnica di potatura .................................................... 343 Q. 12.3. Piegatura e curvatura di rami e branche ...... 345 12.6. Disegno del frutteto e sistemi d’impianto: densità e distanze ............................................ 346 12.6.1. Forme in volume per densità medio basse350 12.6.2. Forme per densità medio-alte .............. 351 12.6.3. Forme obbligate per altissime densità . 357 12.6.4. Forme “transitorie”, convertibili, per impianti a media densità .............................. 358 12.7. Potatura di produzione ................................ 359 12.8. Potatura verde ed epoche di taglio .............. 362 12.9. Potatura meccanica ..................................... 363 12.10. Potatura radicale........................................ 364 PARTE SPECIALE: Allevamento e potatura delle singole specie .............................................. 365 12.11. Melo .......................................................... 365 12.12. Pero ........................................................... 370 12.13. Pesco ......................................................... 372 12.13.1. Forme di allevamento ........................ 374 12.13.2. Potatura di produzione ....................... 379 12.14. Forme di allevamento e potatura della vite 380 12.14.1. Sistemi tradizionali ............................ 380 12.14.2. Sistemi innovativi .............................. 383 12.14.3. Considerazioni sui sistemi tradizionali e su quelli innovativi ...................................... 386 12.15. Olivo ......................................................... 387 12.15.1. Forme tradizionali.............................. 387 12.15.2. Sistemi ad alta densità (superintensivi) a siepe ............................................................. 389 12.15.3. Criteri di scelta della potatura e delle forme di allevamento ................................... 390 12.16. I sistemi di allevamento degli agrumi ....... 391 12.16.1. Assetto tradizionale ........................... 392 12.16.2. Assetto attuale ................................... 392 12.17. Mezzi di controllo della carica produttiva 393 12.18. Raccolta dei frutti ...................................... 396 Letture consigliate ........................................... 398 Capitolo 13 L’acqua e gli apporti irrigui .................... 399 13.1. Assorbimento radicale e movimento dell’acqua all’interno della pianta ................... 399 13.2. Regolazione stomatica della traspirazione .. 401 13.3. Criteri di scelta e di gestione del metodo irriguo .............................................................. 403 13.3.1. Metodi irrigui ...................................... 407 Q. 13.1. Assorbimento e trasporto radiale dell’acqua nelle radici: le vie apoplastica e protoplastica .......... 408 13.3.2. Gestione del metodo irriguo ................ 410 Q. 13.2. Calcolo del volume di suolo interessato dall’irrigazione e della relativa quantità di acqua immagazzinabile .... 414 13.3.3. Irrigazione in condizioni di scarsa disponibilità idrica ....................................... 414 13.4. Architettura della chioma ed efficienza dell’uso dell’acqua .......................................... 417 13.5. Irrigazione e qualità della produzione ......... 417 13.6. Irrigazione ed impatto ambientale ............... 419 13.6.1. Utilizzo di acque non convenzionali ... 420 13.7. Irrigazione e difesa dagli abbassamenti termici421 13.8. Manutenzione degli impianti irrigui ........... 422 13.8.1. I trattamenti fisici ................................ 422 13.8.2. I trattamenti chimici ............................ 423 Letture consigliate ........................................... 423 Capitolo 14 La fertilizzazione nell’arboreto ............... 425 14.1. Introduzione ed esigenze nutrizionali ......... 425 14.2. Criteri di calcolo della dose di fertilizzante e guida alla restituzione dei nutrienti ................. 427 14.3. Diagnosi dello stato nutrizionale dell’albero 429 14.3.1. Basi fisiologiche e scopi della diagnostica fogliare ........................................................ 429 14.3.2. Il campionamento ................................ 429 Q. 14.1. Sintomi di carenze e di eccessi nutrizionali 430 14.3.3. L’interpretazione dei risultati .............. 431 14.3.4. Altre tecniche diagnostiche ................. 432 14.4. Sintomatologie di carenze ed eccessi nutrizionali ...................................................... 433 14.5. Tecniche di distribuzione dei fertilizzanti ... 434 14.5.1. La concimazione pre-impianto ............ 434 14.5.2. La fertilizzazione nei frutteti non irrigui434 14.5.3. La fertirrigazione ................................. 435 Q. 14.2. Aspetti tecnici della fertirrigazione e calcolo della dose di fertilizzante .......................................... 436 14.5.4. La concimazione epigea ...................... 438 Q. 14.3. Fisiopatie nutrizionali del frutto.................. 439 Q. 14.4. La clorosi ferrica ......................................... 440 14.5.5. La fertilizzazione nelle aziende condotte in modo “organico-biologico” ..................... 442 Letture consigliate ........................................... 443 Capitolo 15 Gestione del suolo...................................... 445 15.1. Il sistema suolo ........................................... 445 15.2. Proprietà fisiche e chimiche del suolo: tessitura, reazione, capacità di scambio cationico, carbonati totali e attivi, salinità, potenziale redox446 15.3. Correzione delle anomalie chimico-fisiche . 452 15.4. La sostanza organica: funzioni agronomiche e ambientali ........................................................ 453 15.5. Biomassa microbica ed enzimi del suolo: motore della fertilità ........................................ 456 15.6. Elementi totali ed assimilabilità .................. 457 15.7. Inquinanti inorganici e organici .................. 458 15.8. Interazione pianta-suolo-atmosfera ............. 461 15.9. Principi ecologici della gestione del suolo: le tecniche per favorire l’accumulo di carbonio nei suoli agricoli.................................................... 462 15.9.1. La non lavorazione o la lavorazione minima ......................................................... 462 15.9.2. Il bilancio del carbonio ........................ 466 15.9.3. Le lavorazioni di fondo e di mantenimento .............................................. 466 15.9.4. L'inerbimento naturale: vantaggi e svantaggi ...................................................... 472 15.9.5. L'inerbimento permanente controllato: scelta delle essenze, epoca di semina, mantenimento del prato, effetti agronomici . 474 15.9.6. La pacciamatura ................................... 478 15.9.7. Il diserbo chimico ................................ 480 15.10. Campionamento del suolo ......................... 481 Letture consigliate ........................................... 483 Capitolo 16 Arboricoltura multifunzionale................. 485 16.1. Multifunzionalità dei sistemi arborei .......... 485 16.1.1. Obiettivi produttivi primari e prodotti secondari o aggiuntivi: definizioni e scopi .. 485 16.1.2. Prodotti e benefici dei sistemi colturali arborei .......................................................... 487 Q. 16.1. Il Paesaggio tradizionale dell’arboricoltura promiscua (da Morettini, 1950) ................................ 490 Q. 16.2. Life Cycle Assessment ed Ecological Footprint Analysis: nuovi strumenti per valutare la sostenibilità e la multifunzionalità dell’arboricoltura da frutto .... 493 16.1.3. Arboricoltura multifunzionale in ambienti urbani e marginali ........................................ 494 Q. 16.3. Arboricoltura multifunzionale e tutela delle risorse genetiche da frutto ......................................... 496 16.2. Arboricoltura ornamentale e urbana ........... 499 16.2.1. Introduzione all’arboricoltura urbana .. 499 Q. 16.4. Certificazioni di qualità per la valorizzazione integrata di territorio e produzioni ............................ 499 16.2.2. I ruoli e benefici del verde urbano ....... 500 16.2.3. Alberi e ambiente urbano .................... 501 16.2.4. Selezione del materiale per l’impianto in aree urbane .................................................. 502 16.2.5. Il sito d’impianto e le tecniche di messa a dimora ......................................................... 504 16.2.6. Gestione del verde urbano ................... 506 16.3. Arboricoltura da legno e biomasse energetiche507 16.3.1. Definizione e scopi .............................. 507 Q. 16.5. Forme classiche di allevamento nell’arboricoltura ornamentale .................................. 508 Q. 16.6. Prodotti ritraibili dall’arboricoltura da legno510 16.3.2. Progettazione e realizzazione delle piantagioni ................................................... 510 Q. 16.7. Cicli del C e dell’N negli impianti di arboricoltura da legno ............................................... 511 16.3.3. Gestione delle piantagioni da legno di qualità .......................................................... 512 Q. 16.8. Caratteristiche morfologiche e biometriche del materiale d’impianto ................................................. 513 16.3.4. Pioppicoltura ........................................ 515 16.3.5. Cedui a ciclo breve per la produzione di biomassa ...................................................... 517 Letture consigliate ........................................... 518 Glossario .................................................... 519 Bibliografia ................................................ 526 Indice analitico .......................................... 527 |
Questo libro è anche in:
