18 Referendari Corte dei Conti - Manuale di Contabilità Pubblica - Scienza delle Finanze - Diritto Finanziario
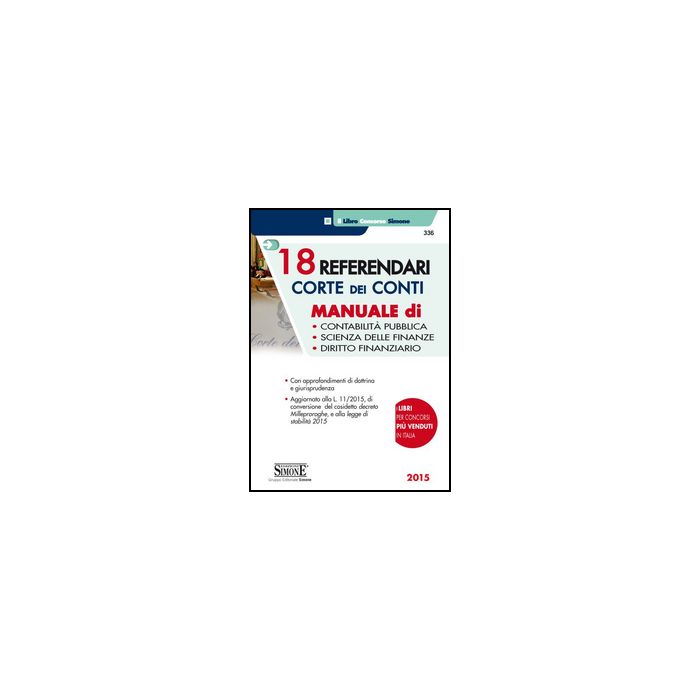
- ISBN/EAN
- 9788891406064
- Editore
- Edizioni Giuridiche Simone
- Collana
- Il libro concorso
- Formato
- Brossura
- Anno
- 2015
- Pagine
- 607
Disponibile
42,00 €
Il testo è diretto ai candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 18 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della corte dei conti (in g. U. , iv serie speciale, del 30 dicembre 2014, n. 101). Tra le materie oggetto delle prove scritte, che gli aspiranti magistrati contabili dovranno affrontare, sono previste: la contabilità pubblica, la scienza delle finanze e il diritto finanziario. Il volume tratta le suddette discipline alla luce delle modifiche normative che recentemente le hanno interessate, tra cui segnaliamo: la legge 27 febbraio 2015, n. 11 (di conversione del dl. 192/2014, cosiddetto decreto milleproroghe); la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata); il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi); la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge delrio).
Maggiori Informazioni
| Autore | AA.VV. |
|---|---|
| Editore | Edizioni Giuridiche Simone |
| Anno | 2015 |
| Tipologia | Libro |
| Collana | Il libro concorso |
| Lingua | Italiano |
| Indice | Libro I Contabilità pubblica Capitolo 1 - Le fonti 1. Definizione e natura della contabilità pubblica 2. Le fonti 3. Segue: La Costituzione e in particolare l’articolo 81 A) L’articolo 81 e il vincolo del pareggio del bilancio dello Stato B) La modifica degli articoli 97, 117 e 119 4. Segue: Le fonti positive A) Le grandi riforme della contabilità pubblica dal 1978 al 1999 B) La legge 31 dicembre 2009, n. 196, la nuova legge di contabilità pubblica C) La legge 24 dicembre 2012, n. 243, attuativa del principio del pareggio di bilancio Capitolo 2 - L’apparato economico-finanziario 1. L’amministrazione finanziaria 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze 3. I dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze A) Il Dipartimento del Tesoro B) Il Dipartimento delle Finanze C) Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (DRGS) D) Il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi 4. Le agenzie fiscali 5. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 6. La Cassa Depositi e Prestiti 7. Altri soggetti della contabilità pubblica A) Le amministrazioni e le aziende autonome B) Gli enti non territoriali C) Gli enti territoriali e le amministrazioni locali Capitolo 3 - Profili generali dei bilanci dello Stato 1. Il bilancio dello Stato in generale A) Definizione B) Funzioni del bilancio C) Anno finanziario ed esercizio finanziario 2. Tipi di bilancio A) Bilancio economico, bilancio finanziario e bilancio patrimoniale B) Bilancio preventivo e consuntivo 3. Bilancio di cassa e di competenza 4. Il bilancio dello Stato italiano 5. Principi del bilancio Capitolo 4 - La decisione di bilancio 1. Il ciclo del bilancio e il principio della programmazione 2. I rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica: il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma A) Il Patto di stabilità e di crescita B) Il PSC e il PNR C) Il calendario e le regole di bilancio comuni per gli Stati membri della zona euro 3. Il Documento di economia e finanza 4. Segue: La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 5. La manovra di finanza pubblica 6. Segue: La legge di stabilità A) La legislazione precedente: la legge finanziaria B) La legge di stabilità 7. Segue: Il bilancio annuale di previsione 8. Segue: La contabilità economica e il budget dello Stato A) Il budget: strumento di programmazione e controllo delle attività B) Il sistema di contabilità economica analitica delle pubbliche amministrazioni C) Il budget dello Stato 9. Segue: Il bilancio pluriennale 10. Segue: La formazione e l’approvazione del bilancio A) La formazione del bilancio B) La procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di stabilità e del bilancio e la loro approvazione C) Effetti giuridici del bilancio 11. Segue: I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica 12. La copertura finanziaria delle leggi A) I mezzi di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi B) La copertura degli oneri connessi a deleghe legislative C) Le modalità e i termini per la predisposizione delle relazioni tecniche D) Le clausole di salvaguardia E) Il monitoraggio sull’attuazione delle leggi recanti oneri finanziari F) Gli oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni e degli enti pubblici 13. L’esercizio provvisorio 14. Assestamento e variazioni di bilancio A) Variazione delle entrate B) Variazioni di spesa: il bilancio di assestamento Capitolo 5 - La struttura del bilancio 1. Classificazione delle entrate e delle spese A) La classificazione delle voci in entrata B) La classificazione delle voci di spesa 2. Fondi di bilancio A) I fondi di riserva B) Fondi speciali 3. Le leggi di spesa pluriennali e a carattere permanente 4. Le gestioni fuori bilancio 5. I residui A) Nozione B) La gestione dei residui Capitolo 6 - L’esecuzione del bilancio 1. Le entrate e il loro regime giuridico 2. Le spese e il loro regime giuridico 3. Il controllo sui titoli di spesa (rinvio) 4. Il fermo amministrativo 5. Compensazione e adempimento parziale Capitolo 7 - La gestione di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria 2. La tesoreria centrale A) Le operazioni di tesoreria B) Le operazioni finanziarie 3. Le tesorerie provinciali 4. La tesoreria unica A) La tesoreria mista: il D.Lgs. 279/1997 B) Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dal D.Lgs. 279/1997 Capitolo 8 - Il rendiconto generale dello Stato 1. Funzioni del rendiconto 2. Il contenuto e la struttura A) Il conto del bilancio B) Il conto generale del patrimonio 3. La formazione 4. La parificazione 5. L’esame e l’approvazione Capitolo 9 - I rendiconti speciali: i conti amministrativi e i conti giudiziali 1. Premessa 2. I conti amministrativi A) Tipologia dei conti amministrativi 3. I conti giudiziali 4. I conti degli agenti della riscossione 5. I conti degli agenti consegnatari di materiale 6. I conti dei tesorieri 7. La cauzione Capitolo 10 - L’ordinamento contabile degli enti locali Introduzione Sezione Prima L’ordinamento contabile previgente 1. Fonti normative A) Il D.Lgs. 77/1995 B) Il Testo Unico enti locali C) L’armonizzazione dei bilanci degli enti locali ai conti pubblici D) Il pareggio di bilancio 2. L’ambito di applicazione e la potestà regolamentare 3. Principi, caratteristiche, struttura del bilancio A) Principi B) Caratteristiche C) Struttura 4. Il piano esecutivo di gestione (PEG) 5. Predisposizione e approvazione del bilancio A) Approvazione B) Esercizio provvisorio 6. Gli allegati al bilancio di previsione annuale A) La relazione previsionale e programmatica B) Il bilancio pluriennale C) Altri allegati 7. La gestione del bilancio A) Le fasi dell’entrata: l’accertamento, la riscossione, il versamento B) Le fasi della spesa: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione, il pagamento 8. I risultati della gestione A) Il rendiconto della gestione B) Il conto del bilancio C) Il conto economico D) Il conto del patrimonio 9. Il dissesto e il riequilibrio Sezione Seconda Il nuovo ordinamento contabile:la fase di sperimentazione e l’entrata in vigore 1. L’attuazione della riforma: il D.Lgs. 118/2011 2. Le regole contabili uniformi: principi contabili generali e applicati A) I principi contabili generali B) I principi contabili applicati 3. Il piano dei conti integrato 4. Gli schemi di bilancio comuni 5. I principali documenti di programmazione A) Il Documento unico di programmazione (DUP) B) Il bilancio di previsione finanziario C) Il piano esecutivo di gestione 6. La gestione del bilancio A) L’entrata B) La spesa 7. Il rendiconto della gestione A) Il conto del bilancio B) Il conto economico C) Lo stato patrimoniale 8. Il bilancio consolidato 9. La fase di sperimentazione Capitolo 11 - L’ordinamento contabile delle Regioni Introduzione Sezione Prima L’ordinamento contabile previgente 1. Le fonti normative 2. Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio A) Il bilancio pluriennale B) Il bilancio annuale 3. La presentazione del bilancio, l’esercizio provvisorio, variazioni e assestamento del bilancio A) Presentazione del bilancio B) L’esercizio provvisorio C) Variazioni D) Assestamento E) Gli impegni di spesa e il pagamento delle spese 4. Classificazione delle entrate e delle spese 5. Il rendiconto 6. L’autonomia contabile delle Regioni a Statuto speciale A) Generalità B) Sicilia C) Sardegna D) Trentino-Alto Adige E) Valle D’Aosta F) Friuli-Venezia Giulia 7. Il rendiconto delle Regioni a Statuto speciale Sezione Seconda Il nuovo ordinamento contabile 1. Premessa 2. Il sistema contabile 3. Il ciclo della programmazione 4. I principali documenti di programmazione A) Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) B) La legge di stabilità regionale C) Il bilancio di previsione finanziario 5. Il rendiconto della gestione 6. Il bilancio consolidato 7. L’applicabilità del nuovo ordinamento contabile alle Regioni a Statuto speciale Capitolo 12 - L’ordinamento contabile di Università, A USL e Camere di commercio 1. L’ordinamento contabile delle Università 2. L’ordinamento contabile delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) 3. L’ordinamento contabile delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) Capitolo 13 - Gli enti pubblici istituzionali 1. Introduzione 2. Pianificazione, programmazione e budget A) La relazione programmatica B) Il bilancio pluriennale 3. I documenti previsionali A) Il bilancio di previsione B) Il preventivo finanziario C) Il preventivo economico D) La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione E) I fondi di riserva F) Il budget del centro di responsabilità di primo livello 4. Classificazione delle entrate e delle spese 5. Assestamento, variazioni e storni del bilancio 6. Il rendiconto generale 7. I bilanci in forma abbreviata 8. La gestione di tesoreria e la gestione patrimoniale A) La gestione di tesoreria B) La gestione patrimoniale 9. Le scritture contabili Capitolo 14 - I beni della P.A 1. Premessa A) Concetto e qualifica di bene pubblico B) I soggetti titolari di patrimoni pubblici 2. Categorie di beni pubblici 3. I beni demaniali A) Il demanio necessario B) Il demanio accidentale 4. Segue: Il demanio regionale, provinciale, comunale e il federalismo demaniale A) Il demanio regionale B) Il demanio provinciale e comunale C) Il federalismo demaniale 5. Segue: Il regime giuridico dei beni demaniali 6. Segue: Acquisto e perdita della demanialità 7. I beni patrimoniali 8. I beni patrimoniali indisponibili 9. Il regime giuridico dei beni patrimoniali indisponibili 10. Utilizzazione dei beni pubblici 11. La tutela dei beni pubblici 12. I beni patrimoniali disponibili 13. I diritti reali della P.A. su beni altrui 14. L’amministrazione dei beni pubblici 15. Gli inventari 16. La valutazione dei beni pubblici 17. La valorizzazione, la dismissione e l’alienazione dei beni pubblici Capitolo 15 - I servizi pubblici 1. Funzioni pubbliche e pubblici servizi 2. I principi regolatori dei servizi pubblici A) Il quadro costituzionale di riferimento B) I servizi pubblici nell’ordinamento dell’Unione europea 3. L’organizzazione dei servizi pubblici: dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore 4. La gestione dei servizi pubblici locali A) Profili introduttivi B) L’articolo 113 D.Lgs. 267/2000 5. Dall’art. 23bis D.L. 112/2008 al referendum di giugno 2011: ancora cambiamenti per i servizi pubblici locali 6. La successiva evoluzione legislativa: il D.L. 138/2011 A) Profili introduttivi B) La dimensione territoriale dell’organizzazione del servizio: l’art. 3bis D.L. 138/2011 7. La regolamentazione dei servizi pubblici locali nell’art. 4 D.L. 138/2011 e la sua illegittimità costituzionale A) L’art. 4 D.L. 38/2011 B) L’intervento della Consulta: la sentenza n. 199/2012 8. Il ruolo del D.L. 179/2012 nella disciplina dei servizi pubblici locali A) L’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nell’art. 34 D.L. 179 B) Le modifiche al D.L. 138/2011: il comma 1bis dell’art. 3bis 9. L’affidamento diretto dei servizi pubblici locali: l’in house providing A) Generalità B) In particolare, il requisito del controllo analogo C) Segue: Il requisito dell’attività prevalente D) La disciplina nazionale dell’in house 10. Le norme in materia di giurisdizione Capitolo 16 - L’attività negoziale della P.A.: i contratti pubblici 1. La privatizzazione del diritto delle amministrazioni pubbliche: dal provvedimento al contratto 2. Classificazione dei contratti della P.A. 3. I contratti pubblici tra direttive comunitarie e disciplina nazionale. Prospettive di riforma A) Dalle direttive del 2004 al Codice dei contratti pubblici B) Il diritto nazionale dei contratti pubblici C) Le Direttive europee del 2014 4. Il Codice dei contratti pubblici A) I principi B) Ambito di applicazione del Codice: soggettivo ed oggettivo 5. Il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici A) Profili generali B) La tutela dei lavoratori in materia di contratti pubblici 6. Il procedimento di formazione del contratto: l’evidenza pubblica A) Profili generali 7. Dalla deliberazione a contrarre alla lex specialis 8. Soggetti partecipanti e presentazione dell’offerta A) I partecipanti alla gara B) I requisiti di partecipazione C) L’istituto dell’avvalimento D) L’offerta 9. La scelta del contraente: procedure e criteri 10. L’asta elettronica 11. Aspetti procedurali della gara: dalla valutazione delle offerte all’aggiudicazione A) L’apertura delle buste contenenti le offerte B) L’aggiudicazione della gara 12. La conclusione del contratto 13. L’approvazione del contratto 14. Le cauzioni nel sistema dei contratti pubblici 15. Profili applicativi del vincolo contrattuale. Esecuzione e recesso A) Dell’esecuzione del contratto B) Il recesso della P.A. 16. I servizi in economia (la piccola evidenza) 17. La tutela A) Tutela stragiudiziale B) Segue: L’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale C) La tutela giurisdizionale 18. L’Autorità nazionale anticorruzione e il ruolo del Presidente nella lotta alla corruzione negli appalti pubblici 19. I principali contratti atipici stipulabili dalla P.A. 20. «Acquisti» centralizzati e autonomia contrattuale della P.A. A) La normativa del 2012 B) La normativa del 2014 Capitolo 17- Il sistema dei controlli 1. I controlli in generale A) Caratteri generali B) Tipi di controllo C) I controlli nella Costituzione 2. I controlli del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 3. Monitoraggio e controllo dei conti pubblici 4. L’analisi e la valutazione della spesa 5. I controlli interni di gestione 6. Segue: La riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile: il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 A) I principi del controllo amministrativo-contabile B) Gli organi di controllo 7. Segue: Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali A) Il controllo preventivo B) Il controllo successivo C) La Relazione annuale sull’esito del controllo 8. Segue: I controlli dei collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti e organismi pubblici 9. Segue: Le verifiche sulla regolarità amministrativa e contabile 10. I controlli nelle Regioni e negli enti locali A) Disposizioni relative alle Regioni B) Disposizioni relative agli enti locali 11. Il controllo esterno: La Corte dei conti A) L’articolazione B) Le attribuzioni 12. Segue: Il controllo preventivo di legittimità sugli atti di Governo 13. Segue: Il controllo successivo sulla gestione 14. Segue: Il controllo sulle Regioni e sugli enti locali A) Il controllo della Corte dei conti sulle Regioni B) Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali 15. Segue: Il controllo sugli enti sovvenzionati 16. Il sistema dei controlli negli enti pubblici istituzionali A) Il sistema di controllo interno B) Il controllo del collegio dei revisori dei conti C) Il controllo di gestione 17. L’attività di referto della Corte dei conti 18. I poteri della Corte costituzionale Capitolo 18 - Le responsabilità nel pubblico impiego 1. La definizione di responsabilità. In particolare la responsabilità del pubblico dipendente 2. La responsabilità patrimoniale 3. La responsabilità amministrativa per danno erariale 4. Segue: I presupposti della responsabilità amministrativa 5. Una peculiare ipotesi di danno erariale: il danno all’immagine della P.A 6. La responsabilità contabile A) La gestione contabile e l’obbligo di rendiconto B) L’elemento soggettivo della responsabilità: l’agente contabile 7. Differenze tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile 8. La responsabilità civile verso i terzi 9. La responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti delle Regioni e degli altri enti pubblici (rinvio) 10. La responsabilità degli amministratori degli enti locali (rinvio) Capitolo 19 - La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica Sezione Prima La Corte dei conti quale giudice contabile 1. Oggetto e scopo di una funzione giurisdizionale contabile 2. I caratteri della giurisdizione contabile A) Profili generali B) Il giudizio contabile come giudizio ad impulso dello Stato: il ruolo della Procura 3. Gli organi della giurisdizione contabile A) Il sistema organizzativo della giustizia contabile B) La competenza delle sezioni giurisdizionali regionali 4. Segue: Il peculiare ruolo delle sezioni riunite e la funzione di nomofilachia della Corte 5. I soggetti passivi della giurisdizione contabile: i dipendenti pubblici Sezione Seconda Tipologie di giudizi innanzi alla Corte dei conti 1. I giudizi di conto 2. I giudizi di responsabilità A) Le regole dell’azione di responsabilità amministrativa B) Profili processuali del giudizio di responsabilità amministrativa C) Segue: il potere riduttivo del giudice contabile 3. La giurisdizione nei confronti degli amministratori e dipendenti delle Regioni e degli enti locali 4. Il giudizio pensionistico A) Lineamenti di giurisdizione pensionistica B) Aspetti processuali del contenzioso pensionistico 5. I giudizi ad istanza di parte 6. Il sistema delle impugnazioni esperibili avverso le sentenze della Corte dei conti 7. L’esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti Libro II Scienza delle finanze e Diritto finanziario Parte I Scienza delle finanze Capitolo 1 - Introduzione allo studio della scienza delle finanze 1. L’oggetto di studio della scienza delle finanze 2. La scienza delle finanze e il diritto finanziario 3. Le principali teorie sulla natura dell’intervento pubblico (rinvio) Capitolo 2 - Le teorie volontaristiche 1. Introduzione 2. Emil Sax e i bisogni collettivi 3. Lo «scambio volontario» di De Viti De Marco 4. Lo schema di Wicksell: il problema del free rider 5. Le critiche al modello volontaristico Capitolo 3 - Gli approcci politico-sociologici 1. Introduzione 2. Wagner e la crescita del settore pubblico 3. Il conflitto governanti-governati 4. Puviani e l’illusione finanziaria 5. La scuola marxista Capitolo 4 - La scuola delle scelte pubbliche 1. Il campo di indagine 2. Il teorema dell’impossibilità di Arrow 3. Il principio dell’unanimità di Wicksell 4. La votazione a maggioranza A) Il paradosso del voto B) Il teorema dell’elettore mediano 5. Lo scambio dei voti (logrolling) 6. Rappresentanza democratica: i politici, i burocrati e i gruppi di pressione Capitolo 5 - Keynes e la finanza congiunturale 1. La finanza del reddito nazionale 2. Il pensiero keynesiano A) La moneta B) Il ripudio della legge di Say C) La rigidità dei salari 3. Il compito dello Stato in Keynes 4. L’attività della pubblica amministrazione e il moltiplicatore 5. Il finanziamento della spesa pubblica mediante imposte 6. Il teorema di Haavelmo 7. Le politiche di stabilizzazione 8. La programmazione economica Capitolo 6 - I limiti delle politiche fiscali 1. Premessa 2. Le critiche allo stop and go 3. I limiti degli stabilizzatori automatici 4. Il crowding out o spiazzamento 5. La critica monetarista 6. La curva di Phillips Capitolo 7 - L’economia del benessere 1. Introduzione 2. L’ottimo paretiano 3. Efficienza e benessere 4. I teoremi dell’economia del benessere Capitolo 8 - La redistribuzione del reddito: le funzioni del benessere sociale 1. La distribuzione del reddito 2. Le unità di osservazione: l’individuo e la famiglia 3. La misura della disuguaglianza: curva di Lorenz e indice di Gini 4. Concetto di povertà 5. Teorie sulla redistribuzione del reddito: utilitarismo A) Funzioni del benessere sociale B) Criterio del maximin 6. Incidenza della spesa pubblica sulla distribuzione del reddito 7. La «nuova economia del benessere» A) Pigou B) La compensazione potenziale Capitolo 9 - Il fallimento del mercato 1. Introduzione 2. L’assenza di un mercato di libera concorrenza 3. L’esistenza di rendimenti crescenti 4. Le esternalità A) Definizione B) Regolamentazione delle esternalità C) L’imposta pigouviana D) Teorema di Coase 5. I beni pubblici 6. La carenza e l’asimmetria di informazioni 7. I merit goods o beni meritori 8. Le vicende del paretianesimo: il «marginal cost pricing» 9. Il second best Capitolo 10 - Gli obiettivi e gli strumenti dell’intervento pubblico nell’economia 1. Il trade-off tra efficienza ed equità 2. I soggetti della finanza pubblica 3. Gli strumenti dell’intervento pubblico nell’economia (rinvio) 4. Le caratteristiche dell’intervento pubblico nell’economia 5. Il bilancio dello Stato (rinvio) Capitolo 11 - L’analisi benefici-costi 1. Introduzione 2. L’analisi benefici-costi ABC A) Il metodo del valore attuale B) Il metodo del valore attuale relativo C) Il metodo del tasso di rendimento interno 3. Gli effetti dei progetti pubblici 4. I prezzi ombra 5. Il tasso sociale di sconto 6. Beni non scambiabili sui mercati 7. Considerazioni conclusive Capitolo 12 - Le entrate pubbliche 1. Distinzioni in materia di entrate pubbliche 2. I beni pubblici (rinvio) 3. Le imprese pubbliche A) Definizione e caratteristiche B) Cause della nascita delle imprese pubbliche C) Forme di esercizio dell’impresa pubblica 4. Le entrate tributarie 5. Le entrate straordinarie A) Definizione B) Alienazione di beni patrimoniali C) Tesoro di guerra D) Contribuzioni straordinarie 6. Segue: l’emissione di carta moneta 7. Segue: il debito pubblico A) Definizione B) Modalità e tecniche di emissione C) Classificazione e forme dei prestiti pubblici 8. Segue: Modalità di estinzione del debito pubblico A) L’ammortamento B) La conversione 9. Il finanziamento della spesa A) La monetizzazione del disavanzo B) La scelta fra debito pubblico ed imposta Capitolo 13 - I tributi 1. Il sistema impositivo A) I tributi B) I singoli tributi 2. Le imposte A) Presupposto ed elementi dell’imposta B) Classificazione delle imposte C) Progressività delle imposte D) Deduzioni, detrazioni e «tax expenditures» 3. Le tasse A) Classificazione 4. I contributi 5. I monopoli fiscali 6. Eccesso di pressione tributaria e tassazione ottimale Capitolo 14 - La teoria dell’incidenza delle imposte 1. L’incidenza delle imposte 2. La valutazione economica delle imposte 3. Traslazione, ammortamento, diffusione delle imposte A) La traslazione delle imposte B) L’ammortamento delle imposte C) La diffusione delle imposte 4. Traslazione delle imposte sul reddito d’impresa nelle diverse forme di mercato A) Traslazione in regime di concorrenza perfetta B) Traslazione in regime di monopolio C) Traslazione nei regimi di mercato intermedi 5. Altri effetti microeconomici delle imposte: evasione, erosione, elisione ed elusione A) L’evasione B) L’erosione C) L’elisione D) L’elusione Capitolo 15 - Le teorie sui criteri distributivi delle imposte 1. Nozioni generali sui principi distributivi del carico tributario A) La giusta distribuzione del carico tributario B) Il principio del beneficio C) Principio della capacità contributiva 2. Il sistema tributario A) L’imposta unica e l’illusione finanziaria B) Imposizione diretta e indiretta 3. Segue: La pressione tributaria: il teorema di Barone e la curva di Laffer A) La pressione tributaria B) Il teorema di Barone C) La curva di Laffer 4. Determinazione della capacità contributiva: il concetto di reddito A) Le definizioni di reddito imponibile B) Il reddito-prodotto C) Il reddito-entrata D) Il reddito-consumo e il problema della doppia tassazione del risparmio E) Discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi Capitolo 16 - L’attività statale decentrata: il federalismo fiscale 1. Principi del federalismo fiscale 2. I modelli economici sul decentramento fiscale A) Il modello di Tiebout B) Il teorema del decentramento di Oates C) La teoria dei club di Buchanan 3. Funzioni e livelli di governo 4. I trasferimenti intergovernativi 5. L’effetto della carta moschicida 6. Decentramento amministrativo e federalismo fiscale in Italia A) La Costituzione B) L’attuazione del federalismo fiscale: la L. 42/2009 C) I limiti all’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali: il patto di stabilità interno D) Segue: La L. cost. 1/2012 e il vincolo del pareggio di bilancio Capitolo 17 - Le spese pubbliche 1. Concetto di spesa pubblica A) Definizione, fini, presupposti economici B) Spese pubbliche e spese private C) La spesa pubblica e l’attività di spendita 2. Classificazione delle spese pubbliche 3. Cause dello sviluppo delle spese pubbliche 4. La produttività della spesa pubblica e la finanza della sicurezza sociale 5. L’espansione tendenziale ed il limite delle spese pubbliche 6. La redistribuzione del reddito 7. Modalità della redistribuzione della spesa pubblica Capitolo 18 - I principali settori d’intervento pubblico: la sicurezza sociale 1. La sicurezza sociale A) Previdenza e sicurezza sociale B) Cenni storici C) La sicurezza sociale e la Costituzione 2. Forme di finanziamento della sicurezza sociale 3. Effetti collaterali dovuti all’incidenza dei contributi sociali 4. Il sistema della sicurezza sociale in Italia A) Il sistema pensionistico B) Sistemi pensionistici a capitalizzazione e a ripartizione C) Sistemi retributivi e contributivi D) Prestazioni e regole del sistema pensionistico E) Previdenza integrativa F) Gli ammortizzatori sociali G) Tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali H) L’assegno per il nucleo familiare 5. Segue: I trattamenti assistenziali A) L’assegno sociale per gli ultrasessantacinquenni privi di redditi B) Le prestazioni economiche assistenziali per il nucleo familiare e per la maternità C) Le prestazioni assistenziali agli invalidi civili 6. Il Servizio Sanitario Nazionale Parte II Diritto finanziario Capitolo 1 - Principi giuridici delle imposte 1. La Costituzione: principi in materia tributaria A) La riserva di legge B) Generalità ed uguaglianza del tributo C) Segue: il principio della capacità contributiva D) Il principio della progressività del sistema tributario 2. Le altre fonti del diritto tributario A) La legge B) Decreti legislativi e decreti legge C) Regolamenti, decreti dirigenziali e provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate D) Istruzioni ministeriali E) Fonti comunitarie e internazionali F) Gli usi G) Lo Statuto del contribuente 3. Interpretazione e integrazione delle norme finanziarie 4. Efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio A) Efficacia nel tempo B) Efficacia nel tempo delle norme sanzionatorie C) Efficacia nello spazio 5. La lotta all’elusione e il diritto d’interpello Capitolo 2 - I soggetti del diritto tributario 1. I soggetti attivi della potestà di imposizione 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze A) Il Dipartimento delle finanze B) Le agenzie fiscali 3. L’assistenza fiscale della Pubblica Amministrazione 4. I CAF 5. L’assistenza fiscale prestata dai professionisti: la certificazione tributaria 6. Soggetti passivi. Concetto di soggettività tributaria 7. Il domicilio fiscale 8. Capacità d’agire. La rappresentanza legale 9. La rappresentanza volontaria 10. L’obbligazione solidale e la successione 11. Responsabile d’imposta e sostituto A) Il responsabile d’imposta B) Il sostituto d’imposta Capitolo 3 - I regimi contabili e la dichiarazione Sezione Prima I regimi contabili ai fini delle imposte 1. Generalità 2. I regimi di contabilità ordinaria A) Regime di contabilità ordinaria per le imprese B) Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni 3. I regimi di contabilità semplificata A) Regime di contabilità semplificata per le imprese B) Regime di contabilità semplificata per gli esercenti arti e professioni 4. Il regime forfettario per i contribuenti minimi 5. Il regime dei contribuenti minimi 6. Il regime forfettario per gli enti non commerciali 7. Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo Sezione Seconda La dichiarazione dei redditi 1. La dichiarazione tributaria A) La funzione della dichiarazione B) Uffici competenti per territorio 2. La dichiarazione annuale 3. La dichiarazione unica A) Unificazione delle dichiarazioni tributarie annuali B) Presentazione 4. La dichiarazione delle persone fisiche A) Generalità B) Soggetti esonerati 5. Il modello 730 A) Generalità B) Il 730 precompilato C) Gli adempimenti del sostituto 6. La dichiarazione delle società di persone 7. La dichiarazione delle persone giuridiche 8. La dichiarazione dei sostituti d’imposta A) Generalità B) Obblighi dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale Capitolo 4 - Accertamento e riscossione Sezione Prima L’accertamento 1. L’attività istruttoria A) Anagrafe tributaria e codice fiscale B) Adempimenti volontari dei contribuenti C) La liquidazione e il controllo formale delle dichiarazioni D) Rateizzazione delle somme dovute a seguito della liquidazione automatica e del controllo formale della dichiarazione E) Accessi, ispezioni e verifiche F) Indagini bancarie e finanziarie 2. L’avviso di accertamento 3. Le diverse tipologie di accertamento 4. L’accertamento nei confronti delle persone fisiche A) Accertamento analitico B) Accertamento sintetico C) Il redditometro D) Accertamento d’ufficio E) Accertamento parziale 5. L’accertamento nei confronti di possessori di redditi d’impresa e di lavoro autonomo A) Accertamento analitico B) Accertamento induttivo C) Accertamento d’ufficio D) Accertamento parziale 6. L’accertamento induttivo mediante gli studi di settore 7. L’accertamento con adesione del contribuente A) Generalità B) L’accertamento con adesione «a regime» C) La procedura D) L’adesione ai verbali di constatazione e la definizione degli inviti al contraddittorio Sezione Seconda La riscossione delle imposte sui redditi 1. Le ritenute fiscali A) La ritenuta diretta B) Le ritenute alla fonte 2. I versamenti diretti A) Generalità B) Acconti d’imposta C) Il versamento unitario e la compensazione D) Rateazione E) Modalità di pagamento 3. La riscossione coattiva A) Il ruolo B) Il ricorso del contribuente: la sospensione e la rateazione della riscossione 4. I rimborsi d’imposta Capitolo 5 - Le sanzioni e il contenzioso Sezione Prima Il sistema sanzionatorio tributario 1. Il sistema sanzionatorio amministrativo A) I principi della riforma del sistema sanzionatorio non penale B) Il ravvedimento C) Le sanzioni accessorie 2. La disciplina dei reati tributari A) Le sanzioni penali B) Ulteriori fattispecie criminose C) Pene accessorie D) Circostanze attenuanti ed esimenti E) Rapporti tra sistema penale e sistema amministrativo tributario Sezione Seconda Il contenzioso tributario 1. Le Commissioni tributarie 2. Oggetto della giurisdizione tributaria 3. Il processo tributario A) Lo svolgimento del processo tributario B) Il ricorso C) Il reclamo e la mediazione D) La trattazione e decisione della controversia E) La sospensione, l’interruzione e la prosecuzione del processo F) L’estinzione del processo 4. La sospensione dell’atto impugnato 5. La conciliazione giudiziale 6. Le impugnazioni 7. L’esecuzione delle sentenze 8. Il giudizio di ottemperanza 9. L’autotutela Capitolo 6 - I singoli tributi Sezione prima Le imposte dirette 1. L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 2. Segue: Il reddito complessivo e le singole categorie di reddito A) Il reddito complessivo B) Le singole categorie di reddito C) I redditi fondiari D) I redditi di capitale E) I redditi di lavoro dipendente F) I redditi di lavoro autonomo G) I redditi di impresa H) I redditi diversi 3. Segue: I criteri di applicazione 4. Segue: La liquidazione dell’imposta 5. Segue: Redditi soggetti a tassazione separata 6. Caratteri generali dell’IRES 7. Segue: Le disposizioni comuni a tutti i soggetti d’imposta A) Scomputo degli acconti B) Scomputo delle ritenute C) Riporto o rimborso dell’eccedenza 8. La tassazione dei dividendi Sezione Seconda L’IVA e le altre imposte indirette 1. Generalità e caratteri dell’imposta sul valore aggiunto 2. Presupposti del tributo 3. Soggetti passivi 4. La classificazione delle operazioni ai fini IVA 5. I regimi contabili 6. Base imponibile ed aliquote 7. Meccanismo applicativo dell’IVA 8. Gli obblighi del contribuente A) Le denunce B) Gli adempimenti contabili: tenuta dei registri obbligatori e fatturazione C) Registro degli acquisti D) Registro delle vendite e registro dei corrispettivi E) Liquidazioni e versamenti 9. Le dichiarazioni A) La dichiarazione annuale B) Le comunicazioni dei dati IVA C) Semplificazione delle comunicazioni all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA 10. Versamento di conguaglio e rimborsi A) Il versamento di conguaglio o l’eventuale rimborso dell’eccedenza B) Rimborsi infrannuali 11. I sistemi di controllo 12. L’imposta di registro 13. Le imposte ipotecaria e catastale 14. L’imposta di bollo 15. L’imposta sulle successioni e donazioni Capitolo 7 - Il sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali 1. I decreti attuativi della L. 42/2009 2. La riforma del sistema impositivo delle Regioni: il D.Lgs. 68/2011 3. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 4. L’addizionale regionale all’IRPEF 5. Altre entrate tributarie delle Regioni 6. Le principali entrate tributarie delle Province e delle Città metropolitane 7. La riforma del sistema impositivo dei Comuni: il D.Lgs. 23/2011 8. Le principali entrate tributarie dei Comuni A) L’imposta unica comunale (IUC) B) Segue: L’imposta municipale propria (IMU) C) Segue: Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) D) Segue: La tassa sui rifiuti (TARI) E) L’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni F) L’imposta di scopo per opere pubbliche G) L’imposta di soggiorno e l’imposta di sbarco H) L’addizionale IRPEF I) La compartecipazione IVA L) L’addizionale comunale sui diritti di imbarco M) La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche |
Questo libro è anche in:
- Concorsi e Master
- Concorsi e Master
- Diritto Costituzionale e Amministrativo
- Diritto: guide allo studio e preparazione esami
- Diritto Costituzionale e Amministrativo
- Diritto: guide allo studio e preparazione esami
- Diritto finanziario
- Pubblica amministrazione e settore pubblico
- Diritto finanziario
- Pubblica amministrazione e settore pubblico
